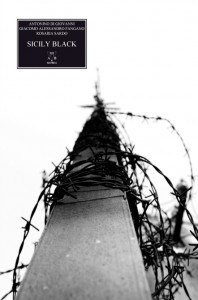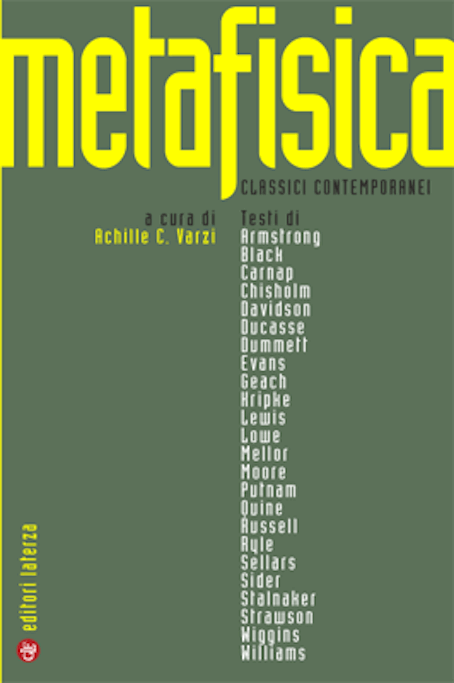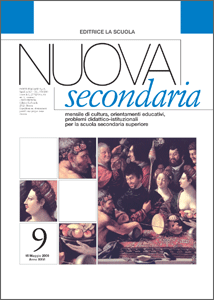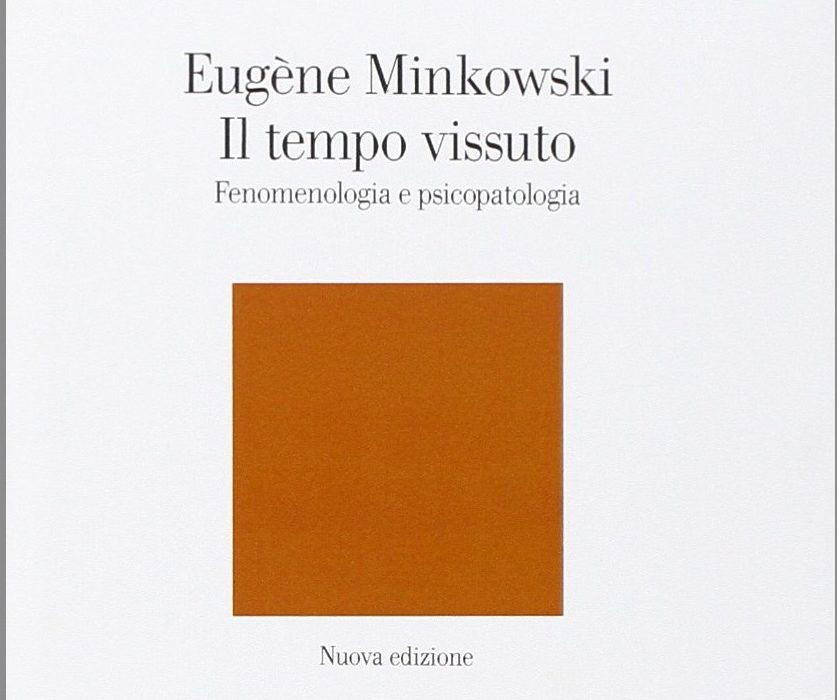
Eugène Minkowski
Il tempo vissuto.
Fenomenologia e psicopatologia
(Le temps vécu. Études phénoménologique et psycopatologiques [1933], 1968)
Trad. di Giuliana Terzian
Revisione e cura del testo di Anna Maria Farcito
Introduzione di Federico Leoni
Prefazione di Enzo Paci
Nuova edizione
Einaudi, Torino 2004
Pagine XXXIX-401
Il tempo/spazio costituisce l’esperienza fondamentale dell’umano e del suo stare al mondo, è «per ognuno di noi il problema più vivo, più personale» (pag. 5). Anche per questo la radice profonda e l’espressione immediata delle psicopatologie non può che coinvolgere la sua percezione e rappresentazione. Il distacco dalla realtà, qualunque forma essa assuma, è un distacco dal fondamento temporale della vita umana.
Il patologico, mostrandoci che il fenomeno del tempo e probabilmente anche quello dello spazio si situano e si organizzano nella coscienza malata diversamente da come lo concepiamo di solito, mette in rilievo caratteri essenziali di questi fenomeni che, proprio a motivo della poca distanza che ci separa da essi nella vita passerebbero inosservati o sarebbero considerati del tutto naturali. (8)
Il disorientamento temporale si accompagna quasi sempre a un disorientamento nello spazio; la malattia psichica è anche una rinuncia alla dimensione fondamentale del futuro, a quello slancio verso l’ha da essere il cui rallentamento e diminuzione produce «ora l’impossibilità di liquidare le situazioni presenti, ora il sentimento di una determinazione ineluttabile a opera del passato» (279). Della complessità esistenziale e psicologica, della sua varietà, si perdono le differenze e rimane l’identità; si dissolve il molteplice a favore dell’uno; si perde il tempo nel dominio dello spazio. Nello spazio, infatti, «noi cerchiamo il simile e l’identico, nel tempo viviamo il nuovo e il dissimile» (314-315).
La schizofrenia è in gran parte il risultato di tale dinamica esclusiva ed escludente, che tende ad arrestare lo slancio della vita interiore in «atti senza domani, atti congelati, atti a corto circuito, atti che non tendono a concludere» (265), tanto da poter dire che lo schizofrenico venga «attirato solo da quello che è spazio, che solo così si senta a suo agio, e che fugga tutto ciò che è divenire e tempo» (262).
Se una caratteristica primaria del tempo è il divenire incessante di questa “massa liquida” (Bergson) che sta ovunque intorno e dentro all’io e che plasma l’«io-qui-adesso» (258) del corpo umano, i processi morbosi consistono anche e proprio nel ridurre tale struttura a una immobilità densa e senza futuro, nella quale i ricordi tendono ad assumere sempre più la figura deformata della persecuzione e di una infinita tristezza. La memoria, infatti, non si limita a registrare l’accaduto ma lo reinventa di continuo. La malattia mentale è una reinvenzione parziale, statica, deformata sino all’allucinazione.
Di contro, gli stati d’equilibrio -sempre fragili- della psiche consistono nel mantenimento della «innata solidarietà spazio-temporale» che è «paragonabile a quella della solidarietà organico-psichica» (22). Ha quindi ragione Heidegger, (del cui libro del 1927 Minkowski afferma comunque di non aver potuto discutere) a definire il tempo come avvenire-essente stato-presentante, «gewesend-gegenwärtigende Zukunft» (Sein und Zeit, § 65, p. 916 dell’edizione Mondadori 2006) e il futuro come «il fenomeno primario della temporalità originaria e autentica» (Ivi, § 65, pp. 925-927).
Secondo Minkowski, infatti, c’è un’asimmetria tra passato e futuro: «l’avvenire vissuto ci è dato incontestabilmente in modo più primitivo del passato. Esso reca con sé nella vita il fattore creatore, di cui il passato sembra essere interamente privo» (39). Ogni raggiungimento apre ad altri obiettivi, ogni luogo dispiega nuovi itinerari, ogni qui è un oltre. Dove ciò non accade il corpo è diventato salma. Perché anche questo è il tempo vissuto, «una riserva eterna e inestinguibile di forze, senza la quale non si potrebbe vivere» (76).
I testi che compongono il libro furono redatti lungo una ventina d’anni e a volte emergono differenze e ripetizioni. Il fondamento è tuttavia sempre chiaro e unitario, radicato com’è nelle tesi bergsoniane e husserliane dei dati immediati della coscienza e delle visioni d’essenze. La prima parte è un Saggio sull’aspetto temporale della vita, la seconda mette alla prova i postulati teorici mediante il confronto con numerosi casi clinici. Il risultato è un testo che offre conferma anche empirica della ricchezza teoretica ed esistenziale della temporalità fenomenologica.