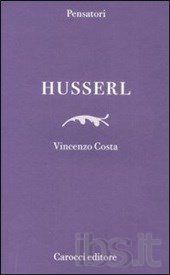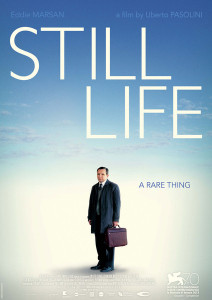Husserl
di Vincenzo Costa
Carocci, 2009
Pagine 232
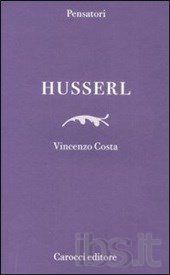 La fenomenologia fu dal suo fondatore sempre concepita e praticata come un metodo, anzi «come il metodo stesso della filosofia», in grado di «abbracciare la totalità dei problemi filosofici» (p. 24).
La fenomenologia fu dal suo fondatore sempre concepita e praticata come un metodo, anzi «come il metodo stesso della filosofia», in grado di «abbracciare la totalità dei problemi filosofici» (p. 24).
Il rifiuto del naturalismo non è soltanto metodologico ma è anche metafisico e consiste nella critica a ogni forma di ingenuo realismo che ritiene di poter cogliere un mondo indipendente dal fenomeno, vale a dire da come la soggettività trascendentale (non quella empirica) costruisce la realtà stessa mentre la percepisce, la valuta, la vive. Il contenuto di qualsiasi percezione può costituire un errore ma il fatto che io veda ciò che vedo non può essere mai un inganno, proprio in quanto è ciò che la mia coscienza sta in questo momento vivendo. Come anche Meinong sostiene, gli enti possono consistere (Bestehen) anche quando il loro correlato fisico ed empirico non esiste: «L’albero che vedo forse non esiste, ma non vi è dubbio che io vedo un albero» (27). Se «posso essere colpito da oggetti che non esistono» questo significa che a costituire il mondo della coscienza, e dunque il mondo, non sono le cause empiriche bensì le motivazioni intenzionali poiché -scrive Husserl- «la relazione reale viene meno quando la cosa non esiste, la relazione intenzionale invece sussiste» (134). La riduzione fenomenologica è quindi il darsi del mondo senza presupporne l’esistenza al di là del suo apparire, della sua radicale fenomenizzazione. Possiamo essere certi dell’immanenza degli enti, del modo in cui ci appaiono, non della loro trascendenza, del mondo in cui sarebbero al di là del loro apparire. È esattamente questo il luogo della certezza filosofica. Esso si chiama intenzionalità ed è fatto della materia sensibile che appare (hyle), del modo in cui appare -come percezione, immaginazione, credenza, calcolo o altro- (noesi), del contenuto di tale apparire in quanto apparire, dell’ente/evento come viene percepito, immaginato, creduto, calcolato (noema).
Materia, noesi e noema sono sempre semantici e temporali; sono «il senso che lega in unità una molteplicità di sensazioni» (46); sono « la forma che essi delineano» (90); sono l’insieme degli enti, degli eventi e dei processi per noi colmi di significato. E tutto questo è possibile perché questo senso e tale forma costituiscono se stesse come strutture temporali, essendo la temporalità «una forma di ordinamento senza della quale niente potrebbe apparire» (51). Non, però, come struttura esterna ed estranea agli enti, agli eventi e ai processi ma come il modo stesso della loro manifestazione, che in fenomenologia equivale al modo stesso del loro costituirsi ed essere.
È anche a motivo di questo nostro percepire il tempo che intesse le cose e le loro relazioni che «noi vediamo costantemente più di quanto ci è dato sensibilmente» (82), poiché ciò che Aristotele e Kant hanno chiamato ‘categorie’ non viene soltanto pensato ma ci è dato intuitivamente attraverso la capacità che il nostro corpomente possiede di collocare ogni singolo ente e ogni evento in un tessuto semantico e temporale che non sta evidentemente nella materia ma abita nel modo in cui essa si costituisce nella coscienza, sta -appunto- nel fenomeno.
Un radicale teleologismo della ragione sta al cuore della rigorosa presentazione che Vincenzo Costa ci offre del filosofo. Dalle Ricerche logiche alla Crisi delle scienze europee e alla mole sterminata di manoscritti, la fede -non c’è altro modo di definirla- di Husserl consiste nella convinzione che «storia non significa semplicemente cambiamento, ma sviluppo guidato da un’idea infinita, orientato verso un telos» (178) che affonda nel Wille zum Leben inteso non come volontà senza senso e senza scopo ma in quanto «nucleo di assoluta razionalità in via di dispiegamento, in corso di manifestazione» (203). Non dunque l’accoglimento dell’umano come finitudine consapevole di se stessa ma come vita di un io trascendentale che -scrive Husserl- «è la vita di un essere finito diretto verso l’infinità» (cit. a p. 206).
Qui la differenza con Heidegger è chiara e fu anche esistenzialmente drammatica nel passaggio dalla formula «la fenomenologia siamo io e Heidegger» (anno 1916) al netto distacco testimoniato da una lettera a Ingarden del dicembre 1929: «Sono giunto alla conclusione che non posso inquadrare l’opera [Sein und Zeit] nell’ambito della mia fenomenologia, e purtroppo, anche dal punto di vista del metodo e addirittura nell’essenziale, dal punto di vista del contenuto (sachlich), la devo rifiutare» (pp. 211 e 213).
E tuttavia -e pur nella differenza- Husserl e Heidegger condivisero sempre e sino in fondo lo sguardo fenomenologico verso enti eventi e processi, pur diversamente declinato. Il logicismo si declina -nei manoscritti che via via vengono pubblicati- anche come metafisica fenomenologica che ha nella soggettività trascendentale e nel richiamo all’esperienza i propri fondamenti, qualcosa di non così dissimile e così lontano dall’analitica esistenziale: «Non si tratta più di comprendere perché appare un mondo, ma che cosa caratterizza la struttura profonda dell’essere, e questa è accessibile appunto interrogando quell’essere che noi stessi siamo. Mentre la metafisica classica (compresa quella di Spinoza e Schopenhauer), almeno agli occhi di Husserl, cercava di accedere alle strutture dell’essere oltrepassando il fenomeno, per Husserl non si tratterà di niente di simile, bensì di scavare all’interno della vita del soggetto per mettere in luce ciò che ha permesso e permette ogni storia e ogni movimento dell’essere. Per accedere alle strutture profonde della realtà e dell’essere bisogna cioè interrogarsi e interrogare quella vita trascendentale che costituisce ogni mondo, che permette al mondo di apparire» (193).
Sarebbe stato davvero possibile per Heidegger soffermarsi così a lungo e così genialmente sul Dasein senza avere dietro e a fondamento il primato della coscienza genetica e del Leib? Il primato di quel corpo isotropo per il quale «lo spazio si organizza a partire da un luogo privilegiato, quello di volta in volta occupato dal mio corpo vivo, cioè dal mio qui […] cioè dal mio corpo vivo che funge da punto centrale o centro dello spazio» (128-129). Il primato di una «vita dell’io» che «precede il suo sapersi» (186) prima ancora che esso diventi consapevole di se stesso (e qui sembra di vedere il proto-Sé di cui parla Antonio Damasio). Il primato di una volontà non intellettualistica ma neppure irrazionale, per il quale «la genesi della volontà, e di ciò che chiamiamo soggetto del volere, coincide in primo luogo con la formazione di un soggetto padrone dei movimenti del proprio corpo vivo» (195-196).
L’essere avrebbe potuto coincidere con il tempo senza la convinzione husserliana [Ms. A V 21/61a] che quanto viene «descritto in termini puramente statici è incomprensibile, e non si sa a questo proposito mai che cosa sia radicalmente significativo e che cosa non lo sia» (192) e che dunque «l’assoluto stesso si dispiega in un processo che è temporale da parte a parte» (199)?
Per entrambi, Husserl e Heidegger, la filosofia si genera dalla differenza tra il dato e il significato. Ontologia e fenomenologia sono due modi radicali di pensare questa differenza. L’ontologia di Heidegger è sempre rimasta radicalmente fenomenologica e la fenomenologia husserliana si è sempre posta nell’orizzonte di un’ontologia genetica. Fu facile profeta di se stesso Edmund Husserl quando nel 1935 scrisse a Ingarden che «le generazioni future mi riscopriranno» (214). Riscoprire Husserl significa infatti scoprire ogni volta la filosofia, il dono di un significato radicale che essa offre alla vita.