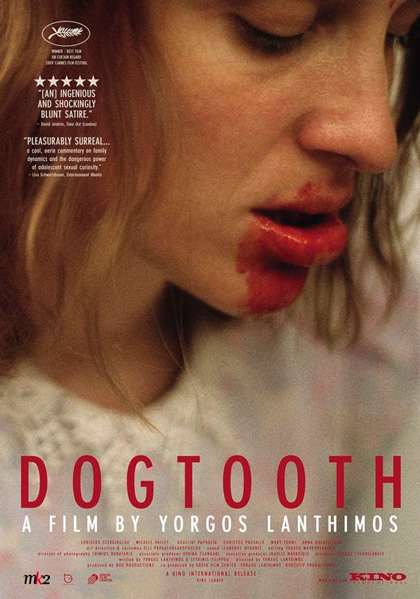L’arbitro
di Paolo Zucca
Con: Stefano Accorsi (Cruciani), Jacopo Cullin (Matzutzi), Benito Urgu (Prospero), Miranda (Geppi Cucciari), Alessio Di Clemente (Brai), Marco Messeri (Candido), Grégoire Oestermann (Jean Michel), Francesco Pannofino (Mureno)
Italia- Argentina, 2013
Trailer del film
 Cruciani è un giovane arbitro, un “fuoriclasse” che aspira legittimamente a dirigere la finale più importante.
Cruciani è un giovane arbitro, un “fuoriclasse” che aspira legittimamente a dirigere la finale più importante.
L’Atletico Pabarile e il Montecrastu sono due squadre sarde di terza categoria dilettanti (sotto non c’è niente), acerrime rivali. L’Atletico, che è diretto da un allenatore cieco, a conclusione del girone di andata si trova a zero punti. Ma in paese torna dall’Argentina Matzutzi, un emigrato che porta la squadra ai vertici sino a contendere il primato al Montecrastu.
La vicenda di Cruciani e quella delle due squadre si incrociano quando l’arbitro viene colto in fragrante. Lui così religioso, e così intransigente sul Regolamento, si è fatto corrompere non per danaro ma per ambizione. Il risultato è che viene degradato a dirigere i tornei di infimo livello. Nella partita decisiva diretta da Cruciani accade davvero di tutto: la tonalità grottesca, che aveva percorso l’intero film, si scatena in un vero e proprio sabba del pallone.
L’epigrafe è di Albert Camus: «Quello che so sulla vita l’ho imparato dal calcio». Il disincanto sul calcio e sulla vita è totale. Non soltanto il calcio viene descritto per quello che probabilmente è ormai diventato: un grande affare nel quale scorrono somme vertiginose e vince chi è più bravo non a giocare ma a corrompere (le vicende della Juventus di Luciano Moggi e i consistenti aiuti arbitrali per portare il Milan in Coppa dei Campioni sono assai recenti e illuminanti); è l’intera vita collettiva a essere permeata di una violenza implacabile contro umani, animali, cose. La tonalità lieve e stravagante di questo film non deve ingannare. Si tratta di una desolata riflessione sull’impossibilità della giustizia. «A quello zoppo, tu spezzagli l’altra gamba». Tutto questo in un bianco e nero elegante e onirico.