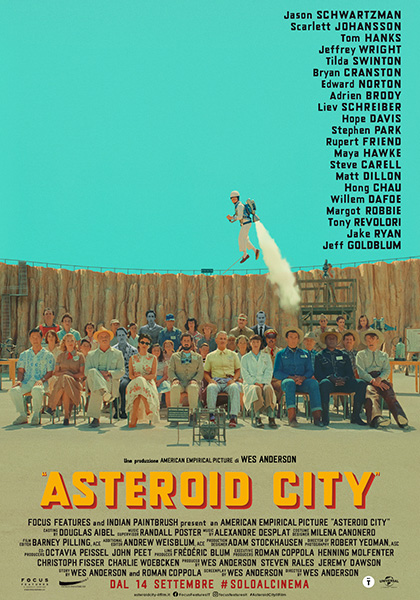Friedrich Dürrenmatt
La Valle del Caos
(Durcheinandertal, 1989)
In «Romanzi e racconti», a cura di Eugenio Bernardi
Traduzione di Giovanna Agabio
Einaudi-Gallimard, 1993
Pagine 587-681
Sfrenata, imprevedibile, feconda, allucinata, implacabile è la fantasia che in questo libro si scatena. Credo di non aver mai letto un testo nel quale a ogni pagina, in qualunque momento, a ogni riga può succedere di tutto come in questo romanzo dove accade veramente qualsiasi cosa. Ne vengono coinvolti, descritti e travolti i contadini di una irraggiungibile vallata svizzera, la Valle del Caos appunto il cui titolo originale potrebbe essere più letteralmente tradotto come valle del guazzabuglio, del disordine, della confusione.
E la confusione regna infatti dappertutto. Confusione tra gli ambienti, che passano dalla costa atlantica degli Stati Uniti d’America – con i suoi gangster più famosi, più gelidi e più rozzi – alle crociere sul Nilo; dalle sedi senza patria delle grandi multinazionali alla Svizzera, «il paese più impenetrabile della terra. Nessuno sa chi è padrone di qualcosa, chi gioca con chi, chi ha le carte in tavola e chi le ha mescolate» (p. 635).
Confusione tra i personaggi, che cambiano volto, alla lettera, attraverso la chirurgia estetica ma anche e specialmente nella sostanza delle loro identità, del loro numero, della loro funzione.
Confusione tra quadri perfettamente falsi venduti come autentici e dipinti autentici spacciati per falsi.
Confusione tra le forze dell’ordine – vigili urbani, polizia, esercito – che dispiegano un enorme apparato di repressione con il solo intento di giustiziare un cane.
Confusione tra la morale e il crimine che appaiono quali sono, vale a dire due aspetti della stessa ferocia, com’è evidente nella Boston Society for Morality che dà vita alla Swiss Society for Morality, entrambe «qualcosa di vago, esattamente come la maggior parte delle associazioni con nobili scopi» (603). Associazioni che edificano in uno sperduto villaggio svizzero una casa di riposo stagionale chiamata Casa della povertà, riservata a gente ricchissima che per alcuni mesi vive in estrema povertà, salvo poi tornare al proprio lusso: «Una vera e propria fissazione di vivere poveramente colse i milionari e le vedove dei milionari, c’erano direttori generali che facevano i letti, banchieri privati che passavano l’aspirapolvere, grossi industriali che apparecchiavano i tavoli in sala da pranzo, manager di prim’ordine che pelavano patate, vedove di multimilionari che cucinavano e si occupavano della lavanderia, sceicchi e magnati del petrolio che falciavano l’erba, sarchiavano, vangavano, segavano, martellavano, piallavano, verniciavano e per questo pagavano prezzi favolosi» (618).
A dare redenzione e conforto a tali milionari è un pastore di nome Moses Melker, uomo di rara bruttezza, «uno schiavo negro fuggiasco grasso e di pelle bianca, con un abito da cresimando e una valigetta in mano» (664), una specie di parente dei neandertaliani e anche assassino seriale delle sue mogli, ma ora dedito alla missione di convertire i ricchi e che per questo elabora una teologia il cui testo fondatore (in fieri) ha per titolo Prezzo della grazia (Preis der Gnade). Melker costruisce una teologia per la quale i poveri sono di per sé meritevoli della salvezza mentre i ricchi devono tutto alla misericordia del «Grande Vecchio» e per questo i ricchi sono i veri destinatari del perdono e della Grazia. E non soltanto i ricchi ma anche gli umani più crudeli, i delinquenti più accaniti, i farabutti, i sadici, i criminali. In loro e soltanto in loro splende la potenza del Signore.
Infatti, se la grazia fosse meritata non sarebbe più grazia bensì ricompensa. La grazia era la cruna dell’ago attraverso la quale non soltanto un cammello, bensì tutti loro potevano passare, loro che erano riuniti lì a lamentarsi della maledizione della ricchezza. Davanti al Grande Vecchio gli ultimi erano i primi e i poveri erano i ricchi, i poveri erano in possesso della grazia e i ricchi maledetti. Ma chi possedeva la grazia non ne aveva bisogno poiché la grazia era già in lui, e quindi la grazia era riservata a loro, i ricchi, i maledetti, i sazi, la grazia con cui venivano incoronati come la sola feccia dell’umanità che ne aveva bisogno (617).
La Grazia essendo del tutto arbitraria, il cuore della teologia di Melker consiste pertanto «nel riconoscimento che nulla potesse giustificare la grazia» (595-596).
Come si vede, si tratta di una teologia anch’essa sfrenata; insieme evangelica e machiavellica, gesuitica e luterana. Teologia di un Dio talmente onnipotente e universale da includere nella propria stessa identità la miseria e il male, un Dio del tutto volontaristico (al modo di Ockham e oltre Ockham), che «avrebbe saputo creare una pietra che non riusciva a sollevare, oppure ritrasformare le cose accadute in non accadute» (590), che poteva fabbricare orologi «con quindici ore, in cui ogni ora durava trecento minuti e ogni minuto quarantacinque secondi, ma anche i secondi non erano uguali; alcuni secondi duravano tre quarti di secondo, altri sette minuti» (608). Un Dio il quale riusciva dunque certamente anche a conciliare la propria essenza di Grazia con quella di «Dio senza barba» vale a dire del più infame tra i malviventi.
Se chiediamo infatti «perché il buon Dio è così ingiusto, se appunto è un buon Dio […] se tutto è così ingiusto con gli uomini e con la natura» (656) è perché «il Grande Vecchio è pensabile solo come criminale» (676), il quale nella sua versione cristiana è «ancora più astratto del padre, ma anche qualcosa di lezioso, un redentore di marzapane sulla croce. […] Un Dio che si lascia crocifiggere fa la commedia» (679).
Un romanzo teologico e grottesco, un romanzo dunque barocco e gaddiano nei contenuti anche se non nella lingua, che è sempre classica e ironicamente perfetta. Il finale è epico; davvero ‘una risata vi estinguerà’ sembra dire il Grande Vecchio alla nostra specie.