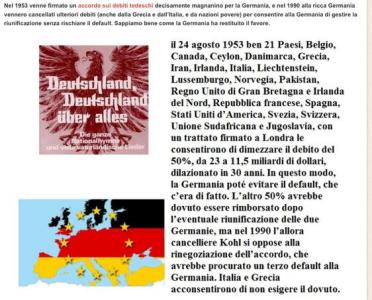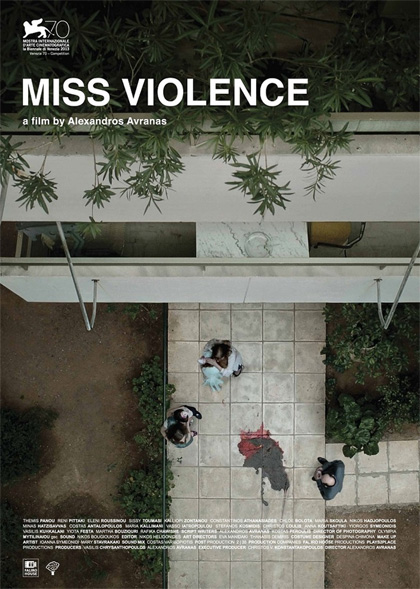Le immagini di Marina Ballo Charmet sono molto lontane da quello che di solito ci si aspetta da fotografie scattate in Grecia. Sono immagini prese dal basso, intuite di lato, che non restituiscono la grandezza della grecità ma il suo non esserci più, le sue tracce, le rovine del quotidiano. E in questo modo, paradossalmente, rimangono molto fedeli a ciò che i Greci sono per noi: assenti.
Si tratta dunque di fotografie del tutto coerenti con il testo del filologo Dino Baldi, il cui percorso tra Oracoli, santuari e altri prodigi (sottotitolo Sopralluoghi in Grecia, Quodlibet Humboldt, Milano 2013, pp. 200) è un itinerario dentro il tempo, la sua permanenza e la sua dissoluzione; un itinerario dentro ciò che non vediamo più ma che ci sembra ancora di vedere. «Un’occasione per fare esperienza diretta della fine delle cose» (p. 12), di tutte le cose, compresa la fine degli dèi, dell’assoluto, del senso. Il segreto della Grecia, uno tra i tanti ma forse il più significativo, si delinea dunque come l’affrancamento da Dio, dal Principio Primo e Ultimo, dall’Eterno, dall’Immobile, dall’Uno. A favore, invece, della dispersione, della differenza, del molteplice, del tempo.
L’itinerario in Grecia diventa così un viaggio interamente e profondamente pagano, nel quale «quella che per noi è solo bellezza, o un patrimonio di esperienze estetiche, per gli antichi era una forza viva da onorare e placare» (34); nel quale «i monti erano sacri per definizione, come le caverne e gli anfratti della terra, e in genere tutti i luoghi in cui la natura manifestava potentemente se stessa» (23), nel quale il morire è la migliore sorte, dopo la disgrazia d’essere nati; nel quale «a volte rimane da chiedersi perché si sta ancora al mondo» (45).
A distanza di millenni, oracoli, santuari e altri prodigi sono stati in gran parte riassorbiti nella natura che li ha generati; sono tornati a essere pietra, acque, terra. Emergono ancora qua e là dei riconoscibili resti, al modo in cui nella memoria di un individuo emergono qua e là ricordi di ciò che una volta è accaduto ma il cui significato è andato perduto nel procedere degli anni e dei luoghi.
Intuiamo quindi il Citerone, monte dove accaddero gli eventi più estremi, sanguinari, dionisiaci; Perachora, dove Medea seppellì i suoi figli; Delfi, dove il predire era «un dire, un disseminare parole a caso nello spazio infinito, che a volte il caso incontrava e rendeva vere» (98) (come ironicamente e splendidamente ha mostrato anche Dürrenmatt nella Morte della Pizia); Eleusi, dove «c’è stato un momento in cui è stato tutto vero, ma è durato un attimo e l’hanno visto in pochi» (69); Dodona, il più antico dei luoghi sacri [raffigurato nell’immagine qui accanto, che non è di Ballo Charmet], dove una colomba venuta dall’Egitto «imparò a parlare greco, e insegnò ai greci a interpretare la lingua degli animali, il fruscio delle foglie, il mormorio dell’acqua, il tintinnare degli oggetti appesi al vento, il risuonare tenue dei tripodi di bronzo» (107).
Tutto questo venne poi «fatto oggetto di scempio da scaltri, occulti, invisibili, esangui vampiri! Non vinto -soltanto dissanguato!…La nascosta sete di vendetta, la piccola invidia diventa padrona!» (F. W. Nietzsche, L’anticristo, § 59, Adelphi, p. 256), come a Olimpia, dove dopo gli ultimi giochi giunsero i goti che abbatterono i templi, «e poi arrivarono implacabili i cristiani, che avevano la tendenza a riconsacrare i luoghi della cultura pagana facendoci il nido dentro e consumandoli piano piano come parassiti» (Baldi, p. 28).
La Grecità è stata anche un «gioco di scambi e corrispondenze fra barbarie e civiltà (ambiguo, insidioso, ma profondamente vitale, se lo si riesce a governare)» (113); è stata anche lo spaziotempo in cui «la fierezza dei mortali vive accanto al senso del limite, inscindibile da esso» (117); è stata la civiltà in cui identità e differenza sono il conflitto e insieme la pace, il rifiuto e l’accoglienza, la potenza dell’esserci e il lamento del morire. È questa «competenza primordiale che in Grecia molti ancora hanno» a far sì che «finché ai greci rimarrà questa virtù di far sentire i propri simili parte della stessa famiglia umana, mi sembra che possano stare abbastanza tranquilli, e un po’ anche noi» (48).
Il testo si chiude ricordando ciò che accadde ai tempi di Tiberio, quando i naviganti sentirono vicino a Corfù una voce che chiamava il pilota egizio Tamo affinché annunciasse che il grande Pan è morto. «Non aveva ancora finito la frase, che tutto, intorno a lui, si riempì di stupore, e un immenso gemito si levò dalla riva» (118). Era morta la misura. Quella stessa misura che risuona nel primo testo della filosofia, il frammento di Anassimandro, e che invita ancora -per chi voglia ascoltarla- a guardare senza terrore alla «malattia originaria, quella che ci portiamo dentro da sempre, per il solo fatto di esistere. La cura del dio allora è come la discesa agli inferi di Ulisse: un viaggio di conoscenza per scoprire cosa abbiamo dentro che non sapevamo di avere, chi siamo che non sapevamo di essere» (57-58).
 Atene, Creta, Istanbul negli anni Sessanta. Chester e Colette, due agiati statunitensi, incontrano un concittadino che vive facendo la guida e imbrogliando un poco i turisti. Chester MacFarland, invece, della truffa è un esperto. Ma non sempre gli va bene. Ora è ricercato da malavitosi ai quali ha sottratto il danaro da investire. Uccide, senza volerlo, il detective che lo ha scovato. Il giovane Rydal aiuta lui e Colette nella fuga.
Atene, Creta, Istanbul negli anni Sessanta. Chester e Colette, due agiati statunitensi, incontrano un concittadino che vive facendo la guida e imbrogliando un poco i turisti. Chester MacFarland, invece, della truffa è un esperto. Ma non sempre gli va bene. Ora è ricercato da malavitosi ai quali ha sottratto il danaro da investire. Uccide, senza volerlo, il detective che lo ha scovato. Il giovane Rydal aiuta lui e Colette nella fuga.