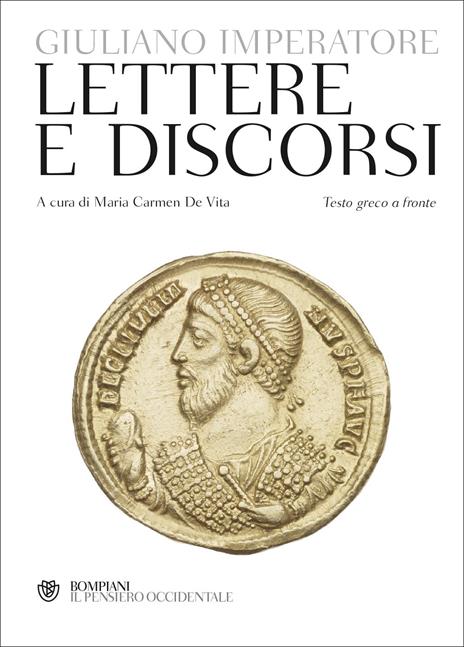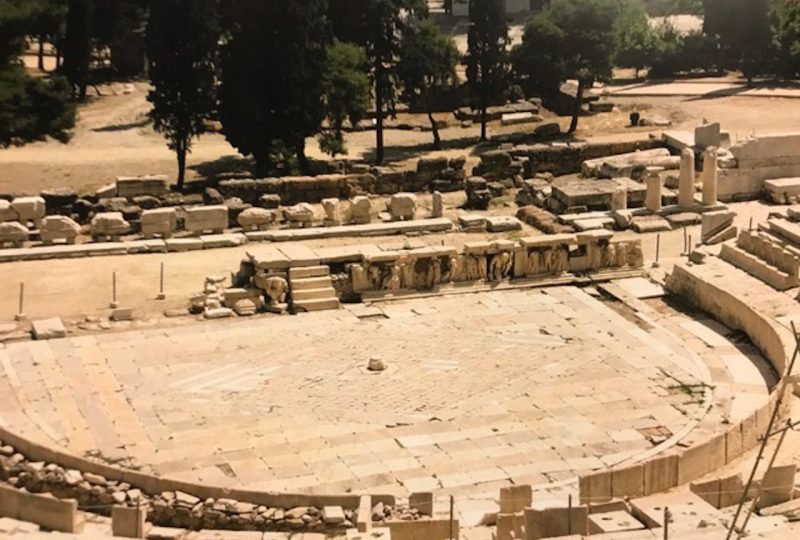Enrico Palma
L’anima. Ψυχή
vol. 12 della collana Greco. Lingua, storia, cultura di una grande civiltà
Corriere della Sera, 2022
Pagine 160
Ventiquattro volumi, ventiquattro parole, ventiquattro modi per accostarsi a «un archetipo di vita intramontabile, nell’orizzonte del quale ancora ci muoviamo, agiamo, pensiamo e in grazia di cui attribuiamo un senso al nostro esistere al mondo» (p. 63), per accostarci ai Greci. Parole quali πόλεμος, la guerra; τέχνη, la tecnica; λόγος, la filosofia; νόμος, la legge; μῦθος, il mito; ἀρχὴ, il potere, e altre parole/mondi costitutivi dell’identità europea, delle sue lingue.
Tra questi concetti c’è quello che dà titolo al dodicesimo volume della collana: ψυχή. Tradotta con il tradizionale «anima», questa parola si mostra nell’argomentare di Enrico Palma assai più sfuggente, ricca, complessa. È un nucleo intorno al quale si addensa un intero mondo di significati, credenze, concetti: ψυχή è «vita spirituale», «vibrazione del corpo che si manifesta nell’istante del suo abbandono», «mente» e «corpomente» (pp. 15-17) ed è ancora altro nel variare dei tempi, dei generi letterari, dei contesti quotidiani, teoretici, religiosi.
Questo volume è anche una sintetica storia della filosofia antica; una storia che comincia con Omero e si conclude con l’ellenismo. Storia che ha due dei suoi protagonisti in Dioniso «che sprigiona le energie occulte e libera nella gioia coloro che scelgono di votarsi a lui» (39) e in Platone, «evocare [il quale] significa affermare la grandezza del pensiero e la fiducia nella razionalità, intraprendere un cammino luminoso e numinoso di trasformazione di se stessi in luce e divinità» (55).
Dentro, accanto e sopra la parola ψυχή abita e vive un’altra parola fondante: ἀλήθεια, verità, che Palma traduce e spiega in un modo heideggeriano, vale a dire profondo e universale: «Ma cos’è la verità? È l’apertura di ciò che si mostra e che emerge dal non nascosto, il taglio di luce in cui avviene la giusta e illuminata visione del mondo» (54).
Ψυχή appare in questo libro parola fortemente prassica, legata al mondo dei riti mortuari e delle credenze relative alla fine; una delle fonti è giustamente Erwin Rohde, con il suo Psiche. Culto delle anime e fede nell’immortalità presso i Greci. Ma è parola legata anche al mondo dei vivi e delle loro passioni; un’altra fonte è Dodds, I Greci e l’irrazionale.
Che sia vita o che sia morte, vale a dire che sia tempo, la potenza di ψυχή è unita a quella di Ἅιδης, l’invisibile, l’oscuro, il vero regno della moltitudine, il regno dei morti; «Ade è un nome del Niente», come scrivono (a p. 10) i curatori della collana Monica Centanni e Paolo B. Cipolla.
Una continuità tra l’essere e il nulla che Palma sa bene mostrare e alla quale affida la conclusione del suo testo: «E allora quando l’alito della morte chiederà il nostro soffio di vita, lo daremo. Senza amaramente piangere, ma gioiosamente sorridendo» (65). Anche di questo i Greci sono capaci.