Come europei ci sentiamo a casa quando entriamo in contatto con le strutture, le opere, i concetti degli Elleni. E nello stesso tempo sappiamo di essere in un paese straniero. Il modo greco di esistere e di conoscere è infatti incomparabile rispetto a ciò che è venuto dopo.
All’abbandono e all’insensatezza che accompagnano la desacralizzazione della materia cosmica e della materia umana, i Greci contrappongono la potenza e la persistenza del mito.
Rispetto alll’attuale dominio dell’etica in ogni aspetto della vicenda umana e naturale (bioetica, deontologie, proliferare di etiche normative), i Greci ritengono che sia la filosofia stessa la più efficace guida dei comportamenti, delle esistenze, dei conflitti.
Per i Greci la saggezza della vita (φρόνησις) è inseparabile dalla sapienza teorica (σοφία) e dove non si dà la seconda difficilmente può esserci la prima. La loro è
una morale senza legge astratta né imperativo categorico. Il problema morale fondamentale è sapere che tipo di vita condurre e come formare il proprio carattere. […] È una morale senza dio e senza regole astratte, perché le norme non sono mai separate dal problema di sapere che genere di vita condurre. D’altra parte, non si trovano nemmeno l’idea dell’universalità delle obbligazioni, né la concezione di compagine umana, né la consapevolezza delle dimensione propria della storia. […] Per concludere, il pensiero greco è perfettamente integrato nella vita dell’uomo. La concezione greca della moralità può accogliere il destino, o il caso e le vicissitudini che caratterizzano la vita dell’uomo. È per questo che difende una concezione di uomo morale, razionalmente autosufficiente, libero, al riparo dalle contingenze. Nella certezza della precarietà della realizzazione morale […] il pensiero etico greco ritrova un legame essenziale con le opere degli autori tragici1.
Per i Greci che la praticavano, la filosofia non è affatto un mestiere –neppure per i Sofisti–, una eccentricità, un lusso, una parte del sistema delle scienze. La filosofia è –e non può che essere questo, non soltanto per i Greci ma per chiunque sia veramente filosofo– la totalità dell’esistenza, del tempo, dello sguardo, dell’agire. La filosofia è significato, strada, senso e redenzione: «Per riuscire a condurre una vita buona, per diventare un uomo che persegue il bene, per essere salvato, si debba essere filosofi. Su questo punto, da Socrate in poi, i filosofi concordano» (M. Frede, 8).
Guida di ogni momento, forma della totalità, strumento di salvezza, la filosofia è ontologia dalla quale deriva poi ogni altra questione, ambito, contesto. Prima di affrontare qualsiasi aspetto particolare e specifico, vanno infatti indagate, comprese e praticate tutte le possibilità, le alternative e le risposte alla questione dell’essere. La centralità del pensare platonico e aristotelico, anche rispetto alla profondità senza misura dei pensatori delle origini, consiste proprio nello sguardo ontologico che questi filosofi rivolgono a ogni frammento del mondo.
Anche da tale sguardo deriva l’antropodecentrismo della filosofia greca, così diverso dalla centralità dell’umano e persino della soggettività che caratterizza invece il pensiero cristiano, cartesiano e moderno. Proprio perché del tutto antropodecentrica, la filosofia più greca dell’età moderna è quella di Spinoza, giustamente richiamato da Jacques Brunschwig nell’affrontare la questione dello slancio del sapere greco, il quale si alza su
un iniziale fondo di tristezza epistemologica: rispetto al sapere divino, le facoltà umane sono severamente limitate, per non dire inesistenti […] Ma accanto a questo pessimismo, che del resto non scomparirà mai, si riscontrano espressioni di vero entusiasmo epistemologico, che nasce e trae forza […] anche e soprattutto dall’idea tacitamente e quasi universalmente ammessa che l’uomo non sta nel mondo come un impero in un impero (per citare Spinoza), come un’isola imprigionata in rappresentazioni che schermano il reale; al contrario, l’uomo sta nel mondo come a casa propria, ne è parte integrante, è fatto della stessa stoffa (89).
Della stessa sostanza del mondo è fatta la parte di materia che si conosce e indaga anche se stessa partendo dall’ammissione che esiste una natura umana, senza la quale non è possibile spiegare la persistenza della lotta, del desiderio e della socialità pur nella miriade di forme mediante le quali lotta, desiderio e socialità si esprimono nel tempo e nello spazio.
Lotta, desiderio, socialità e limite. Nulla bisogna temere come la ὕβρις, la dismisura che ci illude sulle nostre capacità e soprattutto sul valore e il senso delle nostre vite, infime agli occhi degli dèi, vale a dire dell’intero che non conosce pianto. È anche questo lutto del valore a produrre la varietà di strategie che i Greci inventano e adottano per conoscere il mondo del quale siamo parte. È anche per questo che la scienza greca visse una feconda «tensione tra due concezioni molto diverse. La prima esige una scienza esatta, che dia risultati certi, apporti dimostrazioni che procedono da premesse evidenti per se stesse per arrivare attraverso deduzioni valide a conclusioni inconfutabili; la seconda fa spazio al probabile, alla congettura, all’esperienza» (G.E.R. Lloyd, 310).
La metafisica nata con Platone e Aristotele rimane una prospettiva fondante e insieme inattuale anche perché costituisce lo sforzo più radicale e più compiuto di non separare teoria e prassi, immersione nel flusso del tempo e comprensione del tempo come un’interezza non divisa in parti contrapposte e artificiose.
Se «la più grande vittoria di Parmenide» consiste nel fatto che «nessuno contesterà più che l’intelligibilità appartiene a ciò che è eterno e immutabile, e che ciò che è perituro o in movimento è tutt’al più oggetto di opinione» (P. Pellegrin, 379), la fisica eleatica si mostra la migliore alleata della modernità antimetafisica e sofistica, la quale giustamente respinge una concezione così lontana da ogni possibile esperienza fenomenologica ma ne deduce (sbagliando) che tutto sia opinione e che dunque una metafisica non ha legittimità euristica nel mondo.
E invece con Platone, con Aristotele, con gli Stoici va ribadito che il mondo è fatto di parti –Differenza– e, insieme, che l’intero –Identità– è oltre la semplice somma aritmetica e quantitativa delle parti di cui è composto; va ripetuto «che esiste una differenza tra un essere identificabile e una massa informe di materia. In un essere vivente questo è del tutto ovvio, naturalmente; ma anche un lago, o una roccia, possiedono un principio di unità che li differenzia da una semplice massa d’acqua, o da un semplice sedimento minerale» (D.J. Furley, 368).
Anche questo gioco di identità e differenza fa l’unicità dei Greci, del loro pensare come del loro essere stati ed essere ancora. Anche per merito di tale equilibrio sempre diveniente, di questa mai statica e mai dispersa unità, va riconosciuto «all’esperienza greca, e in particolare ateniese, un valore unico nella storia delle società umane» (C. Mossé, 189).
1. M. Canto-Sperber, in Il sapere greco. Dizionario critico (Le savoir grec, Flammarion 1996), a cura di J. Brunschwig e G.E.R. Lloyd; edizione italiana a cura di M.L. Chiesara, Einaudi 2007, vol. I, p. 142. Le citazioni successive saranno indicate con il nome dell’autore e il numero di pagina.
[Il secondo volume dell’opera è stato da me presentato e discusso qui: Il sapere dei Greci]





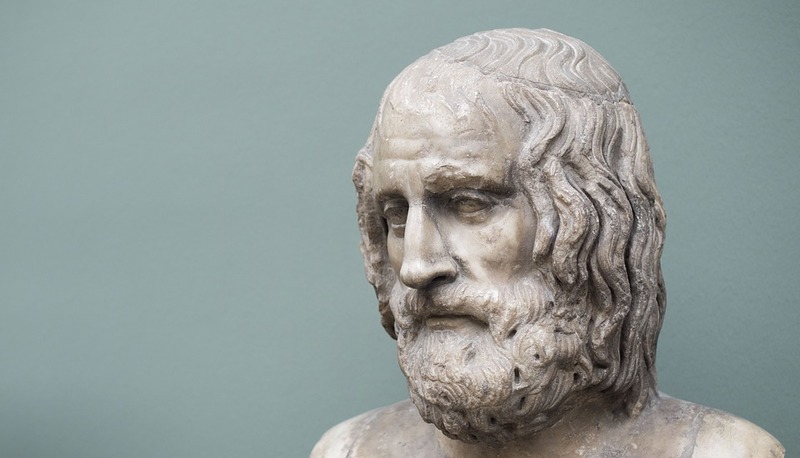

 Le colline e i monti non lontani ospitano eremi di sante, borghi con piazze dove due chiese contrapposte si congiungono nella splendida fontana che sta loro in mezzo, formando una quinta teatrale quasi predisposta per l’epopea western e per altre forme dell’invenzione cinematografica. Questo luogo si chiama Palazzo Adriano, uno dei borghi albanesi di Sicilia, ed è stato infatti scelto da molti registi. Il paesino è posto in basso; sopra di esso sta Prizzi, una casba medioevale intessuta di chiese, edificata davanti alla Montagna dei Cavalli, che conserva nel proprio cuore l’antico abitato di Hippana, uno dei più importanti centri della Sicania, assai antico e sopravvissuto sino al 241 a.e.v., quando la conquista romana cambiò le sorti dell’Isola. Nella strada più importante del paese ha sede il Museo Archeologico ‘Hippana’, ospitale e ricco di ciò che nella Montagna dei Cavalli è stato ritrovato, trafugato e a volte restituito: lamine d’oro e d’argento, una ricca collezione di monete, statuette di vario soggetto, preziosi vasi -lekane, pissidi, alabastron– che raffigurano scene di vita quotidiana e miti dionisiaci.
Le colline e i monti non lontani ospitano eremi di sante, borghi con piazze dove due chiese contrapposte si congiungono nella splendida fontana che sta loro in mezzo, formando una quinta teatrale quasi predisposta per l’epopea western e per altre forme dell’invenzione cinematografica. Questo luogo si chiama Palazzo Adriano, uno dei borghi albanesi di Sicilia, ed è stato infatti scelto da molti registi. Il paesino è posto in basso; sopra di esso sta Prizzi, una casba medioevale intessuta di chiese, edificata davanti alla Montagna dei Cavalli, che conserva nel proprio cuore l’antico abitato di Hippana, uno dei più importanti centri della Sicania, assai antico e sopravvissuto sino al 241 a.e.v., quando la conquista romana cambiò le sorti dell’Isola. Nella strada più importante del paese ha sede il Museo Archeologico ‘Hippana’, ospitale e ricco di ciò che nella Montagna dei Cavalli è stato ritrovato, trafugato e a volte restituito: lamine d’oro e d’argento, una ricca collezione di monete, statuette di vario soggetto, preziosi vasi -lekane, pissidi, alabastron– che raffigurano scene di vita quotidiana e miti dionisiaci.


