De Chirico
Palazzo Reale – Milano
A cura di Luca Massimo Barbero
Sino al 19.1.2020
Nacque a Volos, Giorgio de Chirico, in Tessaglia, a nord dell’isola Eubea. Nel cuore quindi della Grecia, dalla quale assorbì l’enigma, la logica labirintica, il mito. E il mito cominciò a dipingere. Centauri, argonauti, dèi, gladiatori, Odisseo, Ettore, Andromaca, abitano le prime sue opere in forme avvolgenti, dolci e insieme lontane. La partenza degli Argonauti (1909, immagine qui sotto) raccoglie Atena, il mare, il sacrificio, la cetra, il bianco, le fronde.
 Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.
Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.
La folgorazione dell’architettura -fondante e splendido L’enigma di una giornata (1914, immagine di apertura)– con le piazze solitarie, le statue dentro lo spazio che diventa luce, i portici raccolti e inquietanti, i treni che corrono lontano alla ventura, le torri e le ciminiere rivolte verso il cielo sacro. L’architettura è anche la lezione del Rinascimento italiano. Nello sguardo di de Chirico la prospettiva diventa una struttura spaziotemporale che vibra di colori accesi, netti, ontologici.
E poi quadri dentro i quadri, il gusto e il gioco della ripetizione seriale, la libertà -massima– da ogni moda, richiesta, manierismo. Celebrato come inventare della Metafisica, la abbandona facendosi naturalista e romantico e poi vi ritorna negli anni Sessanta, sorprendendo e irritando quanti -critici, mercanti, pubblico– vorrebbero da un artista sempre la stessa forma. L’arte, invece, è invenzione che mai si stanca di «scoprire l’occhio e il demone in ogni cosa», come una volta disse.
In ogni sua fase, espressione, invenzione e sentiero, la pittura di de Chirico è sopratutto pittura, è la posseduta tecnica di un Maestro poiché «una pittura non può essere né sincera, né pura, né spirituale, essa può essere soltanto bene o male dipinta […] Ed è precisamente la qualità della pittura che determina se un quadro è un’opera d’arte oppure un oggetto qualsiasi». Una dichiarazione di poetica del tutto condivisibile.
Giorgio de Chirico è stato un pittore barocco, greco, postmoderno, omerico, ariostesco. Imprendibile perché abitante dentro l’ironia di una profonda intelligenza del mondo.
Un quadro del 1927 ha come titolo Il Filosofo. I suoi pensieri provengono letteralmente dal corpomente, dallo stomaco, dagli arti. Al centro di questo suo corpo un’altra frase: «Sum sed quid sum», che si può leggere come «sono ciò che sono» ma anche «sono ma in cosa consisto?». Uno degli interrogativi dai quali mito e filosofia sono sgorgati.
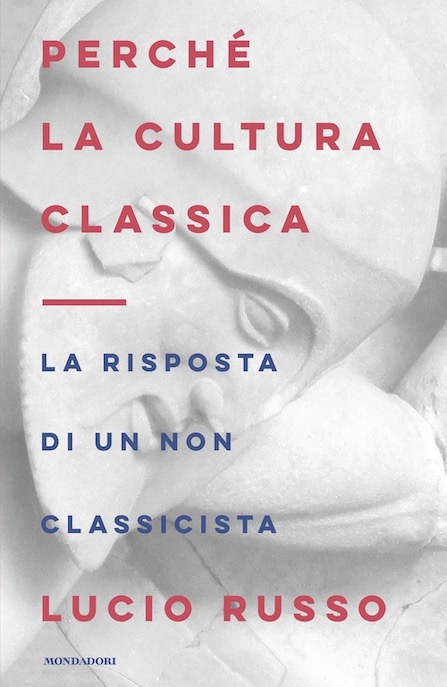




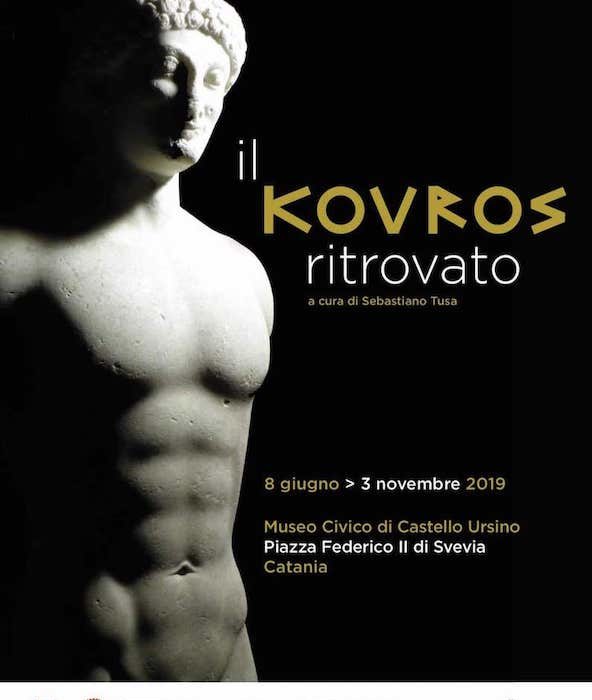


 Gioielli, anelli, gemme, corone. L’oro, il bronzo e l’argento. Anfore e contenitori in vetro. Una ricca sezione
Gioielli, anelli, gemme, corone. L’oro, il bronzo e l’argento. Anfore e contenitori in vetro. Una ricca sezione

 alleata dei Troiani-, l’improvviso amore che sboccia tra lei e Achille proprio mentre l’amazzone muore per mano del guerriero acheo; amore e morte coniugati senza sentimentalismi e insieme con qualcosa di struggente come soltanto una fine che è inizio può essere.
alleata dei Troiani-, l’improvviso amore che sboccia tra lei e Achille proprio mentre l’amazzone muore per mano del guerriero acheo; amore e morte coniugati senza sentimentalismi e insieme con qualcosa di struggente come soltanto una fine che è inizio può essere.

 Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.
Il mito come distanza si fa ironia, soprattutto nei numerosi Autoritratti. Da quello nietzscheano del 1911 -che ha come epigrafe sulla cornice «Et quid amabi nisi quod aenigma est?», che cosa amerò se non qualcosa che si faccia enigma?, a quelli in veste di torero, principe, o semplicemente nudo. Autoritratti che non sono soltanto espressione dell’inevitabile narcisismo ma anche della consapevolezza che il corpo è quanto di più intimo noi siamo.
