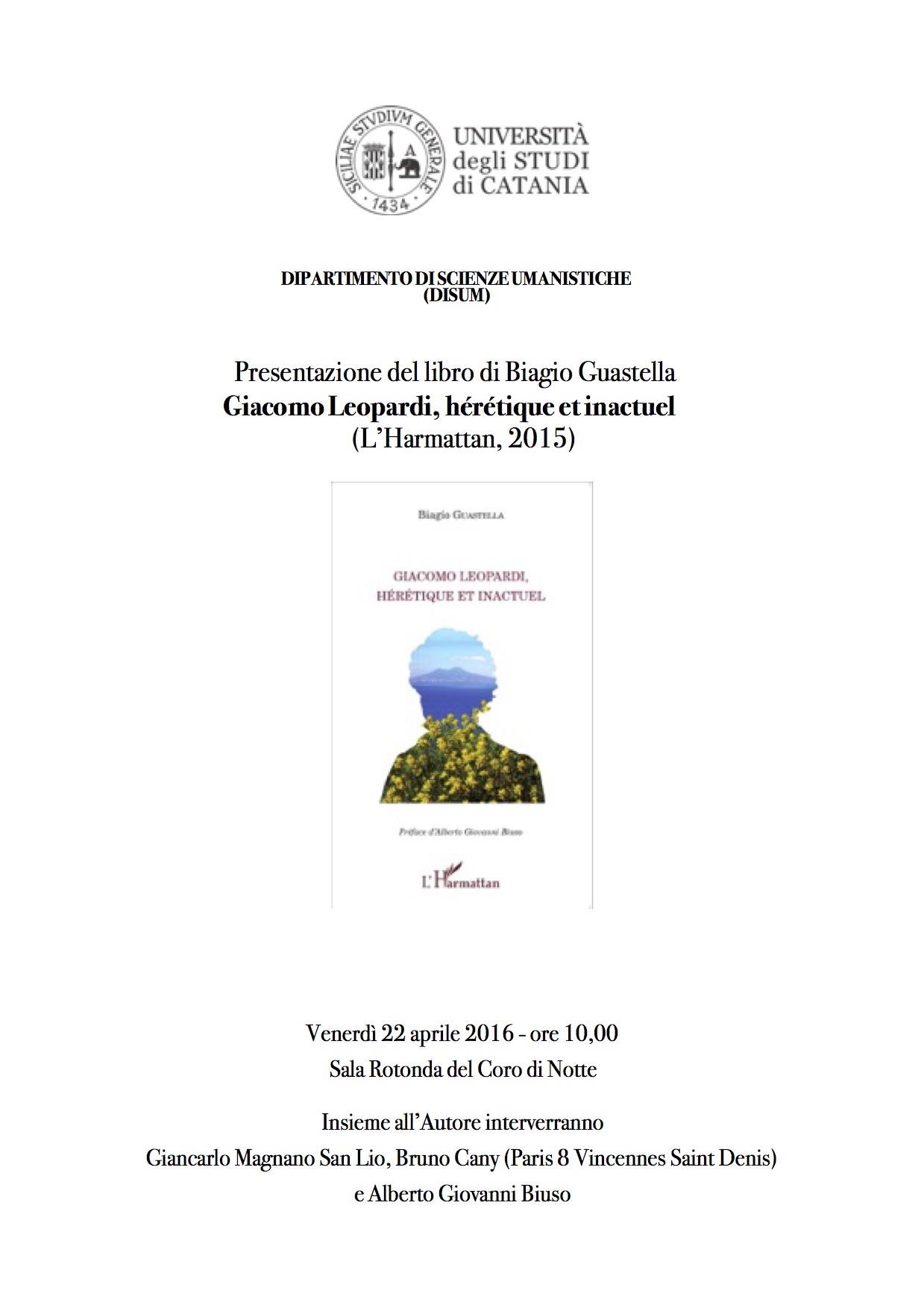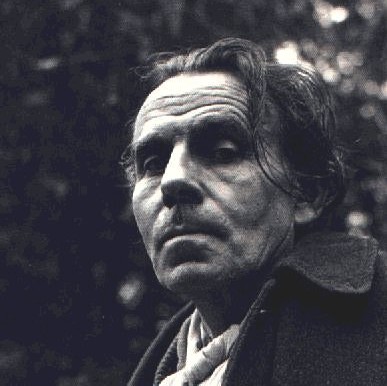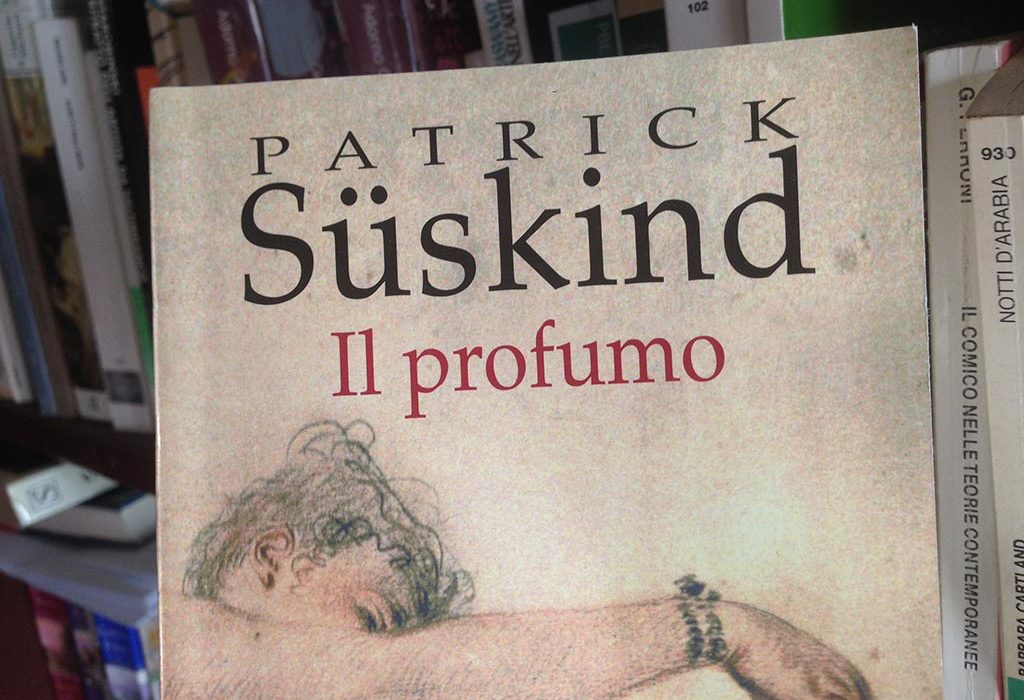Tito Schabert – Matthias Riedl (a cura di)
Das Ordnen der Zeit
Eranos, 10 / 2003
Königshausen & Neumann, 2003
Pagine 213
 Il Tempo come Gabe [dono]; il Tempo che per Spinoza è un modus imaginandi, un’illusione; il Tempo come divinità livellatrice di ogni differenza, celebrato da Sofocle nell’Elettra; il Tempo come inseparabilità di otium e punctum; il Tempo della Gnosi nel quale «die Unendlichkeit des Äon» [l’infinità dell’Aion] si concentra tutta «in diesem Augenblick» [in questo istante] (J. Thomas, p. 155), la cui gustata potenza può indifferentemente aprire all’ascesi come alla dissolutezza, poiché ciò che gli umani sperimentano non è neppure la platonica “immagine mobile dell’eternità” ma proprio una sua Zerrbild, una sua “caricatura” (Id., 153).
Il Tempo come Gabe [dono]; il Tempo che per Spinoza è un modus imaginandi, un’illusione; il Tempo come divinità livellatrice di ogni differenza, celebrato da Sofocle nell’Elettra; il Tempo come inseparabilità di otium e punctum; il Tempo della Gnosi nel quale «die Unendlichkeit des Äon» [l’infinità dell’Aion] si concentra tutta «in diesem Augenblick» [in questo istante] (J. Thomas, p. 155), la cui gustata potenza può indifferentemente aprire all’ascesi come alla dissolutezza, poiché ciò che gli umani sperimentano non è neppure la platonica “immagine mobile dell’eternità” ma proprio una sua Zerrbild, una sua “caricatura” (Id., 153).
Di tali e di altre numerose rappresentazioni del Tempo (precolombiana, mistico-cristiana, islamica, ebraica) questo volume di Eranos dà conto in modo raffinato e molteplice. Poiché se l’uomo antico, come scrive ancora Thomas, è certo più di quello contemporaneo «eingebunden in die Rhythmen des Cosmos und im Einklang mit ihnen» [immerso nei ritmi del Cosmo e nell’armonia con esso] (135), in ogni caso anche per noi il Tempo è una sorta di sottile e impalpabile Wasserzeichen [filigrana] che attraversa «Bewuβtsein und Wissen» [coscienza e sapere] (G. Zarone, 167).
Thomas individua nel mondo classico tre diverse e fondamentali rappresentazioni del Tempo: ciclica, lineare, a spirale. Quest’ultima è simbolo «der unendlichen Wandlung und Metamorphose» [di un’infinita trasformazione e metamorfosi] (136). E non è quindi casuale che il volume si apra e di fatto anche si chiuda sulla metafora eraclitea che più di ogni altra ha espresso, nascosto e svelato la struttura cosmica e insieme interiore –duplice e a spirale- del Tempo: αἰὼν παῖς ἐστι παίζων πεσσεύων• παιδὸς ἡ βασιληίη, il Tempo è un fanciullo che per gioco sposta le pedine sulla scacchiera: sovrano potere di bimbo (DK, B52). Se il Tempo va distinto dalle sue figure, il Tempo è colui che gioca mentre le figure sono ciò con cui egli gioca, le pedine appunto.
Si muore, quindi, perché la struttura biologica che siamo non ci permette di giocare all’infinito le figure temporali. È probabilmente quanto aveva intuito il medico pitagorico Alcmeone citato da Aristotele in Problemata, 916 a33, per il quale gli uomini muoiono poiché sono incapaci di congiungere l’inizio e la fine. Di che cosa? Del loro corpo pulsante, della materia temporale che sono.
Così conclude con esattezza il suo saggio Zarone: «Wir kennen Aion und Chronos, Kairos und Anache, Linie und Zirkel, Kreislauf und Ereignis, durée und évenement, hazard und necessité, Eschaton und Geschichte, Augenblick und Ewigkeit…Aber wohl kaum ein Bild der Zeit kann sich der Anmut des heraklitischen Aion entziehen, der Faszination des mit den Schachfiguren spielenden Kindes –das wir uns dort vorstellen, an der sonnigen Küste des anatolischen Meeres» (173).
[Noi conosciamo Aion e Chronos, Kairos e Ananke, Linea e Circolo, Ritorno ed Evento, durée e évenement, hazard e necessité, Escatologia e Storia, Attimo ed Eternità…Ma quasi nessuna immagine può esprimere la Grazia dell’Aión eracliteo, il fascino del Fanciullo che sposta i pezzi della scacchiera sulle coste assolate del mare anatolico].