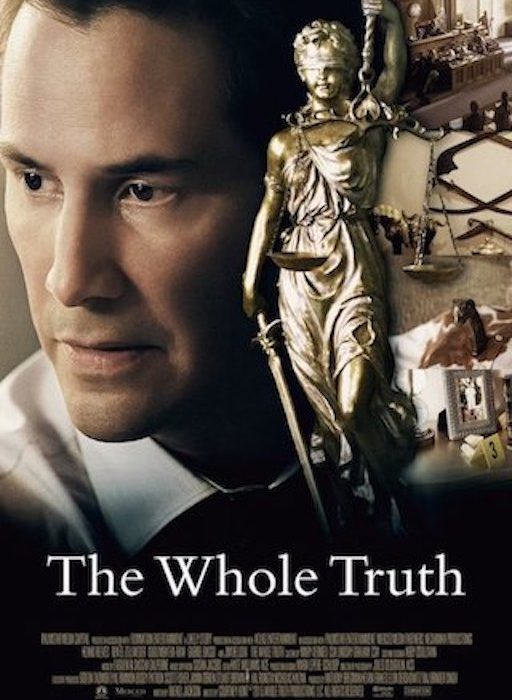The Favourite
(La favorita)
di Yorgos Lanthimos
Grecia, 2018
Con: Olivia Colman (Queen Anne), Rachel Weisz (Sarah Churchill, Duchess of Marlborough,), Emma Stone (Abigail Masham)
Trailer del film
Tre meravigliose attrici disegnano e incarnano la potenza che sino in fondo e verso ogni confine fa della vicenda umana l’inevitabile e nascosto matriarcato che da sempre essa è. Anne Stuart (1665-1714) governa il Regno Unito. Lo fa da una camera, da un letto, da una carrozzina, dalle stampelle. La gotta non le consente l’agilità necessaria a muoversi autonomamente. Condizione che, unita alle molte gravidanze andate a male, causa una salute malferma e una volontà oscillante tra il pianto e le carezze. A sostenerla negli affari di stato c’è la favorita Sarah Churchill, duchessa di Marlborough. Una giovane e lontana cugina di Sarah compare a corte e a poco a poco la conquista, passando dal ruolo di sguattera a quello di ministro. Abigail, questo il suo nome, è stata istruita alla durezza dalle disgrazie familiari che l’hanno fatta decadere da una condizione nobiliare a uno stato di indigenza.
La lotta tra le due donne sul corpo e per il corpo della regina descrive la vicenda umana, le sue guerre, la diplomazia, la determinazione, la menzogna, la ferita, i silenzi, i colpi, le parole, i veleni. Gli strati sociali si confondono nella medesima miseria, dalle prostitute «che danno il culo ai soldati sifilitici» agli aristocratici imbellettati come le puttane, dai servitori perfidi e impacciati ai primi ministri tracimanti di corruzione, dai viaggiatori pervertiti in misere carrozze allo sfarzo di imponenti biblioteche. Ovunque e sempre la violenza involve la vita degli umani, una comune passione la muove, la passione della sopravvivenza dentro il gorgo immutabile e dinamico del tempo collettivo.
Qualche commentatore ha scritto che finalmente Yorgos Lanthimos avrebbe abbandonato ‘le plumbee atmosfere metafisiche’ delle sue ultime opere. Non sanno proprio vedere che invece questo regista crea sempre il medesimo film, come Kubrick.
Di Dogtooth – Kynodontas (2009), The Favourite possiede lo stile iperrealista e raffinato, asciutto e insieme grottesco; così come di The Lobster (2015) esprime la distopia insita nei sentimenti, nei legami, nel naturale, totale, disperato bisogno che gli umani sentono di vivere con gli altri, un bisogno sul quale l’autorità getta la rete sadica dei suoi comandi. E come ne Il sacrificio del cervo sacro (2017) emerge qui l’inesorabile forza degli eventi concatenati gli uni agli altri, dentro più dentro le passioni umane, il cui andare è stabilito dall’ininterrotto divenire dei desideri, delle ambizioni, del gelo e delle follie.
Tutto questo è narrato tramite l’opulenza del grandangolo e lo sbigottimento dei primi piani, mediante lo sfarzo dei colori e la ferocia che cola dalla luce. Ma alla fine, alla fine è la giustizia. Giustizia che riscatta gli altri animali dalla viltà umana e fa di un coniglio il segno, la traccia e l’occasione di una scena conclusiva strana sino all’incomprensibilità e tuttavia splendida e trasparente per chi sa che il sogno umano -ciò che chiamiamo storia– è abitato nel suo fondo dalle immagini ancestrali degli animali. Per chiudere un film nel modo in cui The Favourite si chiude bisogna avere molto coraggio, bisogna avere genio.