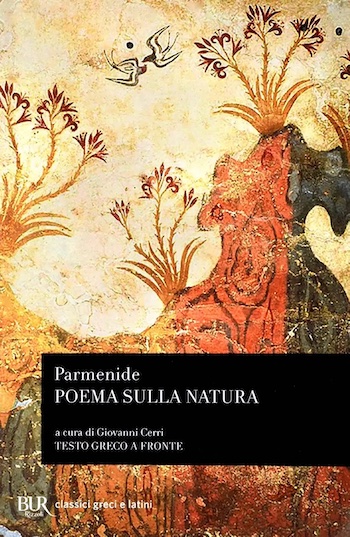Le passioni che conducono gli Achei nella piana di Troia, a vendicare l’offesa recata da un figlio di Priamo a Menelao sovrano, saranno «anche in futuro, / per la gente di là da venire, materia di canto» (Iliade, trad. di Giovanni Cerri, VI, 358).
Che cosa narra tale canto? Narra degli umani che sono incapaci «di vedere insieme il prima e il dopo» (II, 343) mentre sapienza e saggezza consistono anche nel sapere «le cose che furono, sono e saranno (I, 70). Gli umani sono la fragilità stessa della materia, sono come foglie che «il vento ne sparge molte a terra, ma rigogliosa la selva / altre ne germina, e torna l’ora della primavera: / così anche la stirpe degli uomini, una sboccia e l’altra sfiorisce (VI, 147-149). Tutte le generazioni rimangono composte da «miserabili, che simili a foglie una volta si mostrano / pieni di forza, quando mangiano il frutto dei campi, altra volta cadono privi di vita» (XXI, 464-466). Ciò accade perché «gli dei stabilirono questo per gl’infelici mortali, / vivere in mezzo agli affanni; loro invece sono sereni» (XXIV, 525-526). E dunque «non c’è niente di più miserevole di tutti gli uomini fra tutti gli esseri / quanti respirano e arrancano sulla faccia della terra» (XVII, 446-447).
Di tale condizione affannata, effimera e miserabile, l’Iliade mostra forme, ragioni e struttura. Esse si condensano nel πόλεμος, nel conflitto che -afferma Eraclito- è padre di tutte le cose, di tutte è signore (fr. 53). La guerra intride qui tutto. È uno dei due archetipi che fondano la letteratura europea, l’altro è il viaggio, è l’Odissea.
La guerra. Rovinosa (κακοιο, II, 284). Terribile (κακόν, XIII, 225). Che fa ribollire il fiume Xanto «di spuma, di sangue e di morti» (XXI, 325), che eleva al cielo e ovunque «il lamento e il tripudio degli uomini / che uccidevano ed erano uccisi, grondava di sangue la terra» (IV, 450-451 e VIII, 64-65). In questo poema i guerrieri muoiono a frotte, con estrema facilità, in poco tempo colpiti e annientati da chi è più abile di loro, vale a dire da coloro la cui mano è guidata dalla volontà di qualche dio. Guerrieri che non vorrebbero morire, che arrivano a temere la fine sino a fuggire, mandando in malora onori e obiettivi, «a tutti un tremore prese le membra, / e si studiava ognuno da che parte sfuggire a morte immediata» (XIV, 506-507). Morire, infatti, vuol dire andare nell’Ade, «dimora umida, spaventosa, di cui pure gli dei hanno orrore» (XX, 65)
Guerrieri la cui psyche facilmente li abbandona, uscendo dalle ferite aperte dal bronzo, lasciando soltanto una tenebra. Perché qui psyche non vuol dire per nulla anima o qualcosa di simile ma significa, semplicemente, la vita, l’indistinta unità del corpomente che esiste nello spazio e nel tempo. Guerrieri che piangono spesso, con voluttà, senza alcuna vergogna, come accade anche nel conclusivo dialogo tra Priamo e Achille: «Immersi entrambi nel ricordo, l’uno per Ettore massacratore / piangeva a dirotto prostrato ai piedi di Achille, / mentre Achille piangeva suo padre, ma a tratti anche Patroclo: il loro lamento echeggiava per la casa» (XXIV, 509-512). Un pianto che tutti accomuna e dopo il quale l’uccisore del figlio e il padre dell’ucciso gustano infine «il piacere di guardarsi l’un l’altro» (XXIV, 633).
Il conflitto è ovunque. Non soltanto tra nemici di stirpe e di terre ma anche all’interno delle stesse comunità, famiglie, tribù. Il risentimento e l’ira di Achille verso Agamennone sono ben noti. Meno lo è quanto Ettore dice a proposito del fratello Alessandro Paride, fonte per Ilio di tante sciagure: «Se lo vedessi discendere dentro i recessi di Ade, / direi che un brutto malanno avrebbe scordato il mio cuore» (VI, 284-285). Odio e vendetta sono per queste culture realtà del tutto ovvie e naturali. E questo vale per l’intera Grecità, da Omero ad Aristotele, secondo il quale «vendicarsi dei nemici è più bello anziché riconciliarsi» (Retorica A, 9, 1367 a, 20).
Nell’Iliade la ferocia è continua. Non è davvero possibile definire i Greci ‘umanisti’ quando qui si descrivono come del tutto comuni i sacrifici umani -Achille sgozza sulla tomba di Patroclo dodici ragazzini troiani fatti da lui prigionieri a tale scopo: «Con me rallegrati, Patroclo, sia pure in casa di Ade: / perché manterrò tutto quello che poco fa t’ho promesso, / di trascinare Ettore qui e darlo crudo in pasto ai cani, / di sgozzare davanti al tuo rogo dodici figli scelti / dei Troiani, perché sono adirato che t’abbiano ucciso» (XXIII, 19-23)-, quando non c’è nessun rispetto per il cadavere di Ettore, che non soltanto viene trascinato ogni giorno da Achille nella polvere ma che gli altri guerrieri colpiscono ridendo -«eppure nessuno s’accostò senza colpirlo. / E così ciascuno diceva rivolto al vicino: ‘Ehilà, adesso a toccarlo è molto più morbido Ettore, di quando applicava alle navi il fuoco vorace!’» (XXII, 371-374; 1133), Ettore che da parte sua vorrebbe di Patroclo ucciso «issarne / la testa mozzata dal tenero collo sulla punta d’un palo» (XVIII, 176-177).
Non si può comprendere nulla di questo mondo distante e disumano se non si ricorda a ogni istante che tutti i personaggi dell’Iliade sono in mano al volere degli dèi. Tutti. La presenza e il potere dei Numi sono pervasivi e assoluti. A loro vengono ascritti meriti, colpe, esiti. Della sua ingiustizia verso Achille Agamennone afferma di non essere colpevole, poiché i responsabili sono «Zeus e la Moira e l’Erinni che vaga nel buio» (XIX, 87). Presaghi della fine del loro padrone, i cavalli di Achille dicono al loro signore che «certo, ti salveremo anche stavolta, Achille potente / ma t’è vicino il giorno fatale; e non siamo noi / i colpevoli, ma un grande dio e la Moira invincibile» (XIX, 408-410).
Moira ed Erinni, θάνατος καί μοῖρα κραταιή (XXIV, 132), ‘la morte e il duro destino’, sono i veri signori del poema. Più di Zeus, più di tutti gli altri immortali. Più di «Afrodite che ama il sorriso» (III, 424 e XXI, 40). Più di «Dioniso, gioia dei mortali» (XIV, 325). Più di tutti «gli dei che vivono lieti» (θεοί ῥεῖα ζῶοντες, VI, 138), «gli dei beati che vivono eterni» (θεοί ἀιεν ἐοντες, XXIV, 99). Signore della materia, della psyche e del mondo sono la Moira e «l’Erinni che vaga nel buio / […] col suo cuore spietato» (IX, 571-572).
Chi combatte, domina e trionfa nella pianura sconfinata di Ilio? I guerrieri troiani e gli achei certo. Ma «erano in campo con loro la Furia, il Tumulto, la Morte funesta» (XVIII, 535).