Il dolore, per quanto sta accadendo a un popolo di antica eleganza e rigore come il Giappone, è profondo. Tra le immagini più impressionanti quelle del mare inarrestabile che invade di sé la terra con l’implacabilità di una potenza indiscutibile, potenza che soltanto un antropocentrismo ingenuo e patetico può far ancora definire -da non pochi giornalisti, ad esempio- come “irrazionale”. La Terra è il paradigma stesso della razionalità, col suo ordine cosmico dei movimenti di rotazione e di rivoluzione, di moto delle placche geologiche, di trasformazione costante e di entropia. Terremoti, tempeste, piogge, calore, sono assolutamente “razionali”. Irrazionali sono gli esseri umani, le civiltà, le amministrazioni, che costruiscono dighe su terreni franosi, impianti nucleari in zone sismiche, case su case alle falde di vulcani come l’Etna o il Vesuvio. Di tanto in tanto, la nostra grande Madre ci ricorda che siamo una specie come le altre, materia tra la materia, finitudine fatta di pianto e di hybris. Di diverso rispetto alle altre specie viventi abbiamo soprattutto la capacità di affrettare la nostra fine provocando Gaia a scrollarci da sé come quei fastidiosi e arroganti parassiti che siamo. Heidegger, filosofo della Misura, ci ha ricordato che «su questa terra noi rimaniamo insediati nel relativo» (Conferenze di Brema e Friburgo, Adelphi 2002, p. 218).
(Okuribito)
di Yojiro Takita
Giappone, 2008
Con Masahiro Motoki (Daigo Kobayashi), Ryoko Hirosue (Mika Kobayashi), Tsutomu Yamazaki (Ikuei Sasaki), Kazuko Yoshiyuki (Tsuyako Yamashita), Takashi Sasano (Shokichi Hirata).
Daigo è un giovane violoncellista che rimane senza lavoro; risponde a un annuncio riguardante “assistenza ai viaggi” e si ritrova assunto in una agenzia che si occupa sì di viaggi ma soltanto di quello definitivo. Dopo le prime reazioni di sconcerto, Daigo apprende la raffinata e antica arte della tanatoestetica, del rendere belli i morti prima della loro cremazione, in modo che i familiari ne conservino un ricordo di armonia e non di decadenza. A poco a poco, e sotto la saggia e ironica guida dell’anziano Ikuei, Daigo intraprende un itinerario dentro il senso che il morire ha per gli umani. Cura, esattezza, amore, costituiscono le condizioni affinché i familiari di chi non c’è più possano ancora sentire vicina la persona che sta per andarsene per sempre. A questo punto, neppure il rifiuto e le accuse della moglie e degli amici -venuti a sapere del suo nuovo lavoro- costituiranno per Daigo una ragione di sconfitta. L’incontro finale con il padre, che lo aveva abbandonato all’età di sei anni, suggella la riconciliazione col dolore che intesse la vita.
Premio Oscar come miglior film straniero del 2009, Departures è insieme delicato e forte, umoristico e drammatico, sentimentale e oggettivo. Basato sull’antico rispetto giapponese per i morti -e su una cura dei cadaveri che somiglia a quella praticata nell’Egitto antico- affronta con misura e con la giusta ironia un tema che non è mai semplice da esporre. Tutta l’opera è intessuta della passione di Daigo per il violoncello e per la musica che sa restituire vita a ogni cosa trascorsa.
[Sul numero 4 (ottobre 2010) di Vita pensata si può leggere una più ampia recensione ]
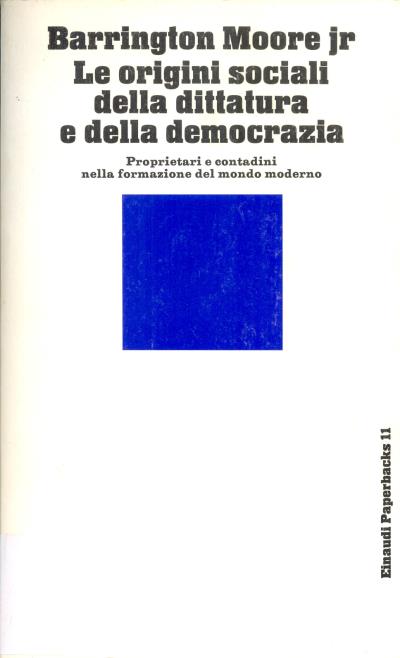
Le origini sociali della dittatura e della democrazia
Proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno
di Barrington Moore jr
(Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Pesant in the Making of the Modern World, Bacon Press, Boston 1966)
A cura di Domenico Settembrini
Presentazione di Luciano Gallino
Einaudi, Torino 1979 (1969)
Pagine XXIV-612
Il sottotitolo di questo libro ne indica con esattezza l’argomento. Contadini e proprietari terrieri hanno fornito un contributo decisivo alla formazione delle strutture sociali contemporanee ma con esiti ben differenti e anche paradossali.
La rivoluzione capitalista e borghese verificatasi in tempi e modi diversi in Inghilterra, Francia, Stati Uniti ha avuto come condizione l’estinguersi della classe contadina: «la scomparsa della classe contadina significò infatti che la modernizzazione poté procedere in Inghilterra senza essere ostacolata da quel grosso serbatoio di forze conservatrici e reazionarie che si manifestarono in certi momenti dello sviluppo in Germania e in Giappone, per non parlare dell’India. Così venne inoltre eliminata dal novero delle possibilità l’eventualità di una rivoluzione contadina sul tipo russo o cinese» (pag. 34). Anche in Francia l’alleanza tra borghesia e contadini giocò a favore della prima e negli Stati Uniti non esisteva una radicata tradizione rurale. Insomma, «sbarazzarsi dell’agricoltura come attività sociale fondamentale costituisce uno dei prerequisiti per il successo della democrazia» (484).
In Asia furono tre le vie verso l’industrializzazione: la rivoluzione contadina in Cina; l’alleanza fra élite rurali e urbane in Giappone (che, come in Germania, condusse al fascismo); il caso atipico dell’India, in cui l’assenza di qualsiasi rivoluzione dall’alto o dal basso ha prodotto una forma instabile di democrazia.
In ogni caso, la struttura portante della storia è la violenza: «attraverso tutta la storia conosciuta, la sorte comune a tutte le società umane è stata quella di essere teatro di lotte, scontri, contrasti, appropriazioni violente, accompagnate da molta ingiustizia e molta repressione» (150). Barrington Moore rifiuta di legittimare questa violenza universale ma respinge anche ogni sua demonizzazione e osserva come il carattere «pacifico» della Rivoluzione inglese derivi in realtà dalla violenza esercitata nel periodo precedente; come l’aver evitato una rivoluzione abbia favorito il fascismo giapponese; come la pace sociale e la sottomessa docilità delle masse indiane sia causa di enorme miseria e di stermini apparentemente naturali ma in effetti ben radicati nella struttura sociale e nella storia dell’India. In definitiva, «la conclusione a cui sono mio malgrado dovuto giungere in seguito all’esame dei fatti è che i costi della moderazione sono stati almeno altrettanto atroci di quelli della rivoluzione, forse anzi molto di più» (570).
Moore osserva che il potere non si limita a costituire l’inevitabile strumento di convivenza tra interessi differenti ma sia sempre anche una struttura criminale e oppressiva, in ogni caso al servizio di alcuni gruppi contro altri. Ad esempio, «il contributo arrecato dall’aristocrazia alla concezione e alla realizzazione di una società libera è stato perciò pagato a un prezzo sociale spaventoso» (552). L’Autore è, in generale, convinto che molti progressi politici -verso la libertà- e sociali -verso l’industrializzazione- siano sempre pagati dai gruppi più poveri e diseredati e comportino un notevole peso di costrizione. La storia umana presenta, così, anche un carattere tragicamente ironico: «una volta di più essi [i contadini cinesi] costituirono la forza principale per portare alla vittoria un partito che si pone l’obiettivo di realizzare con l’uso spietato del terrore una fase della storia, che esso ritiene inevitabile, in cui la classe contadina cesserà di esistere» (253).
Nella sua Presentazione, Luciano Gallino ben evidenzia la grande originalità di questo testo ormai classico negli studi storico-sociali, il suo porsi al di là di schemi consolidati. Le tesi di Moore costituiscono uno «stimolo irritante per ogni occhio di tipo ideologico» (X), il loro muoversi in direzione «dell’ideale della società decente, concretamente possibile a un certo grado di evoluzione storica, […] distinto e opposto a quello di società ottima -inevitabilmente sfociante in qualche forma di persecuzione» (XII).
I decenni che ci separano dal libro hanno reso il progetto di una società decente, «intesa come una società senza guerra, povertà e grossolane ingiustizie» (XII), un ideale di per se stesso rivoluzionario e assai difficile da raggiungere. Moore non difende i grandi racconti ideologici della modernità -liberalismo, comunismo- ma neppure la conservazione delle condizioni attuali (e sempre peggiori) di vita collettiva. E offre con questo un’indicazione metodologica di grande onestà scientifica ed etica: «per tutti gli studiosi di scienze umane la simpatia per le vittime del processo storico e lo scetticismo verso le pretese dei vincitori costituiscono una salvaguardia essenziale contro il pericolo di lasciarsi abbindolare dalla mitologia dominante» (590).
Roy Lichtenstein.
Meditations on Art
Milano – Palazzo della Triennale
Sino al 30 maggio 2010
Molto, molto più che Pop Art. Un uomo ironico e colto assorbe una grande varietà di ispirazioni e di temi ma poi li ricrea mediante la consapevolezza profonda del proprio fare: «Io tento sempre, in un certo senso, di cancellare il “significante” dell’originale», affermò Lichtenstein, in questo modo trasformando la sua copia in un originale. Al Cubismo -in particolare Legér e Picasso- sottrae le ombre e ne fa dunque pura pittura, lontana dalla plastica; del Futurismo intensifica il rapporto tra tempo e movimento, ripensando Carrà in un grande dipinto dal titolo The Red Horseman (1974); la cattedrale di Rouen dipinta da Monet in tre differenti ore del giorno diventa un gioco di ombre su ombre, visibile soltanto a distanza, poiché -spiegò- «il mio lavoro non riguarda la forma. Riguarda la vista»; la pittura degli Indiani pellerossa è restituita con grande rispetto; la classicità greca ritorna nella serie “Entablature” degli anni Settanta, nello splendido Cosmology, nel Laooconte; col Surrealismo la consonanza è forse più immediata ma gli esiti sono assai più lievi; Mondrian sembra particolarmente presente nella serie dei “Perfect and Imperfect Painting”, nei quali Lichtenstein cercò «di fare un quadro astratto completamente privo di scopo»; le numerose “Still Life” costituiscono un profondo rinnovamento di uno dei soggetti più antichi. Ma è negli ultimi dipinti ispirati all’arte giapponese che questo artista raggiunge una purezza e una bellezza struggenti. Vista with Bridge e Tall Mountains (entrambi del 1996, un anno prima della morte) coniugano il vuoto/silenzio dell’Oriente con l’inconfondibile “stile Lichtenstein”. È un’emozione poter guardare questo estremo cenno del pittore all’enigma delle cose e della loro riproducibilità.
Milano – Palazzo Reale
Sino al 27 settembre 2009
Il giardino di Claude Monet a Giverny, le stampe giapponesi delle quali fu appassionato collezionista, le fotografie quasi indistinguibili dalle stampe, la foto di Nadar che ritrae lo sguardo dell’artista come fosse scolpito, un filmato che lo vede al lavoro. E ovunque, nelle sale di Palazzo Reale, la vibrazione delle forme e dei colori, le ninfee come segno e promessa di un segreto che sta nella luce e nell’occhio che la assorbe. L’artista scrisse che «tutti i miei sforzi sono volti a realizzare il maggior numero possibile di immagini intimamente collegate a realtà sconosciute». Un dipinto dal titolo Glicine (1919-20) sembra finalmente cogliere e restituire le sfumature più intime della realtà e dello sguardo, della sintesi attiva che la mente compie sul mondo.
E sono soprattutto le quattro versioni qui presenti del Ponte giapponese a esprimere l’identità profonda della materia con la percezione/visione. In questi dipinti la figura si frantuma e si dissolve progressivamente in impressione pura del colore. A proposito delle sue ninfee, Monet disse una volta a Thiébault-Sisson che «l’effet, d’ailleurs, varie incessamment. Non seulement d’une saison à l’autre, mais d’une minute a l’autre, car ces fleurs d’eau sont loin d’être tout le spectacle; elles n’en sont, à vrai dire, que l’accompagnement. L’essentiel du motif est le miroir d’eau dont l’aspect, à tout instant, se modifie grâce aux pans de ciel qui s’y reflètent, et qui y répandent la vie et le mouvement. Le nuage qui passe, la brise qui fraîchit, le grain qui menace et qui tombe, le vent qui souffle et s’abat brusquement, la lumière qui décroît et qui renaît, autant de causes, insaisissables pour l’œil des profanes, qui transforment la teinte et défigurent les plans d’eau» («Les Nymphéas de Claude Monet», Revue de l’Art, luglio 1927, p. 44).
Milano – Palazzo Reale
Sino al 2 giugno 2009
Come nel momento della lotta altri animali cercano di apparire più alti e più forti di quel che sono -rizzando il pelo o aprendo le piume- così gli umani hanno inventato elmi, mostrine, corazze, divise e tutto quel sistema d’abbigliamento utile per la guerra, per vincerla. Le armature dei bushi sono esempi eccezionali di questo vestirsi per la guerra e -più in generale- per il comando.






