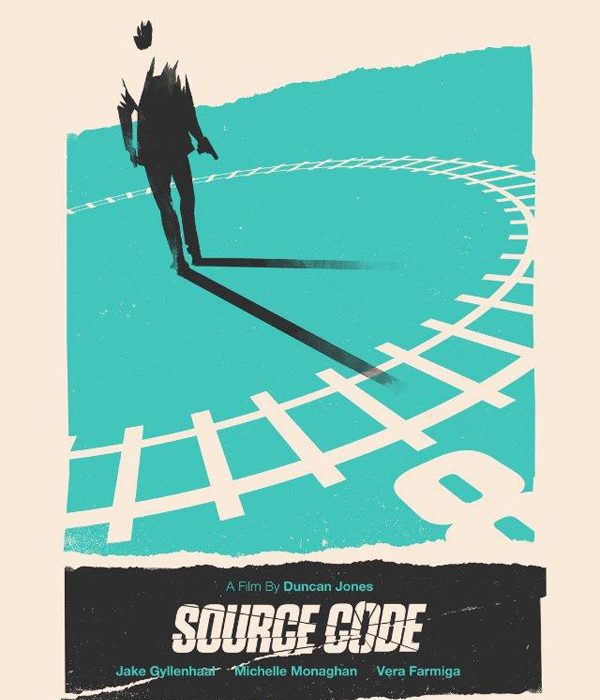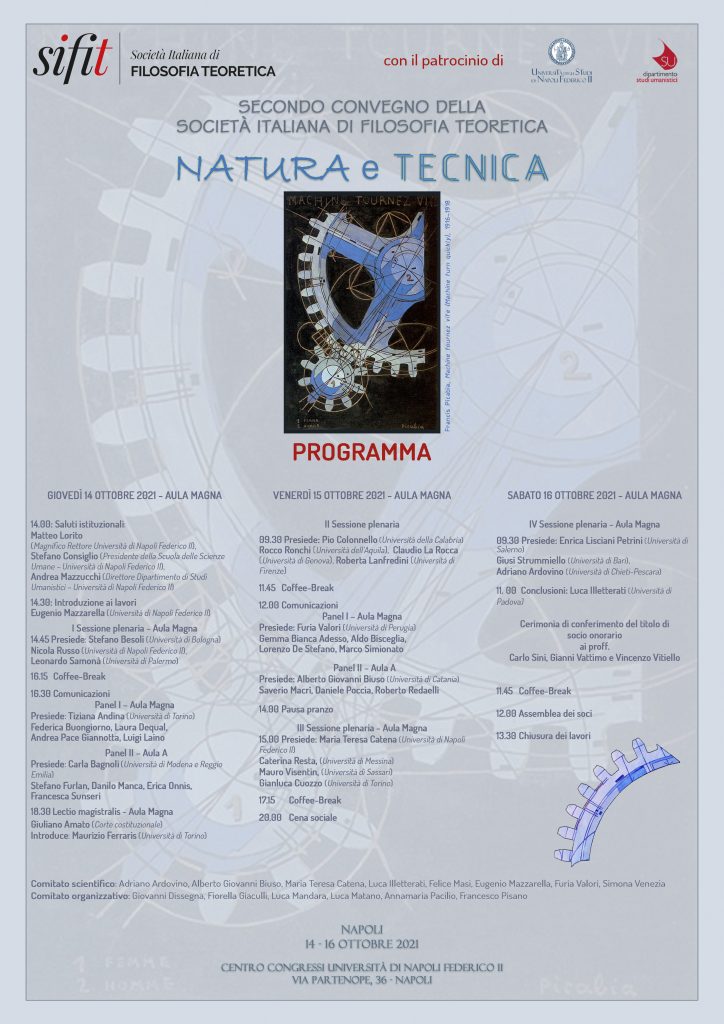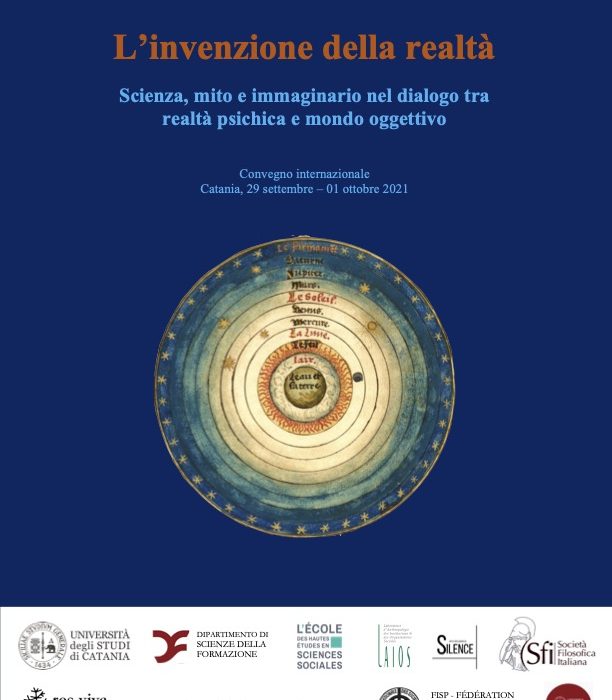[Ho scritto questo articolo, uscito ieri su Aldous, insieme ad alcuni amici che sono anche colleghi. Un professore non filosofo che lo ha avuto in anteprima mi ha risposto che anche lui aveva «letto con raccapriccio il tanto banale quanto arrogante testo […] (che francamente mi ricorda i 150 del Mucchio Selvaggio contro Jack Beauregard nel mitico film “Il mio nome è Nessuno”)». Questo il link alla scena ricordata dal collega 🙂 ]
Bullismo filosofico
Aldous, 17 ottobre 2021
Se gli oltre cento estensori del piccolo manifesto dal titolo Non solo Agamben avessero scritto un testo a favore delle politiche governative italiane sul Covid 19, a favore del lasciapassare sanitario, sarebbe stato un documento legittimo, per quanto non condivisibile. E invece hanno voluto attaccare in tanti una sola persona, un filosofo italiano molto noto, con argomenti -rispetto alla complessità delle tesi di Giorgio Agamben– sinceramente imbarazzanti. Ma la cosa grave non è il merito della questione, la cosa grave è il rivolgersi contro una persona priva di potere politico e accademico indicandola alla pubblica riprovazione. Un atto di bullismo, di violenza organizzata. Hanno formulato solo un nome, quello di Agamben appunto, e non – ad esempio – quello di Massimo Cacciari, che insieme ad Agamben ha redatto e pubblicato un documento che stigmatizza la logica, le radici, le implicazioni del green pass sanitario.
Forse perché Cacciari ha un potere mediatico e accademico che Agamben non possiede? Forse perché un documento senza nomi sarebbe stato in gran parte ignorato mentre il nome di Agamben, internazionalmente noto, attira l’attenzione di molti? Si tratta quindi di un atto di bullismo che ha come motivazione un fatto di marketing, di ascolto, di eco mediatica?
Un atto di bullismo condotto poi con ‘argomentazioni’ degne dei luoghi più culturalmente deprivati della Rete. Al centro del documento, ripetuto addirittura per due volte, c’è il paragone del lasciapassare sanitario con la patente di guida. Vale a dire si argomenta con serietà che una competenza tecnica precisa e circoscritta, il guidare un’automobile, sia la stessa cosa di un lasciapassare relativo all’inoculazione nel corpo di un vaccino. Ma non è neppure questo il punto centrale. Si pongono sullo stesso piano il divieto di guidare senza patente e il divieto di utilizzare treni e aerei; di frequentare concerti, cinema, musei, biblioteche, ristoranti, corsi universitari; il divieto soprattutto di lavorare, di esercitare cioè un diritto fondamentale, e quindi di vivere, di sopravvivere, di esistere. Vivere non è qualcosa di più ampio del guidare un’automobile? Qualcosa di più originario, fondante, essenziale? Un riduzionismo ‘automobilistico’ grave se adottato da chiunque, incredibile se sostenuto da professori universitari.
I filosofi firmatari non sono capaci di argomentazioni più profonde, più sottili, più inscritte nella complessità del mondo? Non solo: nel documento si afferma che i filosofi critici verso il green pass «rappresentano soltanto il loro punto di vista su questi temi». E che cos’altro dovrebbero rappresentare? Forse la verità assoluta della quale invece gli estensori del documento si ritengono evidentemente i portatori? Per loro non vale il fatto che ciò che hanno scritto rappresenti «il loro punto di vista su questi temi»?
Logiche e atteggiamenti escludenti come quelli che emergono da quelle righe non descrivono la complessità del mondo. La vita individuale e le esistenze collettive sono composte da sfumature, accenti, molteplicità. Da quel povero testo emerge una grande superficialità, che è un limite imperdonabile per chi si definisce filosofo.
Pierandrea Amato – Alberto Giovanni Biuso – Roberta Lanfredini – Davide Miccione – Valeria Pinto – Nicola Russo
[Versione in pdf dell’articolo]
Il testo è stato pubblicato anche su:
Corpi e politica
Girodivite.it
Il lavoro culturale (sottotitolo: Per un altro stile della critica filosofica: mai 100 contro 1)
Carmilla (con il video dell’audizione di Agamben al Senato)
Sinistra in Rete