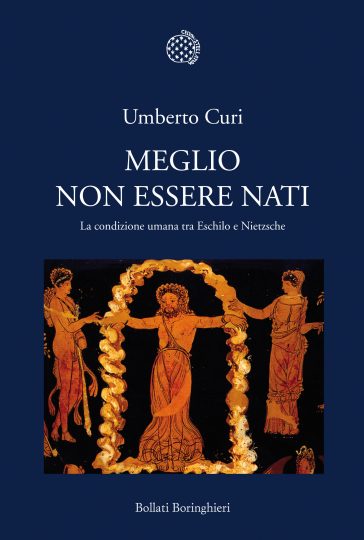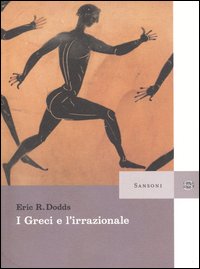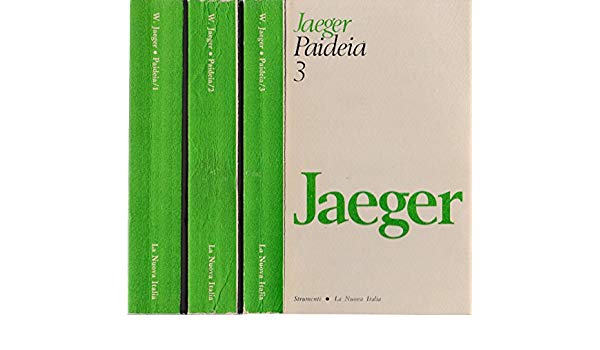
Platone sta al centro della seconda tappa dell’itinerario di Werner Jaeger (1888-1961) dentro la forma-uomo ellenica. L’analisi delle opere della «più grande personalità di educatore apparsa nella storia del mondo occidentale» (Paideia. La formazione dell’uomo greco. II Alla ricerca del divino, trad. di A. Setti, La Nuova Italia, 1978, p. 40) permette di penetrare a fondo nella complessità dell’antropologia greca. Essa si fonda sull’assunzione della natura come norma e direzione dell’esistere di ogni ente. L’avventura umana consiste nell’aprire lo spazio di massima libertà consentito dalla struttura finita perché biologica della specie. Solo così si comprendono gli importanti legami e debiti di Platone con la medicina greca. Egli trovò la soluzione più originale al problema che muoveva tutta la cultura arcaica e che ha in Eschilo la sua espressione più chiara: l’uomo che erra lo fa perché indotto dagli dèi e tuttavia non per questo la sua colpa è meno grave. Platone contrappone alla forza di Ate la paideia, che ha come «presupposto la libertà della scelta, laddove il potere del demone appartiene al regno della necessità» (643). È qui che nasce l’individuo europeo e cioè la forma umana che oppone alla comunità, allo Stato, a Dio la propria irriducibilità di singolo. A coloro, come Popper, che guardano con occhi moderni e prevenuti il progetto platonico, va quindi ricordato che «se lo Stato disegnato da Platone è Stato autoritario, ciò non deve però farci dimenticare che la sua fondamentale esigenza –inattuabile nella realtà politica- di fare della verità filosofica l’istanza suprema del potere, scaturisce in realtà da un immenso valore dato alla libera personalità spirituale, non già da un disconoscimento di un tale valore» (471-472).
Il fatto è che si sbaglia completamente prospettiva se si guarda al Platone politico separandolo dall’educatore, come anche viceversa. La centralità dell’impulso educativo da cui muove tutta la filosofia platonica è una cosa sola con l’esigenza di trovare una risposta al problema del potere. Fra individuo e comunità, società e psiche, Platone -come Socrate- instaura una dinamica di reciproca dipendenza per la quale l’uomo equilibrato può crescere solo sul terreno di una società giusta e questa è a sua volta frutto della giustizia nella coscienza del singolo. «Realizza il vero Stato nella tua psyché» (Repubblica 592 A-B) è il finale invito di Platone, con il quale l’unità arcaica fra il singolo, la famiglia, il clan, la polis, si spezza definitivamente.
Nonostante tutta l’importanza che attribuisce all’educazione, Platone «non crede alla uguaglianza meccanica dei suoi risultati, ma fa molto conto delle differenze individuali di temperamento» (404), sa che una precondizione è l’armonia tra intelletto e carattere; inserisce il fatto educativo nella più vasta dimensione sociale, ritenendo responsabili del successo o del fallimento l’intera comunità e non soltanto gli educatori; rifiuta sia la mera costrizione autoritaria come la riduzione del sapere a un gioco; è convinto, infine, con Socrate, che «l’educazione vera è il risvegliare facoltà che nell’anima sono sopite» (512). Proprio per tutto questo, la paideia si rivolge soltanto a coloro che promettono un qualche esito positivo e non a tutti indistintamente. Solo la prontezza nel capire, delle buone doti mnemoniche e specialmente una vera e propria avidità di sapere, richiedono e permettono la paideia. La selezione è quindi un prerequisito della pedagogia platonica, in modo che –al di là delle differenze di nascita, di classe e di sesso- sia la capace intelligenza della persona il criterio di un’educazione giusta.
Qualunque cosa si pensi della terapia platonica, la diagnosi è di grande verosimiglianza. La sua attualità dipende anche dalla perennità della natura umana, alla quale Platone riconosce la possibilità di cogliere il divino ma anche quella di albergare in sé un male profondo che solo la paideia può contenere. Anche per Platone, come per Nietzsche, l’ordine e la razionalità degli Elleni si ergono su uno sfondo di violenza e di furia. Per entrambi al centro sta il sapere, una scienza gaia, poiché «la conoscenza del significato delle cose è anche la forza creatrice che tutte le guida e le ordina […] e trasforma in un valore positivo tutto ciò che è vita, anche quello che sta ai confini oltre i quali il pericolo comincia» (297 e 306).
Il filosofo al potere -un progetto intessuto di convinzione profonda e di rassegnata malinconia- non ha quindi nulla di autoritario e neppure di professorale. Il filosofo è l’uomo formato nella paideia.
[Sul primo volume dell’opera: Educare
Sul terzo volume dell’opera: «Quell’antica luce risplende ancora»]