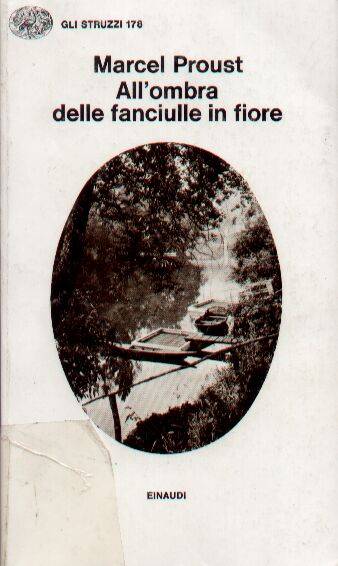Piccolo Teatro Grassi – Milano
Pornografia
(1960)
di Witold Gombrowicz
Con: Riccardo Bini (Witold), Paolo Pierobon (Federico), Ivan Alovisio, Jacopo Crovella, Loris Fabiani, Lucia Marinsalta, Michele Nani, Franca Penone, Valentina Picello, Francesco Rossini
Traduzione di Vera Verdiani
Scene di Marco Rossi
Regia di Luca Ronconi
Sino al 5 aprile 2014
 Un romanzo, Pornografia di Gombrowicz, dai molti strati, dai numerosi enigmi. Ronconi lo trasforma in un’azione teatrale nella quale gli attori raccontano i personaggi, descrivono quello che fanno mentre lo fanno. Non soltanto Witold, colui che nel romanzo dice ‘io’, ma anche tutti gli altri. Si raccontano mentre «si comportano» per «non fare altro», mentre parlano allo scopo quasi sempre «di non dire qualcos’altro», mentre sono spesso a terra, striscianti come il verme protagonista di una scena chiave dove amore e morte ancora una volta si accompagnano e si fondono.
Un romanzo, Pornografia di Gombrowicz, dai molti strati, dai numerosi enigmi. Ronconi lo trasforma in un’azione teatrale nella quale gli attori raccontano i personaggi, descrivono quello che fanno mentre lo fanno. Non soltanto Witold, colui che nel romanzo dice ‘io’, ma anche tutti gli altri. Si raccontano mentre «si comportano» per «non fare altro», mentre parlano allo scopo quasi sempre «di non dire qualcos’altro», mentre sono spesso a terra, striscianti come il verme protagonista di una scena chiave dove amore e morte ancora una volta si accompagnano e si fondono.
I due protagonisti -Witold e Federico- vivono un soggiorno nella campagna polacca mentre intorno infuria la guerra. Loro sono concentrati sulla figlia dell’amico che li ospita e sul ragazzo al loro servizio. Vorrebbero che i due si amassero, si unissero, copulassero. E invece Enrichetta e Carlo mostrano reciproca indifferenza. Il parossismo del desiderio induce Federico e Witold non soltanto a guardare ma anche a costruire situazioni che favoriscano il loro obiettivo. Non li ferma l’arrivo di Venceslao, fidanzato di Enrichetta, di Amelia -madre di lui e donna «cattolica e di alti sentimenti morali»- di un partigiano in crisi, di un giovane ladro che uccide Amelia. Anzi. Ogni evento è inserito in una trama nella quale i due vivono e proiettano la loro potenziale ma evidente omosessualità. Si sentono gli echi del desiderio che muove von Aschenbach in Morte a Venezia, la frenesia che anima Bouvard e Pécuchet, la guerra antieroica e grottesca della Trilogia del Nord celiniana, il modello classico di Aminta.
Il semplice vedere, l’aprire gli occhi e guardare, è in sé pornografico perché l’umano (come ogni altro animale) è una macchina del desiderio che trova nell’eros il culmine del tempo destinato alla vita di ciascuno. In una pagina del suo Diario Gombrowicz scrisse che il vero problema della nostra specie non è la morte ma è «l’invecchiare, questa forma di morte che sperimentiamo ogni giorno. E non tanto l’invecchiare in sé, quanto il fatto di essere così completamente, così terribilmente tagliati fuori dalla bellezza. Quello che ci disturba non è che stiamo morendo, ma che il fascino della vita ci diventi inaccessibile. Al cimitero ho visto un ragazzo che camminava fra le tombe come una creatura di un altro mondo, misteriosa, rigogliosamente in fiore, mentre noi sembravano dei mendicanti» (1953; cit. nel Programma di sala, p. 23). Creatura intessuta di un tempo che appare infinito ma che può anche di botto sparire non nella morte ma nella trasformazione del desiderio in vita, in generazione, in figli. Gombrowicz lo dice con chiarezza: «La bellezza e la gioventù non dovrebbero essere qualcosa di gratuito e di fine a se stesso, un meraviglioso dono della natura, una specie di coronamento? E invece, nella donna, il fascino serve a generare, è foderato di gravidanze e pannolini e la sua massima realizzazione comporta un figlio che segna la fine del poema. Un ragazzo, incantato da una ragazza e da se stesso con lei, non fa in tempo a toccarla che è già padre e lei -madre; quindi la ragazza è una creatura che sembra praticare la gioventù, ma in realtà serve solo a liquidarla» (1954; ivi, p. 25). È la verità. È la negazione del presente in vista di un futuro altrui. È la «liquidazione» della bellezza a favore della generazione di qualcosa che a sua volta diventerà funzionale ad altra carne senza senso.
La corporeità metafisica che intesse Pornografia è anche un modo di affrancamento dal ciclo del nascere e del morire, per diventare il presente nel quale converge il tempo/ora, il Καιρός.