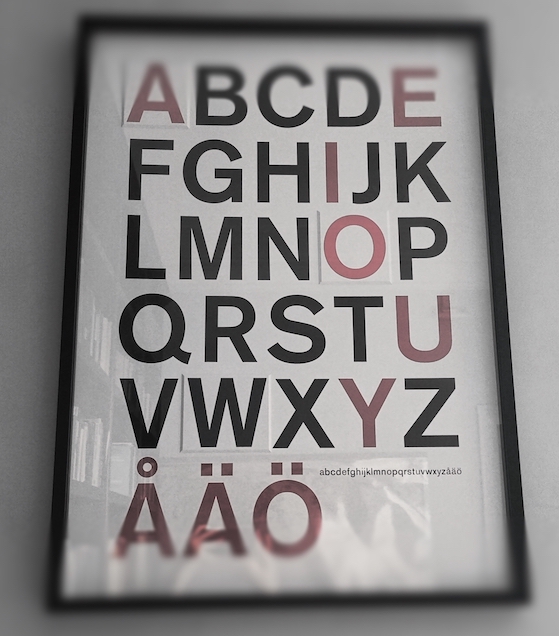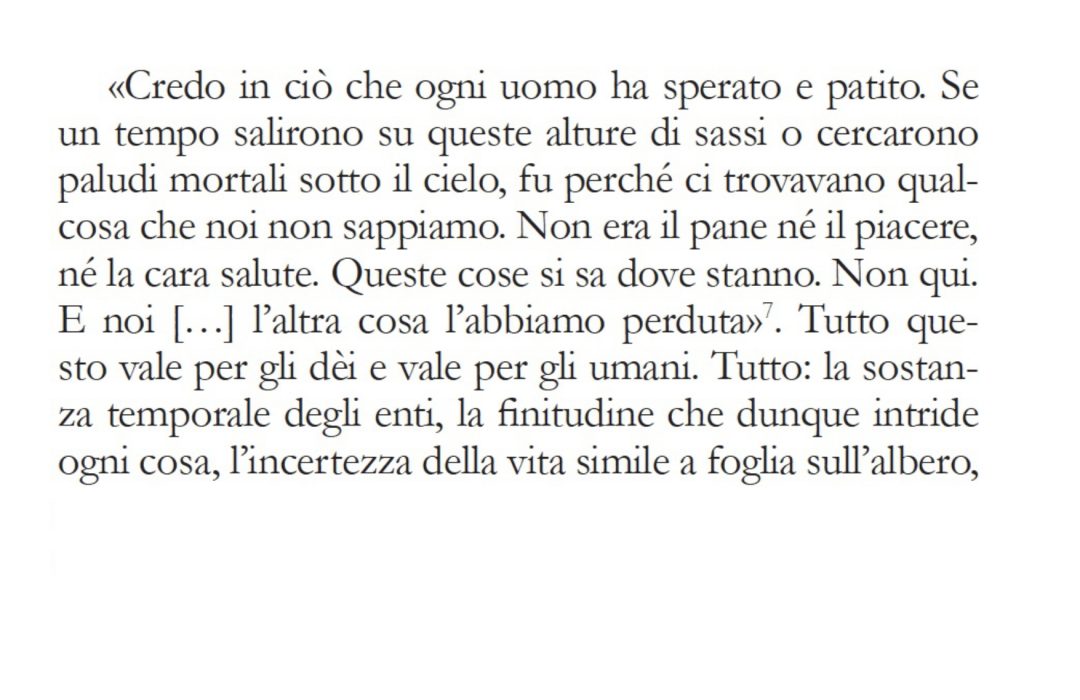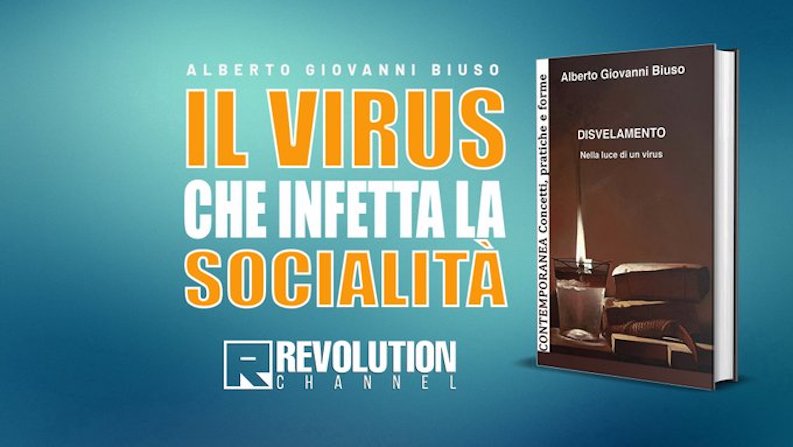Sarah Dierna
– Dopo il Covid. Ripensare la vita e accettare la morte
Recensione/riflessione dedicata (anche) a Disvelamento. Nella luce di un virus
in Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre-ottobre 2022
pagine 205-209
– Recensione a Mario Graziano (a cura di), Filosofi in ciabatte. Divagazioni filosofiche ai tempi del Coronavirus
Corisco Edizioni, Roma-Messina 2020, pagine 206
in Discipline Filosofiche, 30 settembre 2022
[Da Dopo il Covid]
«Come ogni libro, anche questo può essere letto secondo prospettive diverse; è un libro di sociologia, se per sociologia intendiamo lo studio dei corpi collettivi; è un libro di politologia, se con politologia assumiamo lo studio dialettico del potere e delle sue manifestazioni; è un libro di antropologia se con antropologia rimandiamo allo studio dell’umano come individuo e come parte di una comunità; è tutto questo insieme e cioè un libro di filosofia. […]
A sparire sono stati i cittadini – Biuso parla di una primavera senza i corpi – ma non le televisioni che, con un palinsesto ormai ripetitivo e indifferenziato, hanno contribuito al dilagare di un’infodemia riduttivistica e talvolta persino inesatta ottenendo come unico scopo il plasmarsi e l’accrescersi di un’atmosfera apocalittica. […]
C’è in Biuso una conclusiva nota di fiducia che tutto questo finirà. Finirà sicuramente l’epidemia da Sars-Covid19, riconquisteremo la vita a cui con costrizione o collaborazione ci siamo sottratti, ma resterà sempre prossima la possibilità di rinunciarvi finché non comprenderemo davvero in cosa consista la vita, finché non accetteremo davvero la finitudine. Senza comprendere la prima non la vivremo mai in tutte le sue dimensioni. Senza accettare la seconda non la vivremo invece con pienezza e totalità».
[Da Divagazioni filosofiche]
«È proprio questa regressione all’età infantile ad avere favorito l’estendersi di forme di paternalismo, che sembravano confinate al mero ambito medico, al più complesso sistema politico. A ben guardare, lo Stato è partito proprio da quel paternalismo sanitario per ottenere un controllo poi totale nella vita delle persone. […]
A questa stessa autonomia e ‘solitudine’ dovrebbe ritornare anche la scienza – vittima e carnefice di questa situazione – prostituita invece agli interessi di una classe dirigente che l’ha resa di nuovo positiva – nel senso di positum – con il suo attaccamento al cosiddetto mito del dato, e infalsificabile, atteggiamenti questi che l’epistemologia ha da tempo ormai superato. […]
Se i filosofi in ciabatte sono coloro che hanno visto tutto questo quando l’epidemia era al suo sorgere, diremo allora che essi non sono semplicemente quelli che, come l’Armchair Science sono stati confinati in casa, ma quelli che da casa hanno continuato a osservare il mondo senza lo schermo di un televisore, quelli che il reale hanno scelto di non ridurlo in ologramma. […]
Questo segna la differenza tra la chiacchiera e la filosofia: la prima si è dimenticata come pensare, la seconda non ha mai smesso di farlo».