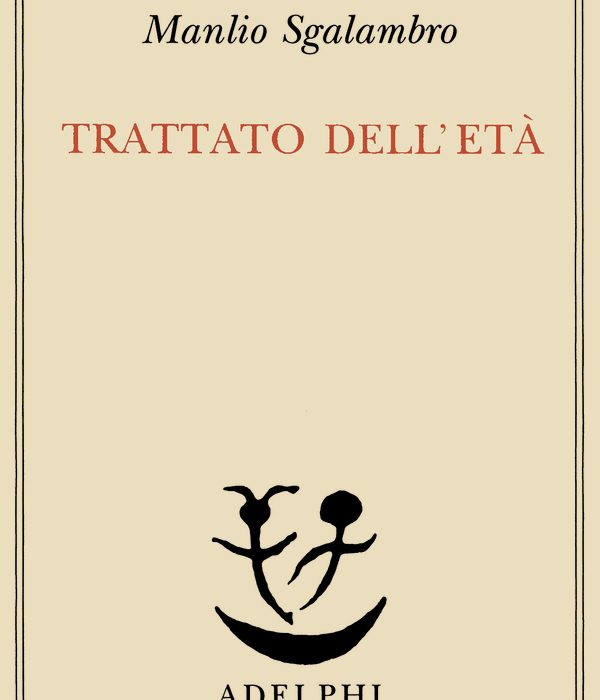Oppenheimer
di Christopher Nolan
USA, 2023
Con: Cillian Murphy (Robert Oppenheimer), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Emily Blunt (Katherine Oppenheimer), Matt Damon (Leslie Groves), Florence Pugh (Jean Tatlock), Benny Safdie (Edward Teller), Kenneth Branagh (Niels Bohr), Jason Clarke (inquisitore)
Trailer del film
Shakespeare (in particolare Riccardo III e Macbeth), Machiavelli (Il Principe), Canetti (Massa e potere) ci hanno mostrato che il potere è un fatto pervasivo e stratificato, evidente e complesso. Ma la sua sostanza non è difficile da cogliere: il potere è espressione e forma della dissoluzione, è radice sempre attuale dei bisogni animali della nostra specie, è raffinata giustificazione della violenza, è la brutale e penultima parola sugli eventi. Penultima perché l’ultima è la conoscenza che indaga sugli esiti del potere, come appunto in Skakespeare, Machiavelli, Canetti e in altri.
Nel Novecento c’è stato un momento (in verità assai lungo) nel quale il potere della filosofia/scienza, nella forma della fisica teorica, e quello politico conversero nella progettazione, realizzazione e utilizzo di un fuoco mai visto, devastante, accecante. Il fuoco generato dalla manipolazione umana del nucleo dell’atomo, fuoco che come onda inarrestabile e totale brucia, dissolve, cancella tutto ciò che incontra. E trasforma quanto di biologico gli sopravvive in un grumo senza fine di piaghe e di dolore.
L’unica potenza che sinora – 2023 – ha utilizzato contro altri stati e contro gli umani e i viventi tale fuoco sono gli Stati Uniti d’America, il 6 agosto 1945 dissolvendo Hiroshima, il 9 agosto cancellando Nagasaki.
Christopher Nolan racconta le origini di questa vicenda, il suo svilupparsi dentro un intrico fatto di carriere universitarie, di procedure e risultati scientifici, di innovazioni tecnologiche, di scommesse e di azzardi, di ambizioni politiche, di dismisura storica. Il presidente USA Harry Truman (del Partito Democratico, interpretato per pochi ma sufficienti minuti da uno straordinario e cinico Gary Oldman) al fisico Oppenheimer che afferma di sentire le mani grondanti di sangue, offre il suo fazzoletto per pulirsele e giustamente gli dice che «lei ha utilizzato la bomba a Los Alamos, non c’entra nulla con Hiroshima e Nagasaki. Le bombe le ho sganciate io».
Los Alamos (New Mexico) fu la sede principale del Progetto Manhattan, che ideò e realizzo gli ordigni nucleari. A guidare il progetto fu appunto Robert Oppenheimer (1904-1967), uno tra i maggiori fisici del Novecento, protagonista del primo esperimento atomico avvenuto il 16 luglio 1945, esplosione alla quale venne data una denominazione religiosa: Trinity.
Di questa persona e personaggio dalla natura complessa, riservata e narcisista, sfuggente, ambiziosa, sostanzialmente malata come quella di tutti i grandi criminali, il film narra la vicenda dagli esordi di studente ai successi scientifici, all’impegno strenuo per realizzare la bomba atomica, ai sospetti di militanza comunista che gli valsero un’umiliante inchiesta, alla collaborazione prima e all’odio implacabile poi da parte di Lewis Strauss, un altro ebreo e Presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti d’America. Gran parte del film è giocata sul canto/controcanto delle udienze dal cui esito a Oppenheimer venne revocata «l’autorizzazione di sicurezza», e dunque la possibilità di continuare a lavorare ai progetti scientifico-militari degli USA, e a Lewis venne negato di entrare come ministro nel governo del Presidente Eisenhower. La contrapposizione tra i due protagonisti è un’autentica lezione di ciò che di solito si intende con «machiavellismo».
Oppenheimer è un’opera sul potere ed è un’opera sulla morte. Un’opera epica nello stile, frenetica nel racconto (tre ore che scorrono senza che ci si renda conto), dinamica e complessa nella temporalità, come sempre in Nolan, a partire da Following (1998) e Memento (2000) sino a Tenet (2020). Un’opera radicale nell’indicare le origini di quello che sarà probabilmente il destino di gran parte del pianeta, forse in tempi non troppo lunghi: la distruzione per opera dell’energia atomica, della potenza inarrestabile della materia manipolata nel suo nucleo, degli ordigni termonucleari di cui sono pieni gli arsenali delle maggiori potenze politiche del presente.
Un’opera che coniuga la morte all’amore. Mentre si accoppia con lui, la giovane amante Jean chiede a Oppenheimer di leggerle alcuni versi di un libro in sanscrito che il fisico sta studiando. E le parole dicono: «Sono diventato morte, il distruttore di mondi». Frase che ritorna durante l’esplosione sperimentale del luglio 1945 a Los Alamos. Questo è il momento sublime del film, anche in senso kantiano: per circa due-tre minuti tace ogni suono e ogni musica (che accompagna invece in modo ossessivo tutta la vicenda), si fa improvviso silenzio, si vede di colpo e poi lentamente ampliarsi la scintilla del fuoco, salire, diventare fungo atomico, espandersi, illuminare, accecare, splendere. Tutto nel più assoluto silenzio e con i volti e i corpi dei fisici e dei militari stupefatti di fronte a tanta perturbante meraviglia.
Amore, potere, morte. Aver potuto sentire tutto questo recitato nella lingua originale di alcuni grandi interpreti ha dato ulteriore profondità alla visione di un’opera inquietante e omerica. Opera che è anche un altro omaggio di Nolan al suo modello Kubrick, il quale affermò che «la distruzione di questo pianeta sarebbe insignificante in prospettiva cosmica. […] Non ci sarà nessuno a piangere una razza che usò il potere che avrebbe potuto mandare un segnale di luce verso le stelle per illuminare la sua pira di morte»1.
Non ci sarà nessuno.
Nota
1. In Enrico Ghezzi, Stanley Kubrick, Il Castoro Cinema 1995, p. 12.