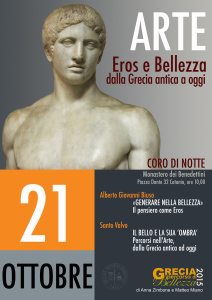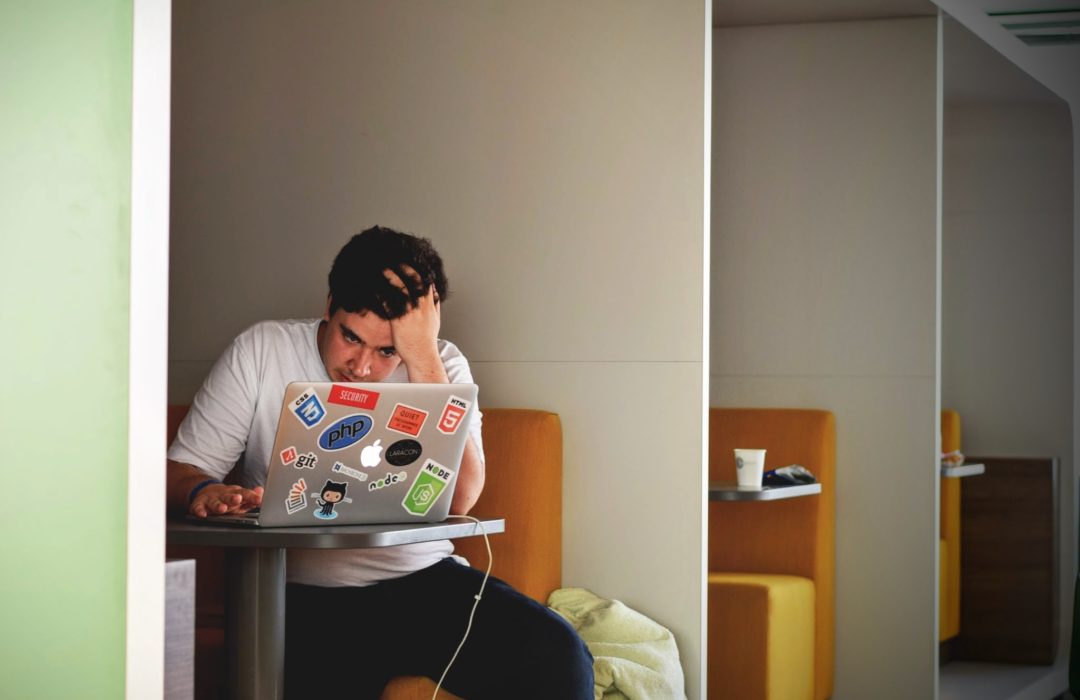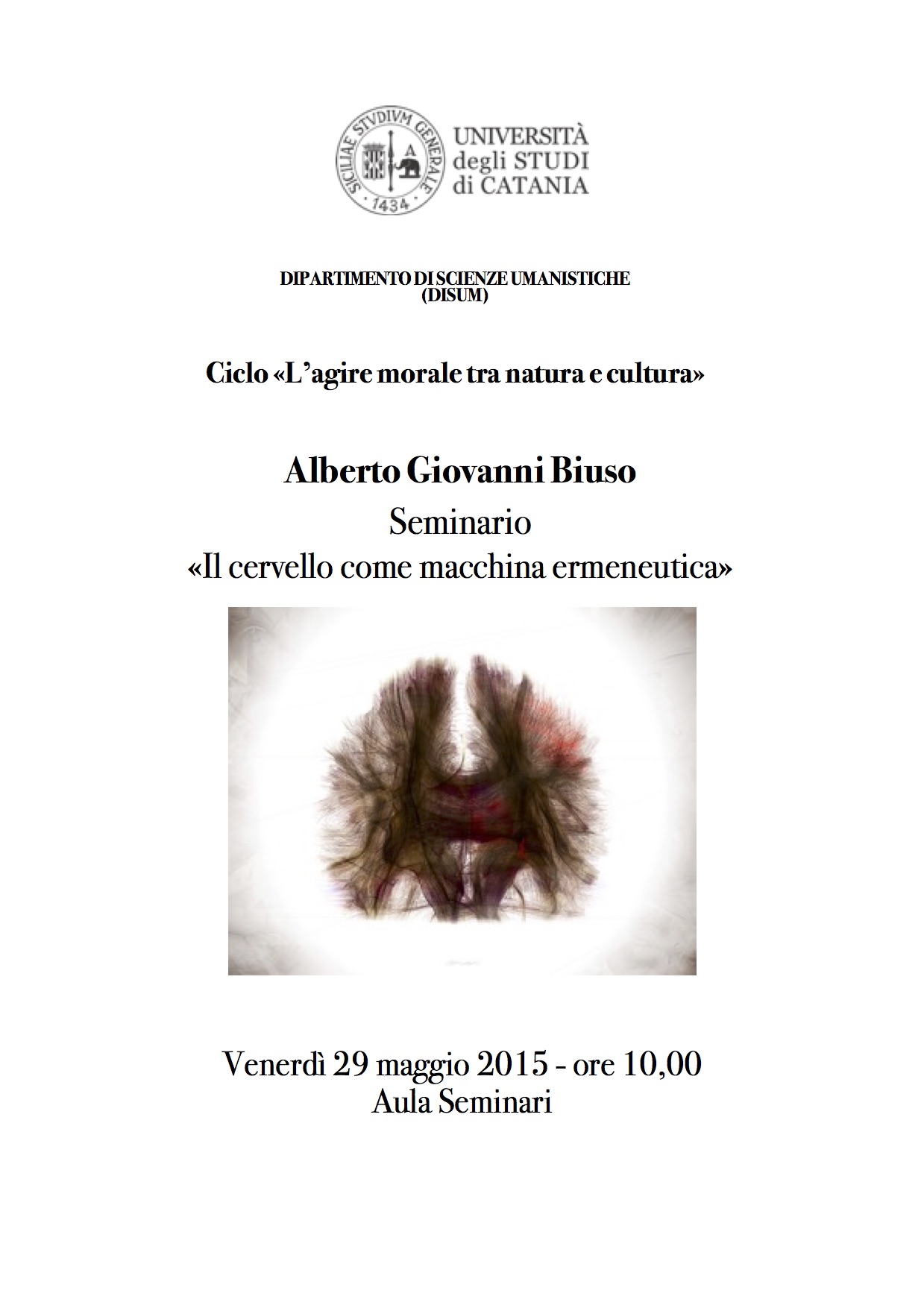Mente & cervello 130 – ottobre 2015
 La ‘scientificità’ della psicologia è assai scarsa, anche se molti psicologi pretendono che sia loro riconosciuta un’autorità simile a quella dei fisici, o almeno dei biologi: «Meno della metà di 100 studi di psicologia, pubblicati nel 2008 su tre riviste di primo piano, ha retto alla prova della replicazione. […] Anche in questi, poi, l’entità degli effetti trovati era in media della metà rispetto allo studio originale» (G.Sabato, p. 19). Si tratta, insomma, di una scienza umana a tutti gli effetti.
La ‘scientificità’ della psicologia è assai scarsa, anche se molti psicologi pretendono che sia loro riconosciuta un’autorità simile a quella dei fisici, o almeno dei biologi: «Meno della metà di 100 studi di psicologia, pubblicati nel 2008 su tre riviste di primo piano, ha retto alla prova della replicazione. […] Anche in questi, poi, l’entità degli effetti trovati era in media della metà rispetto allo studio originale» (G.Sabato, p. 19). Si tratta, insomma, di una scienza umana a tutti gli effetti.
Tra i testi di psicologia, uno dei più noti è Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza (1983). Delle otto principali forme di intelligenza descritte e analizzate da Howard Gardner -e che possederemmo tutte, anche se ciascuno in modo assai differenziato- «sotto l’influenza del nostro bagaglio genetico, della cultura, delle nostre esperienze e della nostra storia personale abbiamo sviluppato alcune dominanze o preferenze che si manifestano attraverso la nostra personalità, le scelte di vita e il nostro stile di apprendimento» (G.Sirois, p. 30). Questo significa anche che l’interazione tra la mente e il mondo è completa e profonda.
Lo conferma una tesi di Heidegger sul linguaggio, secondo la quale si abita in una lingua come si vive in un mondo. Mutare lingua significa dunque cambiare la modalità e le forme del nostro esserci. Un cambiamento che arriva a toccare gli stessi principi morali. Sembra infatti che le valutazioni sui comportamenti espresse in una lingua ben posseduta ma diversa dalla lingua madre siano piuttosto differenti rispetto a quelle pensate e comunicate in quest’ultima: «I bilingue a volte usano la lingua materna quando vogliono sentire appieno l’impatto di un argomento, e passano invece all’altra lingua per distanziarsene emotivamente», poiché «l’effetto lingua straniera trae la sua influenza dal retroterra etico della cultura cui ciascuna lingua si riferisce» (C. Caldwell-Harris, 84).
Differenze, varietà, molteplicità, rendono del tutto illusoria ogni gerarchia tra gli enti e dunque tra i saperi e i loro linguaggi, poiché non esiste «una specie di scala del progresso, che culmina in Homo sapiens. Si tratta di un assunto scientificamente insostenibile, che contraddice ciò che da tempo sappiamo, e cioè che non esistono scale dei viventi, ma ramificazioni nel cespuglio evolutivo» (A.R. Longo, 104).
L’antica intuizione di Senofane, sulla comunanza di tutte le specie nel mondo, viene confermata di continuo. Soltanto lo stolto antropocentrismo di alcune filosofie e di molte religioni può sostenere la superiorità ontologica della materia umana rispetto alla materia tutta.