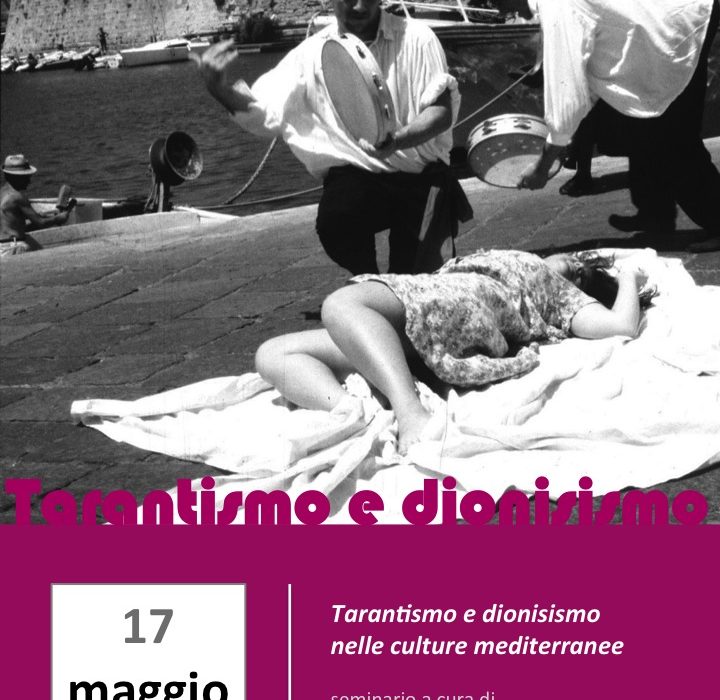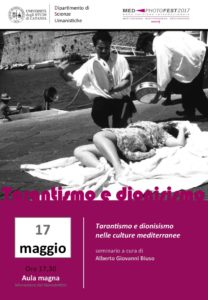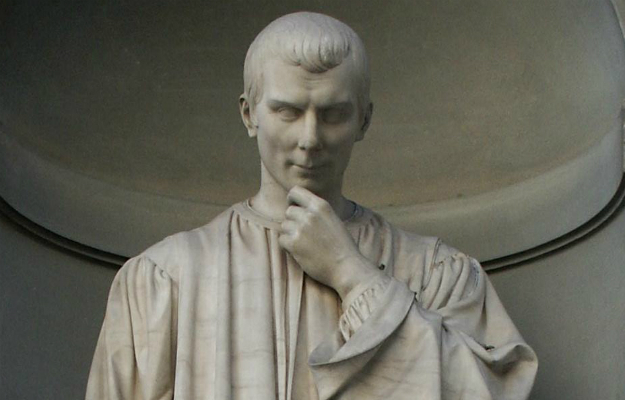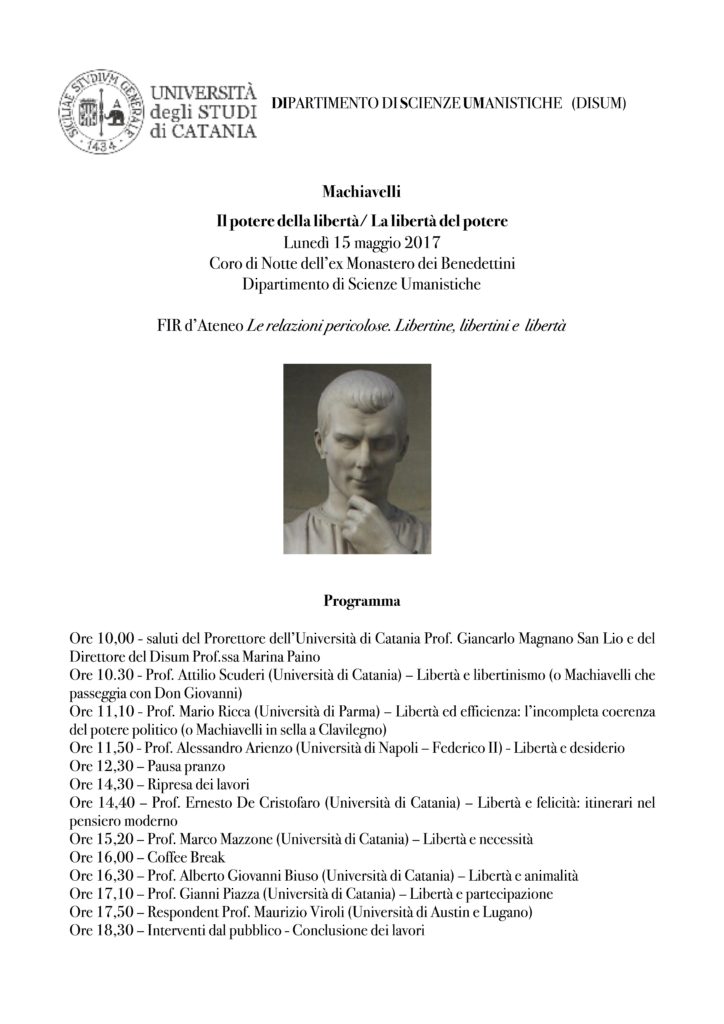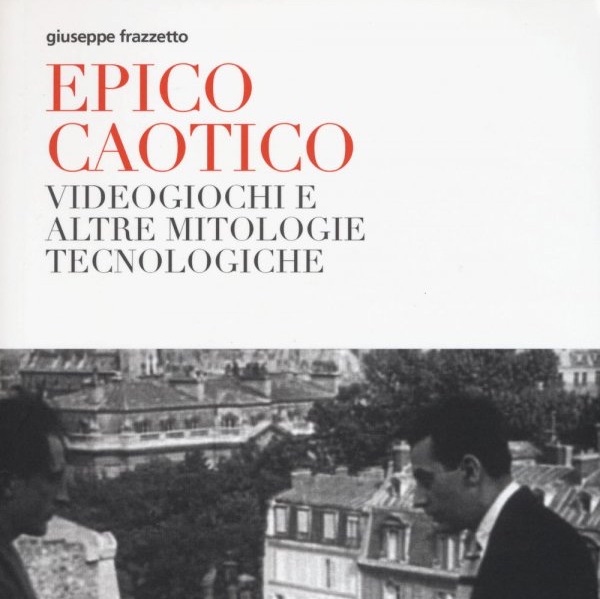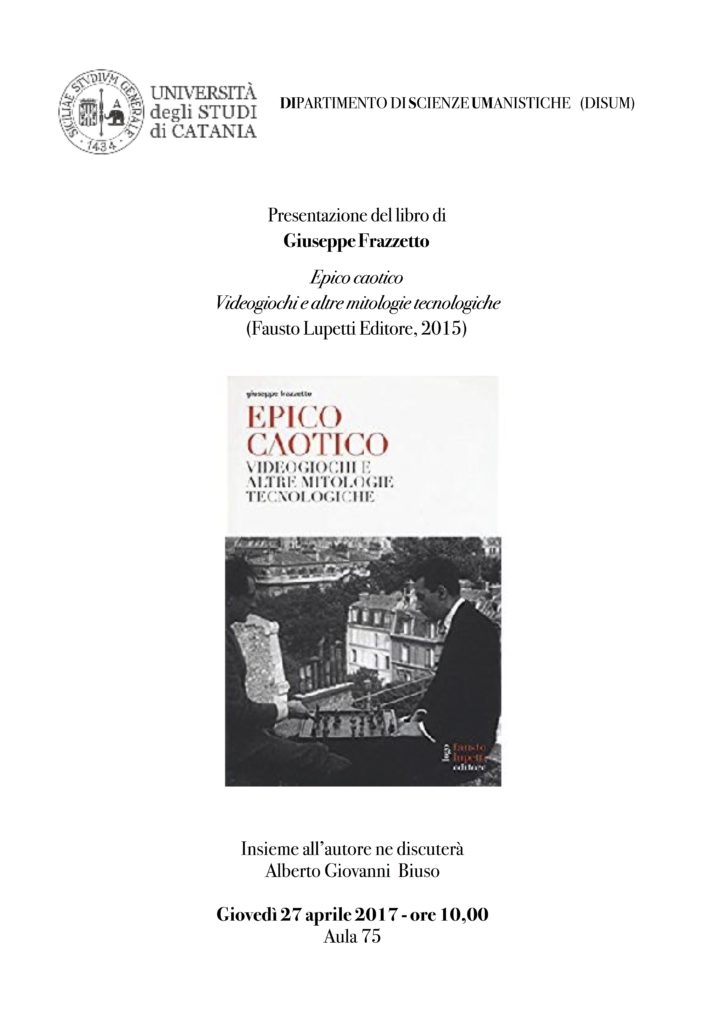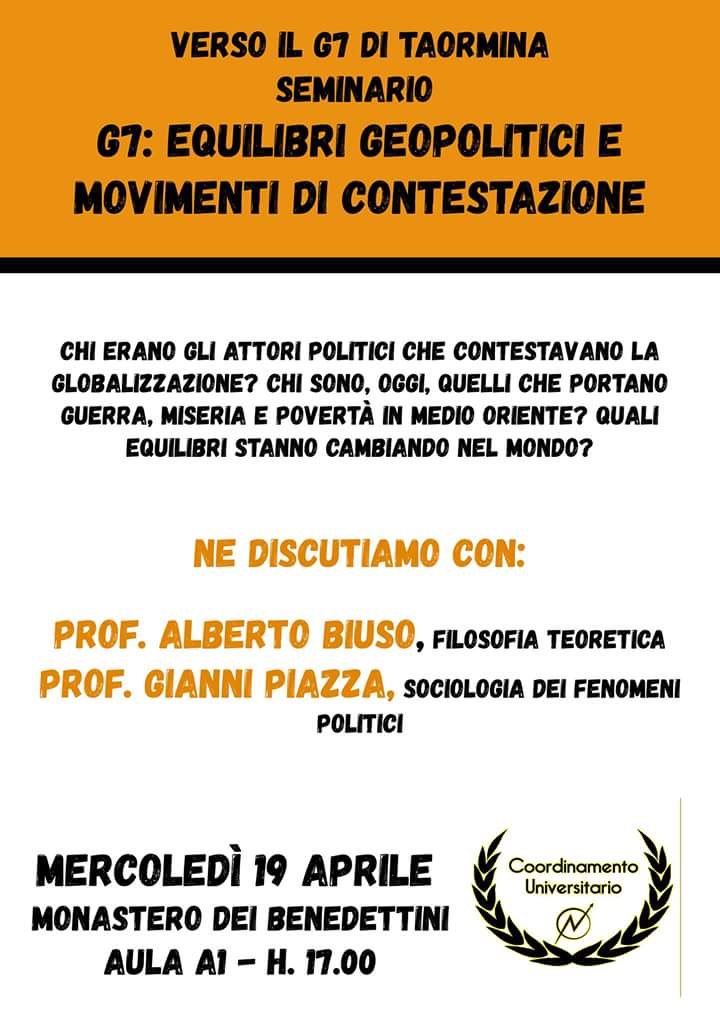Lo scorso anno ho scritto a proposito di una catastrofe didattica. Per fortuna l’Università non è soltanto esami ma è Communitas, è relazione tra persone, è crescere insieme nella conoscenza, nel disincanto e nella tenacia. Nata in Europa nel XII secolo, l’Università rappresenta uno dei più forti elementi di identità del nostro Continente. Luogo di conflitti e di scoperte, sede di trame a volte miserabili ma anche di fondamentali apprendimenti, spazio di scienza e di invenzione, l’Università è il respiro stesso di un sapere non impressionistico, non dogmatico, non utilitaristico. Proprio perché è anche questo, nel XXI secolo si sta operando a fondo -da parte dei decisori politici e dei loro complici- per ridimensionarne la funzione, la struttura, i contenuti. E tuttavia, pur con i tanti limiti che l’Università subisce e che ineriscono alle vicende umane, la fine dell’Università costituirebbe un gesto di autentica barbarie, di impoverimento collettivo, di prevalenza del fanatismo, della superficialità, dello spettacolo che emargina e rimuove il pensiero.
Il principio che mi guida nell’insegnamento è: «Per la scienza, per gli studenti». Proprio perché ha questi scopi, il mio è il mestiere più bello, più coinvolgente, più vivo. Ne ho avuto conferma in questo anno accademico, nel quale i gruppi-classe delle tre discipline sono stati partecipi, attenti, rispettosi e vivaci. La foto che vedete qui sopra è stata scattata lo scorso 1 giugno, a conclusione delle lezioni di Sociologia della cultura. Essa ritrae soltanto alcuni degli studenti che hanno frequentato il corso ma vorrei ringraziarli, insieme a tutti i loro colleghi, per avermi permesso di affrontare tematiche complesse e testi difficili in modo tanto serio quanto piacevole. Spero che gli studenti abbiano imparato qualcosa da me, io sicuramente ho appreso molto dallo scambio rigoroso e quotidiano con loro.
Chi fosse interessato, può anche ascoltare (e scaricare da Dropbox) la registrazione audio degli ultimi 30 minuti della lezione del 1 giugno, dedicati alla lettura e analisi di un saggio sulla società videocratica e ai saluti finali.