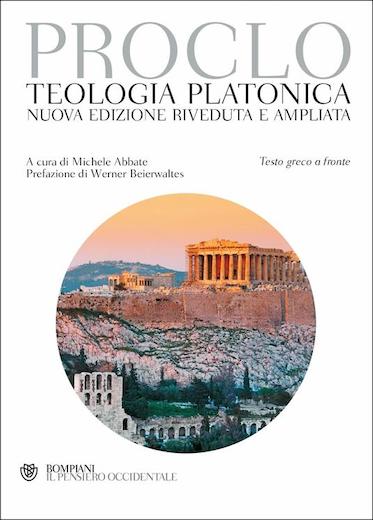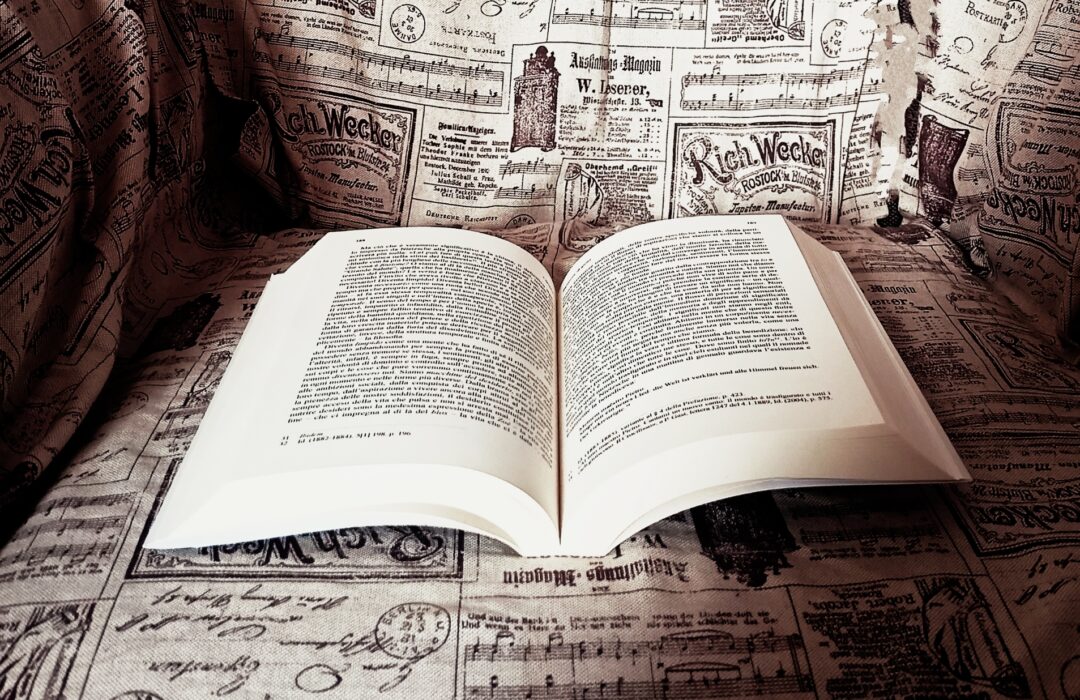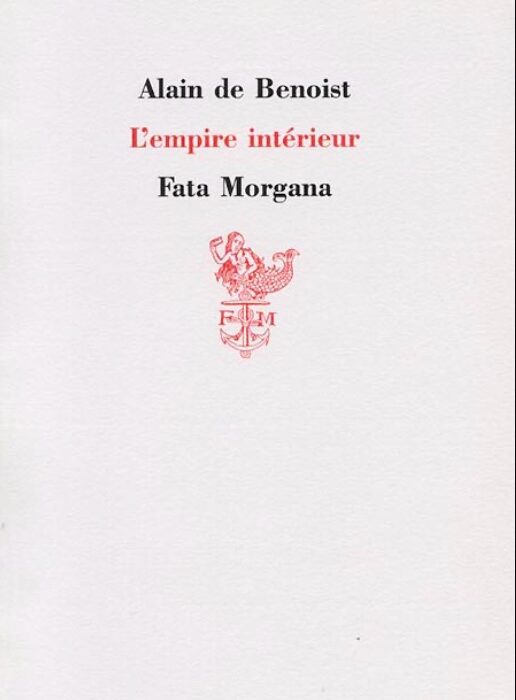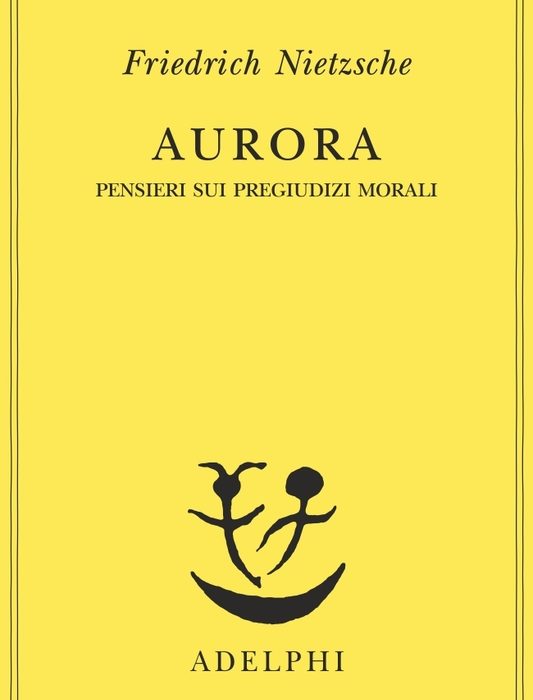Alain de Benoist
L’impero interiore
Mito, autorità, potere nell’Europa moderna e contemporanea
(L’empire intérieur, 1995)
Trad. di Debora Spini e Marco Tarchi
Ponte alla Grazie, 1995
Pagine 188
Complessi, ritornanti, rizomatici sono i percorsi della storia umana, delle comunità che la vivono, delle idee che la plasmano. Dissolti in Europa gli imperi dopo la Prima guerra mondiale, in particolare con i trattati di Sèvres e di Versailles, l’idea di nazione sembrò vincere e trionfare. In effetti essa ha guidato e costituito la storia contemporanea. Ma se nel XIX la nazione avanzò sullo slancio giacobino e napoleonico – eredi del centralismo delle monarchie assolute, in particolare di quella di Luigi XIV -, nel Ventesimo e Ventunesimo secolo essa sta mostrando sempre più la propria natura oppressiva e reazionaria, non solo nei regimi totalitari dell’Italia fascista e della Germania nazionalsocialista ma anche nell’imperialismo degli Stati Uniti e delle burocrazie europeiste, le quali non condividono nulla dell’idea imperiale, rimanendo invece «nazioni che cercano solamente di dilatarsi attraverso la conquista militare, politica, economica o di altro genere, sino a giungere a dimensioni che eccedono quelle delle loro frontiere del momento» (p. 165). Esempio massimo sono gli USA, che operano indefessamente al fine di «convertire l’intero mondo in un sistema omogeneo di consumo materiale e pratiche tecno-economiche» (166).
L’imperialismo contemporaneo è da ogni punto di vista l’opposto del principio e della struttura imperiali come emergono, ad esempio, nell’Impero romano fondato su un riconoscimento e un rispetto pervasivi delle autonomie locali e delle differenze ideali: di costume, di lingua, di religione. Quest’ultimo elemento costituisce un fattore di civiltà che i monoteismi hanno combattuto, calunniato, dissolto: «L’Impero romano non si richiama a divinità gelose. Ammette quindi gli altri dei, famosi o sconosciuti, venerati dai popoli che riunisce. La tolleranza religiosa è la norma, come del resto in tutto il mondo antico» (145).
Il mito dell’impero si fonda per de Benoist nell’impero del mito. A quest’ultimo è dedicata la prima e densa parte del volume. Attraverso un’ampia disamina filosofica e storica, si argomenta la tesi per la quale «Mythos e Logos sono termini assolutamente interscambiabili» (11), tanto che molte ricerche contemporanee in settori disparati – antropologia, letteratura, filosofia, religioni, logica – mostrano la razionalità del mito. Tra gli studiosi più noti, Kurt Hübner e James Hillman. Il primo sostiene che «il mito, lungi dall’essere ‘irrazionale’ possiede al contrario la sua propria razionalità. […] L’uomo non sperimenta mai il mondo direttamente: ogni sua esperienza, compresa quella scientifica, è necessariamente mediata da un universo mentale significante. Il mito quindi forma la struttura di questo universo e niente può dimostrare che questa struttura sia meno legittima di quella proposta dalla scienza» (62-63); da parte sua, Hillman vede nella «ragione solo un’espressione particolare del mito» (63).
Il mito va molto al di là del religioso e dell’etico. Il dominio sempre più pervasivo e soffocante della morale nel nostro tempo rappresenta un sostituto assai povero di comportamenti che sono di per sé misurati poiché regolati su una misura non soggettivistica, non psicologica, non normativa. Questa misura scaturisce non dal religioso o dall’etico ma dal sacro, che è un legame profondo e immediato con la materia come κόσμος, come totalità e dunque come continuità misurata dell’umano rispetto all’intero del quale è parte. Si tratta del contrario della ὕβρις, della dismisura escludente e individualistica diffusa nel mondo mediterraneo dai monoteismi, in particolare da quello cristiano: «Il mondo a questo punto non può più essere intrinsecamente il luogo del sacro. La relazione immediata non è più quella fra l’uomo e la totalità del reale, ma una semplice relazione con qualcun altro, che associa dei soggetti ormai separati» (36).
Monoteismi che a loro volta costituiscono il frutto e insieme il rafforzamento di alcuni elementi del tutto desacralizzanti: «l’individualismo (anima individuale, salvezza individuale), la dissociazione inaugurale nel dualismo dell’essere creato e dell’essere increato, il rifiuto del tempo circolare o ciclico e l’adesione ad una concezione della storia unilineare e vettoriale» (35).
La dimensione sacrale e mitica, invece, è intessuta di una ripetizione che implica sempre la differenza. E «in questo sta il senso di ogni metafora cosmica, fondata sul regolare alternarsi di opere e giorni, delle età e delle stagioni. Il ritorno periodico della primavera è il ritorno di una forma, ma non di un contenuto: è sempre la stessa stagione, ma è sempre un’altra primavera. L’immagine chiave, in questo caso, non è tanto il cerchio quanto la spirale o la sfera, poiché la possibilità di superare nasce dalla stessa ripetizione; e la rigenerazione del tempo nasce dal ricorso a ciò che è al di là del tempo» (25).
Il principio imperiale ha soprattutto questo in comune con l’ontologia mitica: un gioco senza fine di Identità e Differenza, per il quale che si tratti di dèi o di umani «l’identità degli altri, lungi dall’essere una minaccia per la nostra identità, fa parte di ciò che permette a tutti noi di difendere le nostre rispettive identità contro il sistema globale che cerca di ucciderle» (175).
L’Europa, luogo e spazio di origine di queste dinamiche, potrà sopravvivere alla sua sempre più evidente insignificanza politica e geostrategica soltanto se rispetterà le differenze tra i popoli e le comunità che la compongono e l’identità della loro storia mediterranea, se saprà dunque «tornare nella luce del mito» (74), nel chiarore della filosofia greca.