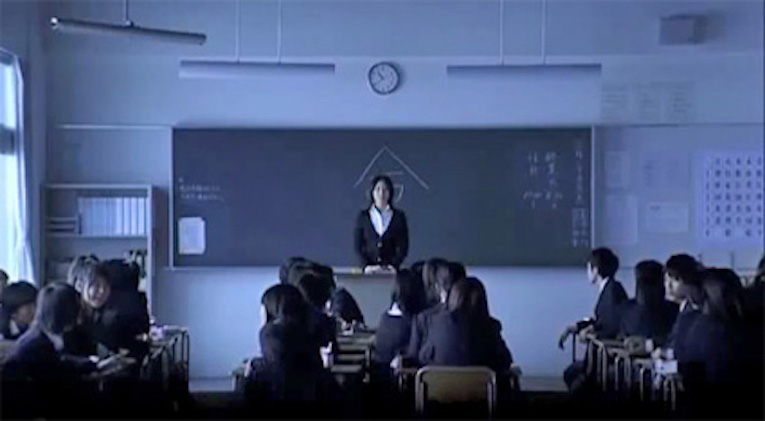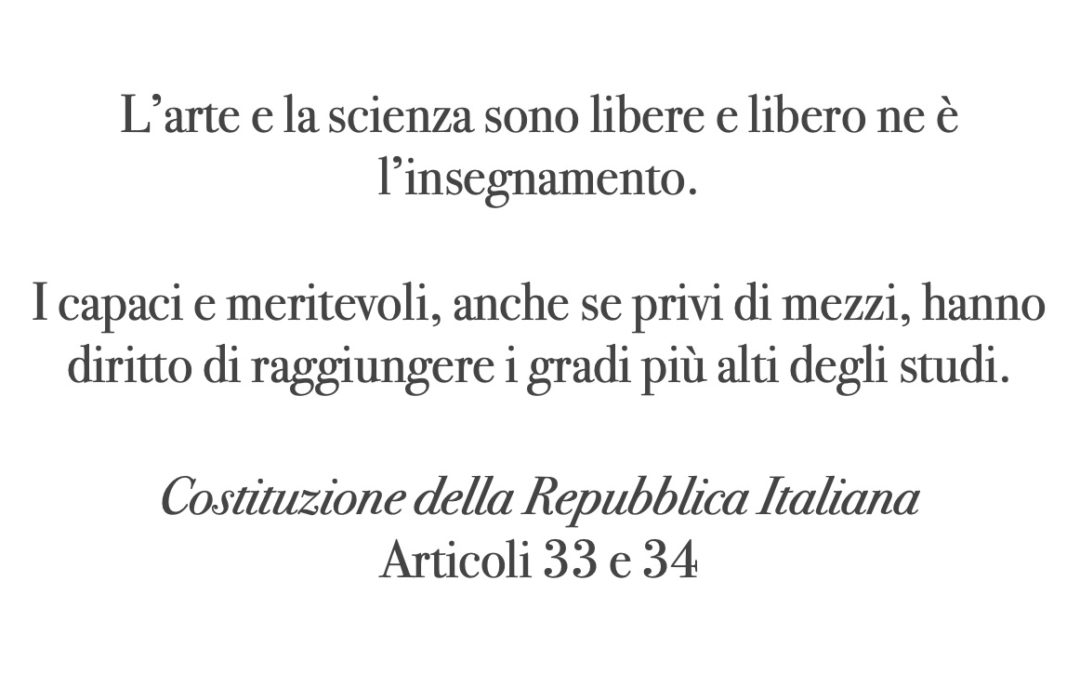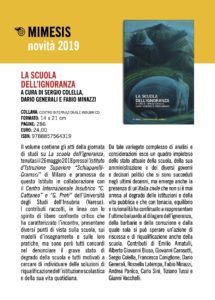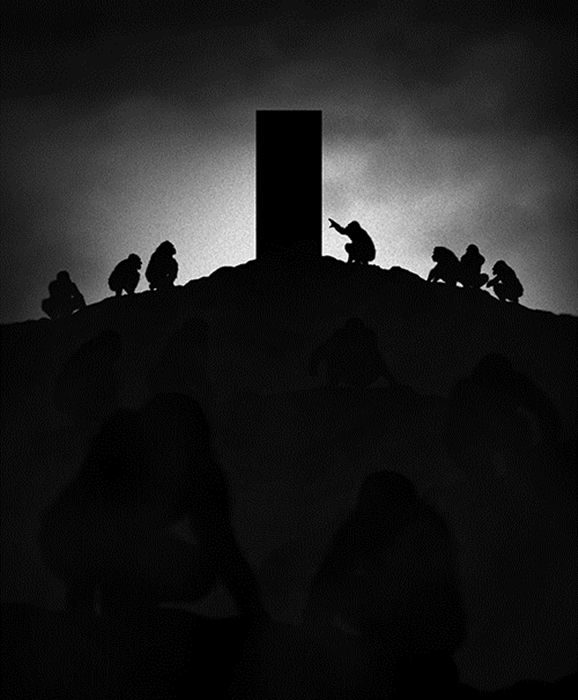Pubblico i pdf con la valutazione didattica ricevuta per i corsi svolti nell’a.a. 2018-2019 nel Dipartimento di Scienze Umanistiche di Unict.
Per l’insegnamento di Filosofia teoretica hanno sinora risposto al questionario on line 36 studenti.
Per l’insegnamento di Sociologia della cultura hanno sinora risposto al questionario on line 157 studenti. Il numero di studenti ‘frequentanti’ è 103, un dato che mi lascia perplesso, visto che a lezione gli studenti erano molti di meno, non più di una cinquantina. Tanto più che lo scorso anno per la stessa disciplina il numero di questionari compilati era stato di 25. Sospetto dunque che ci sia un errore ma questo è comunque il report ufficiale e come tale lo pubblico qui.
Per l’insegnamento di Filosofia della mente non ho ricevuto il report perché il numero di risposte al questionario è insufficiente.
Ringrazio i miei studenti per i giudizi che hanno espresso. Sono loro, da sempre, una delle ragioni che rendono meraviglioso questo lavoro. E a loro ricordo il modo in cui a marzo iniziammo o proseguimmo i nostri tre corsi.
Filosofia teoretica (Metafisica):
Husserl non è un autore, la fenomenologia non è una tra le tante correnti della storia della filosofia. Husserl e la fenomenologia sono un metodo/mondo fondato su un progetto teoretico visionario: far divenire l’umano ciò che è, trasformare i corpimente in un itinerario di conoscenza che non distingua più io e mondo ma li faccia emergere come un campo di forze nel quale la materia dispiega la propria autocomprensione, uno spazio che viene sempre riempito dal senso che una sua parte, quella umana, dà al mondo.
Dentro le circa 45.000 pagine stenografate nelle quali Husserl ha tentato di comprendere e comunicare la complessa struttura del mondo, si dispiega un pensiero tanto dinamico quanto unitario.
Dinamico poiché -come suggerì Eugen Fink- è possibile scandire il percorso husserliano in quattro fasi corrispondenti in generale ai luoghi del suo insegnamento: Halle, Göttingen, Freiburg e il periodo successivo al pensionamento; e tuttavia le istanze, i temi, le modalità, la tenacia del pensiero husserliane rimasero costanti a partire dalla filosofia della matematica, transitando per l’esigenza di una logica pura radicata poi nella soggettività trascendentale che perviene infine alle grandi analisi della crisi delle scienze e dell’identità dell’Europa.
Sociologia della cultura (Dismisura):
Il peggiore dei mali è la dismisura, è la ὕβϱις che smarrisce senso, proporzione, mezzi e obiettivi, che tutto confonde nel coacervo di una grandezza pronta a spezzarsi, che si spezzerà. Il primo dei beni è dunque -come concludono gli interlocutori del Filebo (66a)- ciò che è misurato nello spazio, τὸ μέτριον, e opportuno nel tempo, τὸ καίριον. L’epoca presente è invece dismisura. Lo si vede nei fenomeni più diversi, la si incontra a ogni passo, la si tocca ovunque.
La razionalità, al contrario, ben si esprime nell’immagine di Atena σκεπτόμενη. «Lo sguardo meditativo della dea (definita skeptòmene, ‘colei che medita’) è volto verso il cippo dell’agon cui presiede. Ella fissa il limite e al contempo vi si appoggia. Il limite non è soltanto il luogo dove qualcosa si arresta: è ciò che fa avvenire quella cosa, la rende presente» (Olivier Rey, Dismisura. La marcia infernale del progresso, Controcorrente 2016, p. 102).
Della misura Atena, la filosofia, è l’espressione e la forma suprema. La filosofia non è una fede o un procedimento soltanto logico ma è un sapere intuitivo della condizione umana e cosmica; non è un atteggiamento psicologico ma un’esperienza completa, sofferta e gloriosa dello stare al mondo; non è un ripetere formule altrui ma diventa il ripercorrere da sé il cammino di ogni ente dalla Pienezza al Limite. Perché il peggiore dei mali è la tracotanza, è la dismisura.
Filosofia della mente (Tempo della mente e Tempo del mondo):
La credenza di molti fisici contemporanei che il tempo sia irreale costituisce una forma di platonismo matematico, il quale ha però abbandonato il profondo legame che Platone sente con la realtà come intero e come problema, sostituendo a tale serietà ontologica il semplice fascino dell’eleganza e del formalismo matematici, i quali tuttavia non garantiscono in alcun modo la verità dei loro asserti ma soltanto il bisogno di eternizzarsi.
Il fatto, ad esempio, «che il movimento avviene nel tempo mentre la sua rappresentazione matematica è atemporale significa che non sono la stessa cosa» (Lee Smolin, La rinascita del tempo. Dalla crisi della fisica al futuro dell’universo, Einaudi 2014, p. 36).
Il tempo si conferma così il più importante tema e problema della fisica e di tutte le possibili scienze che non vogliano assumere una dimensione e un linguaggio mistico-matematici. «L’ipotesi della realtà del tempo conduce a una cosmologia più scientifica» (Smolin, p. 248) perché conduce a una cosmologia la quale non ha più bisogno dei tentativi epistemologici, religiosi ed etici di consolarci del nulla nel quale ogni ente è destinato a dissolversi come ente in questa forma qui, in questa determinata struttura minerale, vegetale, animale, atomica e cosmica.
La tesi della realtà effettiva, totale, pervasiva del tempo è più scientifica perché il mondo «continua a essere, sempre, un fascio di processi che si evolvono nel tempo e soltanto alcune sue piccole parti possono essere rappresentate da oggetti matematici atemporali» (Smolin, p. 252), è più scientifica perché il mondo è tempo.