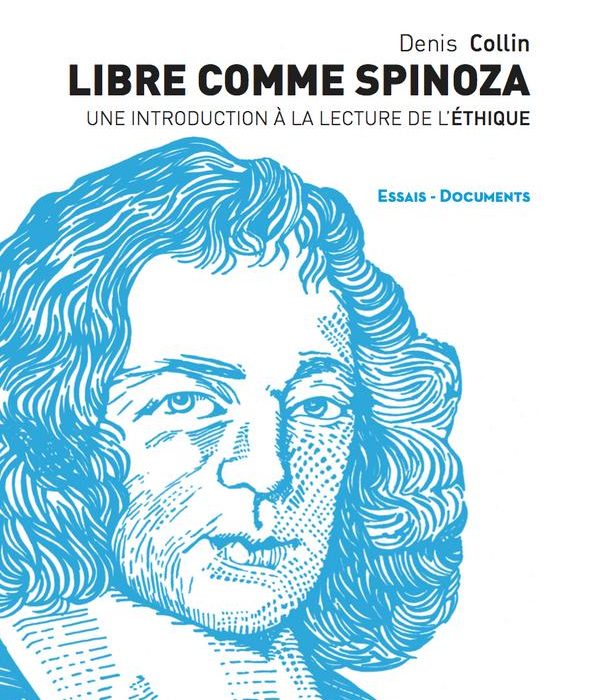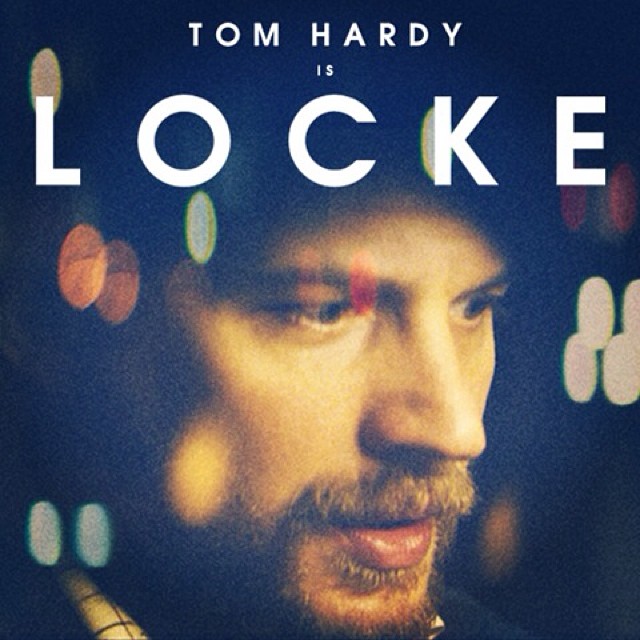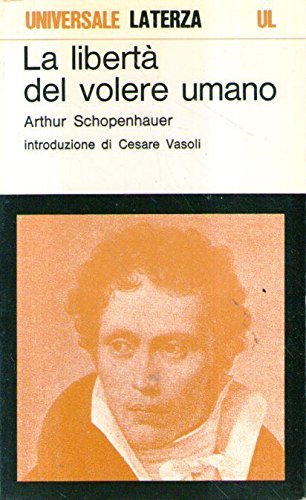Ἡρακλῆς μαινόμενος -Eracle furioso, Eracle impazzito– è il titolo completo di una tragedia di Euripide. C’è sempre infatti un dio che non tollera il trionfo di un umano, qualunque ne sia la ragione. O intrinseca: Eracle è figlio di uno dei tanti amori umani di Zeus ed Era non lo sopporta; o data da eventi che scatenano l’invidia: Eracle riesce a tornare dall’Ade e a salvare i figli e la moglie da morte imminente e sicura. Quei figli e quella sposa ai quali, impazzito, sarà lui stesso a dare la morte dalla quale li aveva salvati.
Un’inemendabile violenza percorre la vicenda di Eracle dalla sua nascita e ancor prima. Una violenza che si esprime come giusta vendetta poiché, lo afferma più volte Anfitrione, «un gusto c’è nella morte d’un uomo nemico che paga il fio delle colpe commesse»1 ed è naturale «τοῖς φίλοις τ᾽ εἶναι φίλον / τά τ᾽ ἐχθρὰ μισεῖν: ἀλλὰ μὴ ‘πείγου λίαν», «essere amico ai cari e odiare i tuoi nemici» (vv. 585-586, p. 827). In questa naturalità della vendetta, i Greci erano tuttavia assai più etici di noi, dei moderni. Teseo dà infatti per scontato che «i ragazzi non sono mai coinvolti da una guerra: è chiaro che si tratta di ben altro» (847). Nelle guerre del Novecento e del XXI secolo, invece, i bambini sono coinvolti totalmente. Chi è più crudele? Noi o loro?
Eracle è il più grande degli eroi, le sue imprese vanno al di là dell’umano e del possibile. E tuttavia viene annientato come uno qualsiasi dei figli dell’uomo, viene colpito negli affetti più fondi, nell’onore, nella saggezza. In quale altro modo mai i Greci potevano esprimere la loro sapienza? Che si tratti dell’intervento di un dio, di τύχη-Caso o di Ἀνάγκη-Necessità, l’esito è l’Inevitabile che sta scritto nei gangli stessi della materia, nelle cellule della vita, nell’intrico degli eventi in cui «ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων δίχα», «tutto si muta con vicenda alterna» (v. 104, p. 813), nel divenire, nel tempo. Il determinismo è, semplicemente, la verità del mondo. Anche chi lo nega fa parte di tale necessità. È questa la convinzione dei due filosofi più greci che dopo i Greci ci siano stati: Spinoza e Nietzsche.
Eracle è il testo dove necessità e determinismo sconfiggono ogni umano e ogni divino andare. Nessuno vi si oppone poiché nessuno si può opporre: «ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν θήσει ποτέ», «nessun uomo potrà mai fare in modo che ciò che deve non debba accadere» (v. 311, p. 818); «non c’è nessuno che sfugga alla sorte, non un mortale, non un dio, se è vero quanto si legge nei poeti» (852). La prima affermazione è di Megara -sposa di Eracle–, la seconda è di Teseo, il suo più che fraterno amico. Tradotto in siciliano: «A ccu è distinato di moriri o scuru, ammatula cci menti l’ogghiu lantirnatu».
Pagina magnifica di questo capolavoro è il racconto dettagliato, accorato, terribile e inevitabile che il Nunzio formula della follia di Eracle e dei suoi effetti (vv. 922-1015, pp. 839-841). Una descrizione perfetta nella varietà dei toni, nella sintesi, nella concitazione, nella distanza e nel moto. Una descrizione degli eventi che conducono Eracle a esclamare, ormai distrutto, «φεῦ: / αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμων κακῶν», «Ah! Diventare un sasso…smemorare!» (v. 1397; p. 854). Come di tanto in tanto dico ai miei studenti, un sasso è entità più consona di qualunque vivente, un sasso è libero da ogni immaginabile soffrire. È dai Greci che ho imparato anche questa sapienza.
1. Euripide, Eracle (Ἡρακλῆς μαινόμενος), in «Le tragedie», trad. di Filippo Maria Pontani, Einaudi 2002, p. 832. La tragedia fu messa in scena nel 2018 da Emma Dante al Teatro greco di Siracusa.