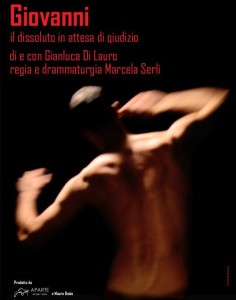Marcel Proust
(Le Temps retrouvé, 1922; Gallimard, 1954)
Trad. di Giorgio Caproni
Einaudi, 1978
Pagine XVIII- 437

I nuclei narrativi che concludono il grande affresco sono tre: la guerra, l’opera, il tempo.
Parigi durante la guerra, coi suoi misteriosi e grotteschi personaggi, i suoi segreti di città orientale, il suo volto raffinato e decadente, costituisce l’ultima grande aggiunta -suggerita e quasi imposta dagli avvenimenti stessi- all’originario progetto della Recherche. Qui è ancora una volta protagonista il personaggio più grande, forse il più amato dall’Autore: il barone di Charlus.
Il trionfo del Tempo si esprime attraverso tre intense immagini: la maschera che si posa sui volti, rendendoli negli anni irriconoscibili; il «teatrino di marionette immerse nei colori immateriali degli anni, di marionette che esteriorizzavano il Tempo: il Tempo che, d’ordinario, non è visibile, che per diventar tale va in cerca di corpi e che, dovunque li incontra, se ne impossessa per mostrar su di loro la propria lanterna magica» (p. 258); «i vivi trampoli crescenti senza posa» (391) sui quali gli umani si muovono fino a che non riescono più a reggere la distanza tra il mondo da cui sono germinati e il tempo al quale sono pervenuti.
La meditazione conclusiva sul Tempo viene introdotta mediante l’ultimo personaggio che appare nel romanzo: la figlia di Gilberte Swann e Robert de Saint-Loup. Personaggio senza nome essendo in effetti una metafora nella quale convergono le due strade di Méséglise e di Guermantes, apparse all’inizio dell’opera inconciliabili. In questa ragazza la cui bellezza è segno della giovinezza perduta del Narratore si celebra il trionfo della vita, del tempo e della dissoluzione: «così muta l’aspetto delle cose di questo mondo; così il centro degli imperi e il catasto dei patrimoni e la mappa delle situazioni sociali, tutto ciò che sembrava definitivo viene incessantemente rimaneggiato, e gli occhi d’un uomo che ha vissuto possono contemplare il più completo sconvolgimento proprio là dove gli sembrava più impossibile» (360).
Tempo e Opera sono inseparabili poiché essa «è il solo mezzo per ritrovare il Tempo perduto» (231). L’arte riconcilia con il dolore e con la morte. L’uno è l’ispiratore, l’altra è la ragione stessa per la quale l’opera esiste. L’ «Adorazione perpetua» fa dell’opera e della vita una sola realtà: «la vita vera, la vita finalmente scoperta e tratta alla luce, la sola vita quindi realmente vissuta, è la letteratura», «l’arte è il fatto più reale, la più austera scuola di vita, e il vero Giudizio finale» (227 e 211). Di notte, poiché di essa e del silenzio i libri sono figli, il Narratore costruirà la sua cattedrale di parole.
La gioia per l’Opera conclusa si coniuga alla modestia che induce il Narratore a rivolgersi a chi lo ha letto non come a un semplice fruitore di pensieri altrui ma come a un lettore di se stesso «essendo il mio libro qualcosa di simile a quelle lenti d’ingrandimento che l’ottico di Combray porgeva al cliente; il mio libro grazie al quale avrei fornito loro il mezzo di leggere in loro stessi. Dimodoché io non avrei domandato loro né di lodarmi né di biasimarmi, ma soltanto di dirmi se è proprio così, se le parole che essi leggono dentro di sé son proprio quelle che io ho scritte» (375). Sì, sono le stesse.
[Le mie riflessioni sugli altri sei volumi della Recherche si possono leggere qui: La strada di Swann, All’ombra delle fanciulle in fiore, I Guermantes, Sodoma e Gomorra, La prigioniera, La fuggitiva ]