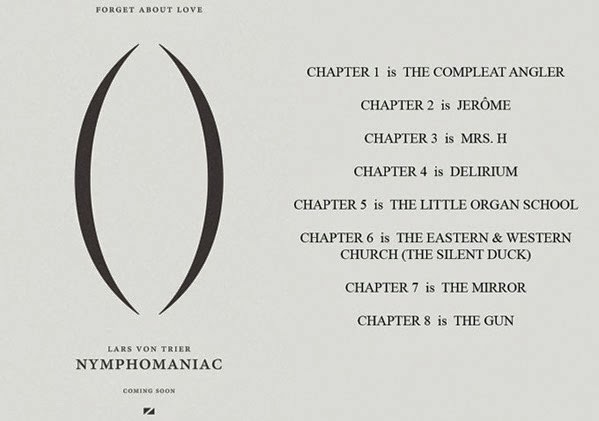Copia originale
(Can You Ever Forgive Me?)
di Marielle Heller
USA, 2018
Con: Melissa McCarthy (Lee Israel), Richard E. Grant (Jack)
Trailer del film
Lee Israel è esistita veramente. Viveva a New York negli anni Novanta, redigendo biografie di scrittori e lavorando qua e là nei giornali. Aveva un pessimo carattere e amava soltanto la sua gatta. Beveva molto, venne licenziata, aveva debiti consistenti. Quasi per caso, si inventò lettere e biglietti di famosi scrittori che poi vendeva alle librerie antiquarie. Ad aiutarla fu l’unico amico, inconcludente e debosciato, che aveva.
Potrei parlare di questo film dal punto di vista della ricostruzione storica, della vita materiale, le case, gli oggetti, gli abiti. Impeccabile. Potrei parlare anche delle ottime interpretazioni -al punto giusto tra passione e distanza– dei due protagonisti. Potrei parlare del dramma di due vite assai diverse, entrambe perdute ma sempre in cerca di redenzione. Potrei parlare soprattutto della scrittura, l’elemento intorno al quale tutto si muove, le lettere intese sia come missive sia come i segni che ci consentono «di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo», di «parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e diecimila anni» e tutto questo «con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta» (Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, Einaudi 1982, p. 193).
Potrei parlare di tutto questo. E invece no. Preferisco dire qualcosa di politico, qualcosa che riguardi la πόλις contemporanea che si chiama New York, un luogo di lotta di tutti contro tutti, di costante competizione, di assenza di sicurezze sociali, di profonda solitudine, di sporcizia e di degrado, dove l’unico culto condiviso è rivolto al dollaro e alle sue molteplici incarnazioni. Sul numero 423 (marzo 2018) di A Rivista anarchica, Santo Barezini, descrivendo la vita quotidiana in questa città, parla di «una malattia, la mela avvelenata di New York».
Nelle città americane -non soltanto in esse naturalmente ma in esse in modo particolare- il denaro è tutto, è davvero l’«equivalente generale» del valore (Marx), compreso il valore delle vite umane. Vite che dunque, come quella di Lee Israel, danno per naturale il sopruso, il regime della lotta, il senso e il significato incarnati nella merce che consente di ottenere tutte le altre merci e l’illusione della soddisfazione: «Der Amerikanismus ist die historisch feststellbare Erscheinung der unbedingten Verendung der Neuzeit in die Verwüstung. Das Russentum hat in der Eindeutigkeit der Brutalität und Versteifung zugleich ein wurzelhaftes Quellgebiet in seiner Erde, die sich eine Welteindeutigkeit vorbestimmt hat. Dagegen ist der Amerikanismus die Zusammenraffung von Allem, welche Zusammenraffung immer zugleich die Entwurzelung des Gerafften bedeutet».
«L’americanismo è la manifestazione storiograficamente consultabile dell’incondizionato declino dell’epoca moderna nella devastazione. Nell’evidenza della brutalità e rigidezza, il carattere russo gode contemporaneamente di una zona sorgiva piena di radici nella sua terra, la quale si è destinata preliminarmente un’evidenza mondiale. Al contrario, l’americanismo è la raccolta disordinata di tutto, una raccolta che significa sempre, allo stesso tempo, lo sradicamento di ciò che è stato accumulato»
(Martin Heidegger, Schwarze Hefte 1939-1941 [Quaderni neri 1939-1941], Überlegungen XV [8-10], in «Gesamtausgabe», Band 96, Vittorio Klostermann 2014, p. 257; traduzione di Francesco Alfieri).