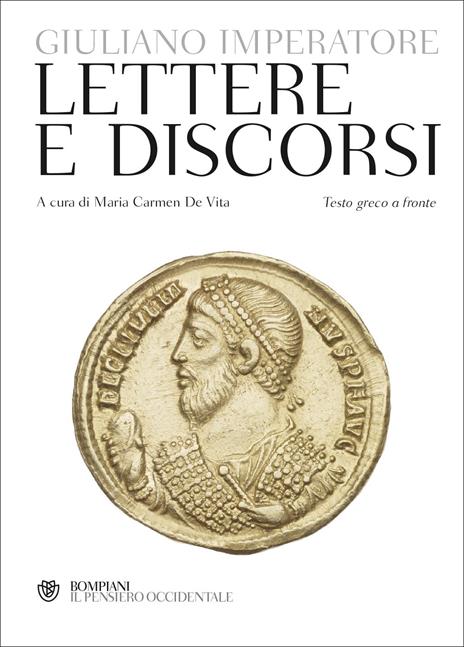L’imperatore Giuliano amava scrivere quasi quanto amava leggere. Portava con sé ovunque dei libri, in particolare Omero e Platone, anche durante le campagne militari. E al prefetto d’Egitto Ecdicio conferma che se «alcuni sono appassionati di cavalli, altri di uccelli, altri di fiere; a me, invece, è entrato dentro, fin da piccolo, un desiderio struggente di possedere dei libri» (lettera 107; Antiochia, fine luglio-agosto 362, 377d-378a, p. 141) 1.
Lettura e scrittura fanno il primato dello studio su ogni altra attività umana, tanto che – ricorda a Eumenio e a Fariano – «se qualcuno vi ha fatto credere che per gli uomini esiste qualcosa di più gradevole e utile del filosofare in tranquillità e al riparo da pubbliche incombenze, costui, ingannato, vi inganna a sua volta» (lettera 8: Gallia, fine 358-fine 359, 441b, p. 5) e raccomandando loro di dedicarsi con particolare cura allo studio di Platone e di Aristotele.
Tra i suoi scritti, le molte lettere inviate sia come privato sia prima come Cesare e poi come Augusto rappresentano una parte significativa del suo pensiero. Che infatti Giuliano si occupi di questioni personali o pubbliche, ha sempre davanti a sé la κοινοῦ τών Ἕλλήνων, la comunità degli Elleni, alla quale rivolgersi per confrontarsi, per guidarla, per delineare e vivere insieme la παιδείαν ορθην, la retta educazione tramite la quale restituire il mondo agli dèi e gli dèi al mondo.
L’unicità dell’imperatore Giuliano consiste esattamente e anzitutto in questo, nel modo con il quale pensò e – sino a che visse – realizzò il progetto di ricostituzione e rinascita dell’Ellenismo. Un modo unico perché esplicitamente volto a utilizzare il λόγος, la parola, la persuasione, e non l’autorità, la violenza, la costrizione. Metodi questi utilizzati da alcuni imperatori prima di lui e soprattutto dai cristiani prima e dopo il suo breve regno (dal 361 al 363). Giuliano ha piena consapevolezza sia dell’obiettivo e sia del metodo filosofico e non violento con il quale raggiungerlo: «Io non voglio né che i Galilei vengano messi a morte, né che siano ingiustamente colpiti, né che subiscano qualche altro male» (lettera 83 ad Artabio; Antiochia, luglio-dicembre 362, 376e, p. 85), anche perché ritiene che l’ateismo dei cristiani negatori degli dèi e il fanatismo che caratterizza le loro azioni siano espressioni patologiche di menti inquiete e senza misura, costituiscano più una malattia che altro. Essa andrebbe dunque curata e non punita.
Tra questi comportamenti c’è la loro tendenza (documentata da innumerevoli fonti antiche e dagli studi moderni) a «impadronirsi delle eredità degli altri e accaparrarsi di ogni cosa» (lettera 114 ai cittadini di Bostra; Antochia, calende di agosto 362, 437a, p. 153). E c’è soprattuto il bisogno – anch’esso ampiamente documentato – di morire, di farsi uccidere dalle autorità imperiali in modo da ottenere subito la palma del martirio e il conseguente paradiso: «Molti degli atei sono ossessionati e persuasi a morire, perché – essi pensano – voleranno in cielo, una volta staccati violentemente dalla vita» (lettera 89b a Teodoro, sommo sacerdote; Antiochia, marzo 363, 288 a-b, p. 99).
Nonostante tali e altri inquietanti comportamenti, Giuliano non esercita nessuna violenza contro i cristiani, i quali appunto
per ignoranza più che per convinzione si sono sviati. È con la ragione che bisogna convincere e istruire gli uomini, non con le percosse, gli insulti e i supplizi corporali. Perciò, ancora e ripetutamente invito coloro che aspirano a una devozione autentica a non commettere ingiustizia contro le moltitudini dei Galilei, a non attaccarle, a non recare loro offesa. Bisogna avere compassione piuttosto che odio per coloro che sono così sfortunati proprio in quello che c’è di più importante (ancora ai cittadini di Bostra, 438b-c, p. 155).
Sintetizzando con chiarezza le linee della sua politica verso i cristiani, l’imperatore scrive che «mi sono comportato verso tutti i Galilei con tanta mitezza e umanità che nessuno di loro in nessun luogo ha mai subito violenza, è stato trascinato al tempio o minacciato perché facesse, contro la sua volontà, cose del genere», mentre i Galilei esercitano continuamente violenza anche reciproca, contro i loro correligionari definiti ‘eretici’: «Invece i membri della Chiesa ariana, resi arroganti dalla loro ricchezza, hanno aggredito i seguaci di Valentino, e hanno osato commettere a Edessa infamie quali mai dovrebbero verificarsi in una città ben ordinata» (lettera 115 agli Edesseni [l’attuale Odessa, in Crimea]; Antiochia, fine ottobre-metà novembre 362; 428c-d, pp. 155-156). Valentino e i suoi seguaci furono una delle più importanti e influenti comunità gnostiche, perseguitate appunto dai cattolici e dagli altri cristiani.
Il veleno dell’intolleranza cristiana contaminò comunque persino Giuliano inducendolo a proibire non i testi dei cristiani o degli ebrei ma quello di altri Elleni, di alcune filosofie da lui ritenute inaccettabili: «Non sia ammessa la dottrina di Epicuro, né quella di Pirrone; già infatti – e hanno fatto bene! – gli dèi hanno anche distrutto le loro opere, cosicché la maggior parte di esse è scomparsa» (ancora a Teodoro, 301c, p. 119).
Al di là di questa debolezza, di tale cedimento allo spirito violento contro le filosofie introdotto dalle lotte cristiane per l’ortodossia, Giuliano mostra la serenità di chi sente vicino a sé il divino, mostra il disincanto di chi ha ben compreso la natura inemendabile della vita, il suo limite. A coloro tra gli Elleni che provano angoscia per la distruzione dei templi greci operata dai Galilei, l’imperatore ricorda che quanto
è stato realizzato da un uomo saggio e buono può essere distrutto da uno malvagio e ignorante; invece, le immagini viventi, stabilite dagli dèi, della loro sostanza invisibile, cioè gli dèi che si muovono in circolo per il cielo, rimangono eterne per sempre. Nessuno, dunque, perda la fede negli dèi, vedendo e ascoltando che alcuni hanno fatto violenza alle loro statue e ai loro templi (ancora a Teodoro, 295a, pp. 109-110).
Il disincanto sulla condizione umana è ben mostrato da due brani di una lettera ritenuta spuria ma che in ogni caso esprime efficacemente lo spirito dell’imperatore. Il quale ricorda a Imerio, prefetto d’Egitto, che al dolore insistito e inconsolabile di Dario per la morte della sua amata compagna, Democrito promise «che se avesse fatto scrivere sulla tomba della moglie i nomi di tre persone mai sfiorate dal dolore, subito ella sarebbe ritornata in vita. […] Dario rimase a lungo in imbarazzo, non potendo trovare alcuno cui non fosse capitato anche di soffrire qualche dolore; allora Democrito, sorridendo, secondo la sua abitudine, disse…» (lettera 201, 413b-c, p. 185).
La lettera si conclude affermando che «sarebbe una vergogna per la ragione se non avesse la stessa forza del tempo» (ibidem), sarebbe una vergogna che quanto il tempo in ogni caso consegue, l’attenuazione del dolore, non si cercasse di raggiungerlo già nel presente con la forza del pensare.
Nota
1. Giuliano Imperatore, Lettere e Discorsi, a cura di Maria Carmen De Vita, Bompiani 2022, sezione Le Lettere (pagine 1-189). Le indicazioni bibliografiche delle lettere che cito sono fornite direttamente nel testo, tra parentesi.