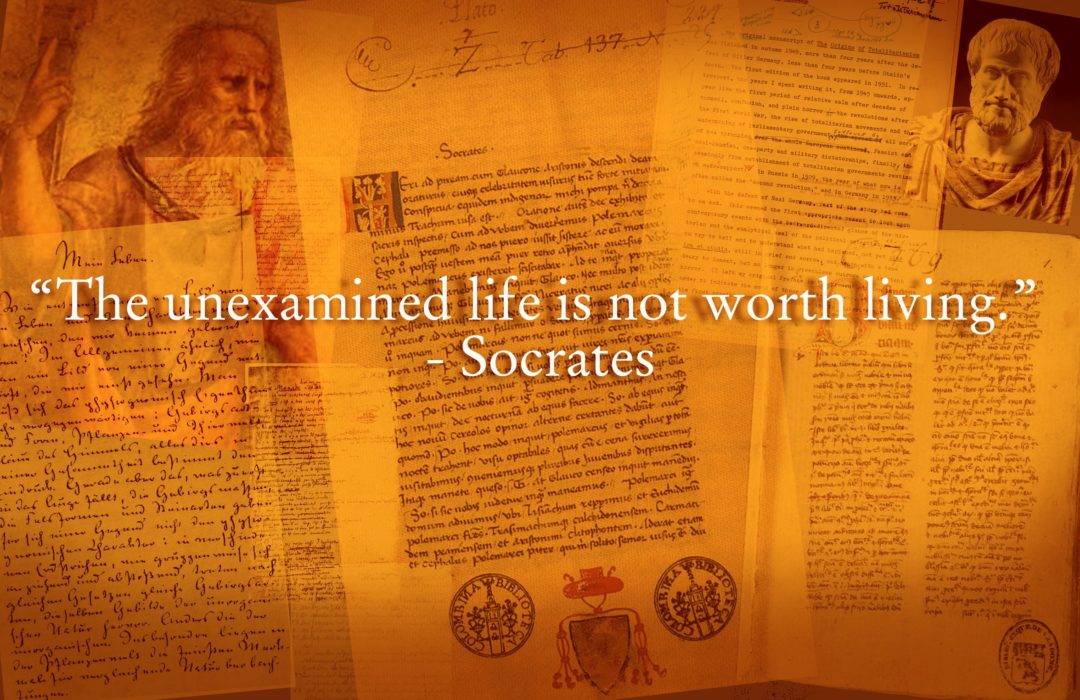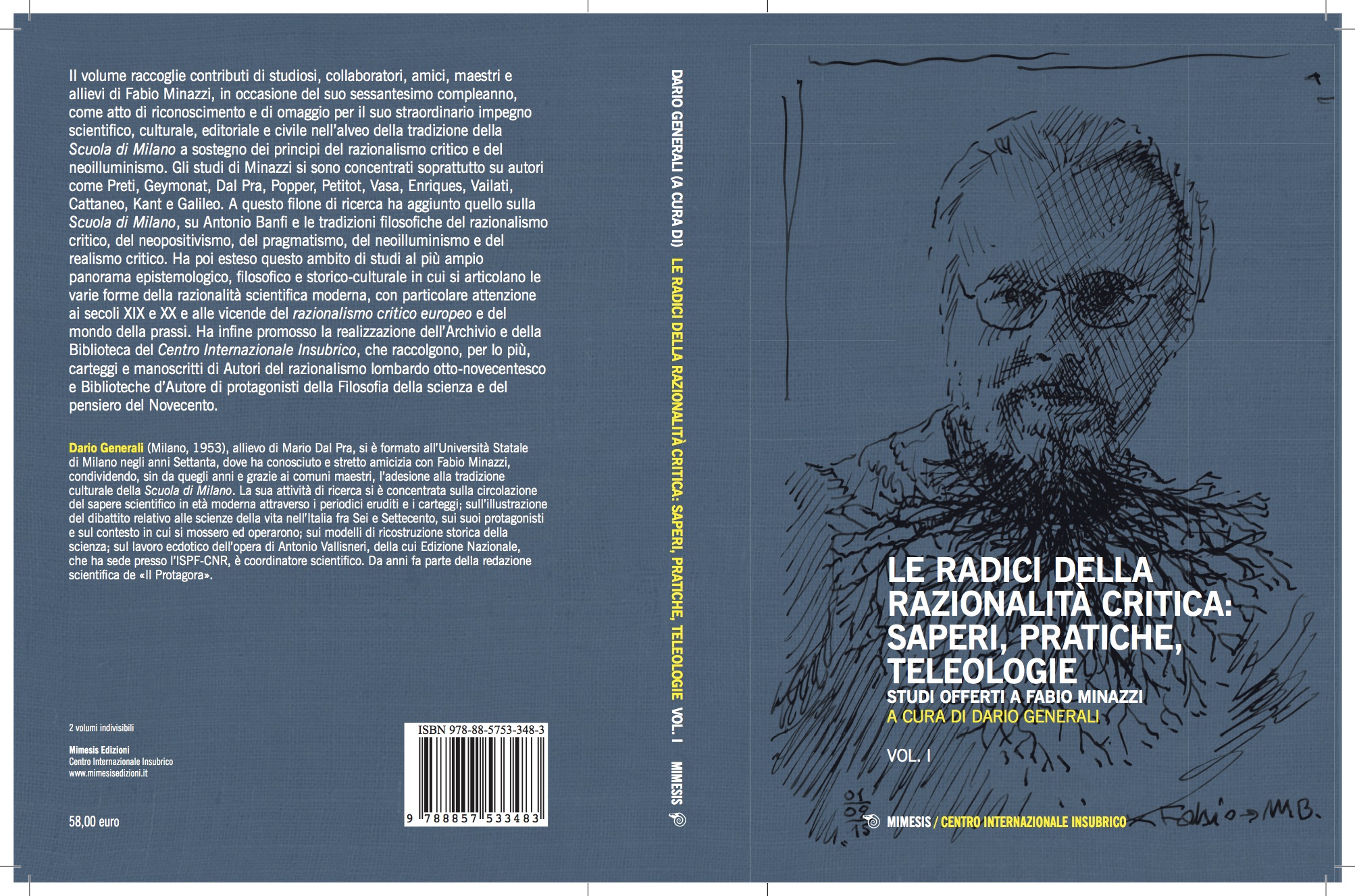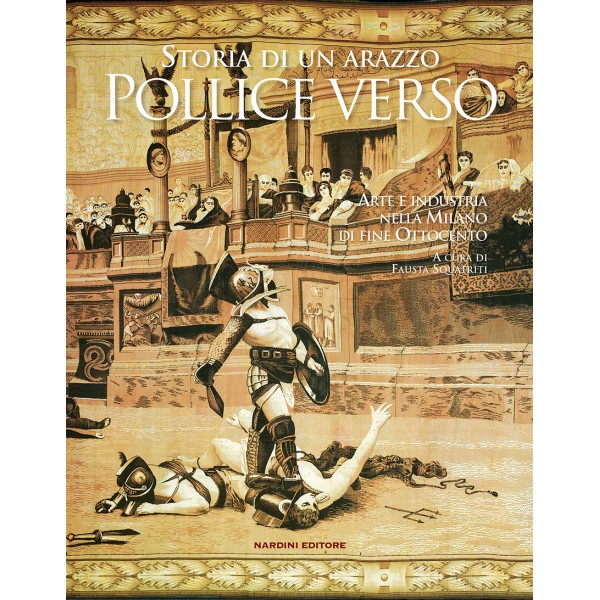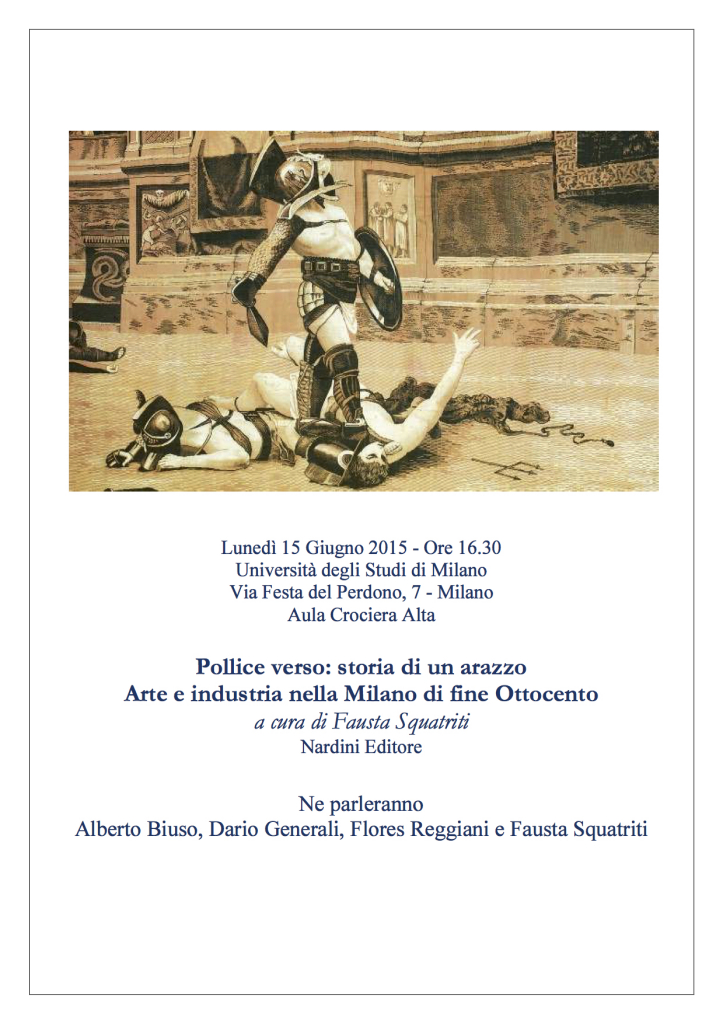Il Prof. Dario Generali mi ha segnalato un intervento di Raniero La Valle che chiarisce in modo lucido e documentato il contesto nel quale è maturata la proposta di riforma della Costituzione Italiana da parte del governo Renzi-Alfano. Riporto qui alcuni brani di questo intervento, preceduti dalla riflessione di Dario Generali.
==========
Un’analisi molto lucida e informata, che fornisce un’interpretazione credibile degli ultimi 25 anni di storia mondiale e delle spinte reazionarie che dovunque si manifestano.
Il ‘libero’ mercato mal tollera qualsiasi pensiero divergente e qualsiasi critica, che contabilizza come inutili costi e limitazioni dei suoi profitti. Basta entrare in una logica aziendale per comprenderlo. Gli ordini del management non devono essere discussi o, peggio ancora, disattesi, perché in questo modo si rischierebbe di compromettere gli obiettivi aziendali o, comunque, aumentare i costi di produzione e di gestione logistica. L’errore esiziale è di permettere che le logiche aziendali egemonizzino la vita politica, i suoi modelli e le sue finalità, che devono essere ben altri. I profitti dei capitali investiti non possono essere l’unico metro di valutazione della qualità di una società. Alti livelli di produttività garantiscono risorse economiche, ma queste hanno senso se finalizzate al miglioramento del generale tenore di vita dei popoli e alla capacità che questa crescita diventi sviluppo. Diversamente rischiano di essere un cancro nel tessuto sociale e civile e di operare per la disgregazione di ogni forma evoluta di organizzazione di stato sociale.
==========
L’Italia è a crescita zero, la disoccupazione giovanile a luglio è al 39 per cento, il lavoro è precario, i licenziamenti nel secondo trimestre sono aumentati del 7,4 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 221.186 persone, i poveri assoluti sono quattro milioni e mezzo, la povertà relativa coinvolge tre milioni di famiglie e otto milioni e mezzo di persone.
E l’Italia che fa? Fa una legge elettorale che esclude dal Parlamento il pluralismo ideologico e sociale, neutralizza la rappresentanza e concentra il potere in un solo partito e una sola persona.
[…]
Ora, per trovare la verità nascosta del referendum, il suo vero movente, la sua vera premeditazione, bisogna ricorrere a degli indizi, come si fa per ogni giallo.
Il primo indizio è che Renzi ha cambiato strategia, all’inizio aveva detto che questa era la sua vera impresa, che su questo si giocava il suo destino politico. Ora invece dice che il punto non è lui, che lui non è la vera causa della riforma, ha detto di aver fatto questa riforma su suggerimento di altri e ha nominato esplicitamente Napolitano; ma è chiaro che non c’è solo Napolitano. Prima ancora di Napolitano c’era la banca J. P. Morgan che in un documento del 2013, in nome del capitalismo vincente, aveva indicato quattro difetti delle Costituzioni (da lei ritenute socialiste) adottate in Europa nel dopoguerra: a) una debolezza degli esecutivi nei confronti dei Parlamenti; b) un’eccessiva capacità di decisione delle Regioni nei confronti dello Stato; c) la tutela costituzionale del diritto del lavoro; d) la libertà di protestare contro le scelte non gradite del potere.
[…]
Inoltre bisognava distruggere il principale avversario e fautore politico del No, il Movimento 5 Stelle. Questo spiega l’attacco spietato e incessante alla Raggi. E poi ci volevano i tempi supplementari per distribuire un po’ di soldi con la legge finanziaria.
[…]
Ebbene il delitto fondatore dell’attuale regime del capitalismo globale fondato, come dice il papa, sul governo del denaro e un’economia che uccide, è la prima guerra del Golfo del 1991.
È a partire da quella svolta che è stato costruito il nuovo ordine mondiale.
[…]
E allora questa è la verità del referendum. La nuova Costituzione è la quadratura del cerchio. Gli istituti della democrazia non sono compatibili con la competizione globale, con la guerra permanente, chi vuole mantenerli è considerato un conservatore. Il mondo è il mercato; il mercato non sopporta altre leggi che quelle del mercato. Se qualcuno minaccia di fare di testa sua, i mercati si turbano. La politica non deve interferire sulla competizione e i conflitti di mercato. Se la gente muore di fame, e il mercato non la mantiene in vita, la politica non può intervenire, perché sono proibiti gli aiuti di Stato. Se lo Stato ci prova, o introduce leggi a difesa del lavoro o dell’ambiente, le imprese lo portano in tribunale e vincono la causa. Questo dicono i nuovi trattati del commercio globale. La guerra è lo strumento supremo per difendere il mercato e far vincere nel mercato.
Le Costituzioni non hanno più niente a che fare con una tale concezione della politica e della guerra. Perciò si cambiano. Ci vogliono poteri spicci e sbrigativi, tanto meglio se loquaci.
E allora questa è la ragione per cui la Costituzione si deve difendere. Non perché oggi sia operante, perché è stata già cambiata nel ‘91, e il mondo del costituzionalismo democratico è stato licenziato tra l’89 e il ’91 (si ricordi Cossiga, il picconatore venuto prima del rottamatore). Ma difenderla è l’unica speranza di tenere aperta l’alternativa, di non dare per compiuto e irreversibile il passaggio dalla libertà della democrazia costituzionale alla schiavitù del mercato globale, è la condizione necessaria perché non siano la Costituzione e il diritto che vengono messi in pari con la società selvaggia, ma sia la società selvaggia che con il NO sia dichiarata in difetto e attraverso la lotta sia rimessa in pari con la Costituzione, la giustizia e il diritto.
==========
Il testo completo dell’intervento di Raniero La Valle si può leggere su Micromega.