 La sezione più interessante di questo numero di Mente & cervello è costituita forse dalle due paginette conclusive dedicate alle recensioni. Vi si parla, infatti, di tre libri fra di loro collegati e dedicati rispettivamente alle dipendenze, al piacere e al determinismo genetico. Nel suo L’istinto del piacere, Gene Wallenstein cerca di spiegare come mai «il nostro cervello è disposto a subire sacrifici, persino sofferenze, prefigurandosi un intenso piacere, anche di breve durata, che ne potrà derivare» (P.Garzia, p. 104). Una disponibilità che ha come effetto la possibile dipendenza da innumerevoli fonti di piacere, molte delle quali dannose. «Ciò che indirizza le nostre preferenze in termini di piacere varia, a volte moltissimo, non soltanto nelle diverse fasi della vita ma pure in rapporto all’ambiente. Potente motore evolutivo, il piacere orienta e guida ogni scelta della nostra vita» (Id., p. 105). “In rapporto all’ambiente”, certo, ma anche con una componente innata di estrema potenza. È quanto sostiene Dick Swaab -recensito da M.Capocci- in Noi siamo il nostro cervello. Il neurobiologo olandese ritiene infatti che noi diventiamo assai presto ciò che siamo: «È la vita intrauterina a decidere molti aspetti della nostra personalità: scelte sessuali, integrazione familiare, fragilità emotive, schizofrenia, nonché altri tratti più o meno patologici sono dovuti alla chimica che il feto esperisce all’interno del ventre materno, oltre che alla genetica ereditata dai genitori» (104).
La sezione più interessante di questo numero di Mente & cervello è costituita forse dalle due paginette conclusive dedicate alle recensioni. Vi si parla, infatti, di tre libri fra di loro collegati e dedicati rispettivamente alle dipendenze, al piacere e al determinismo genetico. Nel suo L’istinto del piacere, Gene Wallenstein cerca di spiegare come mai «il nostro cervello è disposto a subire sacrifici, persino sofferenze, prefigurandosi un intenso piacere, anche di breve durata, che ne potrà derivare» (P.Garzia, p. 104). Una disponibilità che ha come effetto la possibile dipendenza da innumerevoli fonti di piacere, molte delle quali dannose. «Ciò che indirizza le nostre preferenze in termini di piacere varia, a volte moltissimo, non soltanto nelle diverse fasi della vita ma pure in rapporto all’ambiente. Potente motore evolutivo, il piacere orienta e guida ogni scelta della nostra vita» (Id., p. 105). “In rapporto all’ambiente”, certo, ma anche con una componente innata di estrema potenza. È quanto sostiene Dick Swaab -recensito da M.Capocci- in Noi siamo il nostro cervello. Il neurobiologo olandese ritiene infatti che noi diventiamo assai presto ciò che siamo: «È la vita intrauterina a decidere molti aspetti della nostra personalità: scelte sessuali, integrazione familiare, fragilità emotive, schizofrenia, nonché altri tratti più o meno patologici sono dovuti alla chimica che il feto esperisce all’interno del ventre materno, oltre che alla genetica ereditata dai genitori» (104).
Ancora una volta, tuttavia, va superata la sterile contrapposizione tra ambiente e genetica. Gli umani sono degli animali sociali che plasmano il proprio cervello in relazione alla cultura e creano cultura con i neuroni. Alcuni esempi? Il sesso: «Per il comportamento sessuale il cervello è essenziale quanto gli organi riproduttivi» (K.Lambert, 41); le malattie, comprese le più gravi: «Negare l’esistenza di una relazione fra sistema immunitario e psicologia non è più possibile ai giorni nostri. Sono infatti troppe le prove che l’organizzazione psicologica o gli eventi stressanti possono influire sulla risposta immunitaria. La branca superspecialistica che se ne interessa è la psiconeuroendocrinoimmunologia, un termine complicato che indica soltanto le possibili interrelazioni fra sistema nervoso centrale, equilibri ormonali e sistema immunitario» (L.Tondo, 7); i sogni, i quali -al di là delle interpretazioni mitologiche o psicoanalitiche (che, in verità, sono quasi identiche, e anzi quelle freudiane sono ancor più arbitrarie di qualunque mito)- non sarebbero altro «che il pensiero di un cervello che si trova in uno stato biochimico diverso. Infatti le esigenze fisiologiche del sonno alterano il suo funzionamento» (D.Barret, 25-26); il sonno stesso -soprattutto quello REM- ha lo scopo psicosomatico di consolidare la memoria.
Ma nell’umano la chimica è inseparabile dalla semantica e quindi «i nostri comportamenti e perfino le nostre reazioni fisiologiche dipendono in larga misura dall’immagine che abbiamo del mondo, più che dalla realtà stessa», come dimostra M.Barberi in un istruttivo e divertente articolo dedicato al bluff in tutte le sue forme e non soltanto in quelle classiche del poker (51-52). Il titolo, infatti, è «la vita è un bluff», per spiegare il quale serve una vera e propria ermeneutica fisiologica oltre che filosofica.
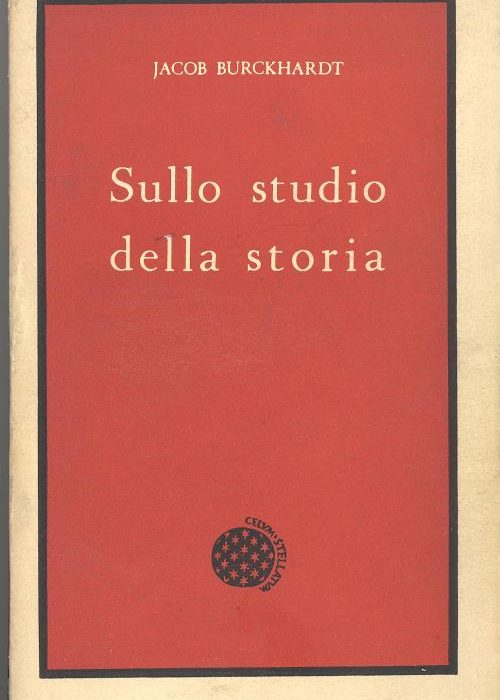
Sullo studio della storia
(Uber geschichtliche Studium [Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1868-1873])
di Jacob Burckhardt
Trad. di Mazzino Montinari
Boringhieri, 1958
Pagine 310
In queste sue lezioni pubblicate postume nel 1905 -anche con delle manipolazioni1– Burckhardt rifiuta le concezioni storicistiche che interpretano il divenire storico come lo sviluppo progressivo di un’idea, di un valore, di una qualsiasi Provvidenza. Cerca, piuttosto, di vedere la storia nella sua più concreta e non garantita empiria, a partire comunque da tre grandi concetti: stato, religione, cultura.
Lo stato e la religione sono per Burckhardt elementi statici, di controllo, alla fine sempre oppressivi. La cultura, invece, è la dimensione dinamica, libera, viva e costantemente nuova. Essa è «la quintessenza di tutto ciò che si è formato spontaneamente per promuovere la vita materiale e come espressione della vita spirituale e morale» (pp. 42-43). In quanto tale, essa costituisce la critica delle altre due strutture, «l’orologio che rivela l’ora in cui la forma e il contenuto in esse non coincidono più» (74).
Attraverso ampie pennellate ed efficaci excursus, Burckhardt enuncia una serie di tesi che saranno condivise e rielaborate da Nietzsche, il quale in uno dei biglietti del 4 gennaio 1889 definì il collega basileese «il nostro grande, più grande maestro»2. Tra queste tesi: il pluralismo metodologico; la Grecia come il luogo dove cultura e arte hanno avuto i migliori esiti, senza che però questo implichi la romantica e «fantastica predilezione per una antica e idealizzata Atene» (151); il cristianesimo come tipica religione dei passivi e dei dogmatici, che non è stata nemmeno capace di migliorare la condotta morale dei suoi adepti; il riconoscimento del conflitto come elemento dinamico della storia; la critica alle società massificate, i cui membri si adeguano sempre a chi meglio garantisce loro «tranquillità e guadagni» (239). Alle masse Burckhardt contrappone le «individualità possenti [che] si impongono e indicano le direzioni» (80-81).
Oscillando tra pragmatismo e metafisica, disincanto e progetto, Burckhardt si pone alla confluenza di numerosi itinerari della cultura e del pensiero moderno. Lo studioso riservato, il silenzioso maestro, insegna a Nietzsche «che in generale non si valuti la vita terrena più di quel che merita» (193). Era la stessa convinzione di Platone: «Certo è vero che le vicende umane non meritano poi una grande considerazione, ma è anche vero che bisogna pur occuparsene, per quanto possa essere un compito ingrato»3. Questo compito è la storia.
Note
1. Nel 1998 Einaudi ha pubblicato una nuova edizione, presentandola con queste parole: «Le lezioni che Burckhardt tenne all’Università di Basilea tra il 1868 e il 1873, uno dei momenti salienti della moderna riflessione storiografica. Condotta sui manoscritti originali, la nuova edizione a cura di Maurizio Ghelardi restituisce gli appunti dello storico svizzero alla loro vera natura, facendo giustizia delle deformazioni nate dalle precedenti manipolazioni e riproducendo le frequenti osservazioni critiche che Burckhardt annotava in margine ai fogli».
2. F. Nietzsche, Briefe. Januar 1887 – Januar 1889, in «Nietzsche Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe», herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, vol. III/5, de Gruyter, Berlin-New York 1984, lettera 1245, p. 574. Nel recente quinto e ultimo volume della traduzione italiana dell’Epistolario (Adelphi, 2011) la lettera si trova a p. 889.
3. Platone, Leggi, 803 a, trad. di R. Radice.
Due docenti universitari hanno redatto un appello -rivolto al ministro Profumo e a Monti- che sta ricevendo adesioni molto numerose. L’ho sottoscritto anch’io poiché mi sembra che descriva con realismo la situazione in cui ci siamo cacciati e proponga delle vie d’uscita. Vi si stigmatizza, infatti, la progressiva burocratizzazione: «Si sta scatenando negli atenei la definizione dei “criteri di valutazione”, al fine di misurare la “produttività” scientifica degli studiosi, come si misura una qualsivoglia quantità calcolabile. Anche per questo le Università europee sono sotto l’assedio quotidiano di un flusso continuo di disposizioni normative, che soffocano i docenti in pratiche quotidiane di interpretazioni e applicazioni quasi sempre di breve durata. Sempre minore è il tempo per gli studi e la ricerca, mentre la vita quotidiana di chi vive nelle Facoltà –docenti, studenti, personale amministrativo– è letteralmente soffocata da compiti organizzativi interni mutevoli, spesso di difficile comprensione, quasi sempre pleonastici». Un fenomeno che gli studenti dell’Ateneo dove insegno ben conoscono, dato che ogni anno vengono loro imposte modifiche anche radicali ai piani di studio, le quali creano una confusione enorme che sono i ragazzi a scontare, prima e assai più che i docenti.
Si condanna il cosiddetto «processo di Bologna», voluto nel 1999 dall’allora ministro Luigi Berlinguer (di infausta memoria) e sostenuto poi dai suoi successori. Tale modello ha infatti «rivelato il suo totale fallimento. Il numero dei laureati non è aumentato, le percentuali degli abbandoni nei primi anni sono rimaste pressoché identiche, diminuiscono le immatricolazioni, si fa sempre più ristretta l’autonomia universitaria, i saperi impartiti sono sempre più frammentati e tra di loro divisi, tecnicizzati, mai riconnessi a un progetto culturale, a un modello di società».
Un fallimento che l’appello giustamente riconduce al modello statunitense: «Ma a dispetto dell’immenso fiume di risorse e la finalizzazione spasmodica delle scienze alla produzione di brevetti e scoperte strumentali, i risultati sono stati irrisori. La grande ondata di nuovi posti di lavoro qualificati non si è verificata. Anzi, gli investimenti nel sapere hanno accompagnato un fenomeno dirompente: la distruzione della middle class. […] Inseguire gli USA su questa strada è aberrante. La crisi in cui versa il mondo rivela l’erroneità irrimediabile di una strategia da cui bisogna uscire al più presto».
Per avviare la «fuoriuscita dal modello liberistico di un’Europa ormai sull’orlo del collasso» il testo formula proposte molto concrete e di buon senso, tra le quali:
«Abolire il fallimentare sistema del 3+2 dall’organizzazione degli studi e ripristinare i precedenti Corsi di Laurea, prevedendo lauree brevi per le Facoltà che vogliono organizzarli».
«Abolire i crediti (i famigerati CFU) come criteri di valutazione degli esami».
«Noi crediamo giusto che l’Università resti pubblica, sostenuta da risorse pubbliche. […] L’organo di autogoverno degli Atenei sul piano didattico e della ricerca non può essere comunque il CdA, ma il Senato Accademico, democraticamente eletto, in modo da rappresentare equamente tutte le discipline e tutte le figure di coloro che nell’Università lavorano e studiano».
«Occorre immediatamente dar vita a un meccanismo di rapido reclutamento di nuovi ricercatori […] Ma è necessario al più presto bandire concorsi per la docenza in tutte le Facoltà. I docenti (compresi i ricercatori) italiani sono i più vecchi d’Europa e i numerosi pensionamenti hanno sguarnito gravemente tante Facoltà», compresa quella in cui insegno, i cui studenti hanno visto la cancellazione da un giorno all’altro di materie da loro scelte al momento dell’iscrizione.
«È infine necessario spendere le energie dei docenti per riorganizzare i saperi, il loro studio e la loro trasmissione nelle Università», poiché il senso della docenza universitaria affonda nella ricerca e nello studio quotidiano (“da mattina a sera”), aggiornato e scientifico e non nella burocratizzazione e nella quantificazione espressa da un lessico non a caso mercantile (debiti e crediti).
Consiglio di leggere con attenzione e per intero il Documento. La questione universitaria non riguarda i docenti e neppure soltanto gli studenti che frequentano per alcuni anni gli Atenei, ma è un ambito la cui struttura e il cui funzionamento ricadono sull’intero corpo sociale, su tutti.
[Invito a leggere anche un successivo intervento e i relativi commenti: L’università (s)valutata]
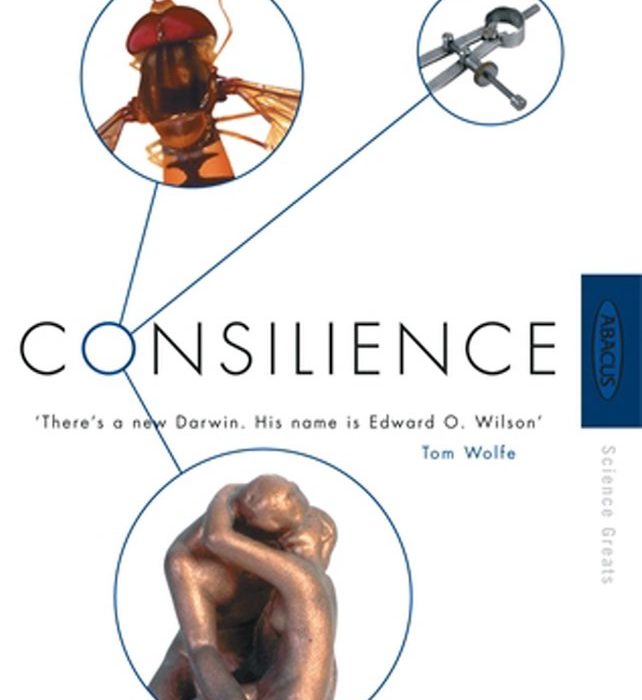
L’armonia meravigliosa
Dalla biologia alla religione, la nuova unità della conoscenza
di Edward O. Wilson
(Consilience, 1998)
Trad. di Roberto Cagliero
Il titolo italiano di quest’opera cerca, senza riuscirci, di restituire la densità di contenuto di un termine dell’inglese arcaico come Consilience. Coincidenza, convergenza, unificazione; questo è il plesso semantico che il titolo originale intende evocare. Convergenza tra che cosa? Tra il sapere scientifico e quello umanistico, non due campi separati e distinti -come induce a pensare lo specialismo che va diventando una palude di discipline minori dentro le quali affonda la comprensione del mondo- ma due ramificazioni dell’unico sapere umano e naturale, da apprendere nella sua unitarietà originaria e profonda. La complessità del mondo è incomprensibile senza una visione capace di sintetizzare science e humanities. Infatti,
l’idea centrale della visione coincidente del mondo è che tutti i fenomeni tangibili, dalla nascita delle stelle al funzionamento delle istituzioni sociali, sono fondati su processi materiali in ultima analisi riconducibili alle leggi della fisica, indipendentemente dalla tortuosità e dalla durata delle sequenze (pag. 305).
Comprendere la condizione umana significa anzitutto capire i geni e la cultura. E non come ambiti e funzioni autonome ma nella loro essenziale coevoluzione. L’evoluzione del cervello e quella dei comportamenti hanno proceduto insieme per milioni di anni. La radice di molti dei pericoli che sovrastano la Terra e l’umanità risiede proprio nel fatto che da alcuni millenni -dalla Rivoluzione neolitica- l’evoluzione culturale è diventata incomparabilmente più veloce di quella genetica. Tuttavia, ancora oggi
la cultura è creata dalla mente comune e ogni mente individuale a sua volta è il prodotto del cervello umano, che è strutturato geneticamente. I geni e la cultura sono dunque collegati in modo inscindibile. Ma il collegamento è flessibile, in termini finora quasi del tutto incommensurabili. Ed è nel contempo tortuoso: i geni codificano regole epigenetiche, che sono i percorsi neurologici e gli aspetti regolari dello sviluppo cognitivo grazie ai quali la mente individuale si assembla. La mente cresce dalla nascita fino alla morte assorbendo parti della cultura esistente che trova disponibili, avvalendosi di selezioni guidate dalle regole epigenetiche ereditate dal cervello individuale (144, corsivo dell’Autore).
I concetti chiave sui quali si fonda questo tentativo di unificazione della conoscenza sono i seguenti: epigenesi, natura umana, naturalismo etico, panteismo biologico.
L’epigenesi «definisce lo sviluppo di un organismo sotto l’influsso congiunto dell’eredità e dell’ambiente» (221-222). Educazione e geni, storia e biologia, appreso e innato non sono per nulla in conflitto tra di loro proprio perché «nell’ampia zona che sta a metà tra le visioni estreme del Modello Standard delle Scienze Sociali e il determinismo genetico, le scienze sociali sono essenzialmente compatibili con quelle naturali» (216).
Sta qui la necessità di un’etica naturalistica, i cui capisaldi possono essere così sintetizzati: centralità del corpo; coesistenza di passione e razionalità; rifiuto della credenza nel libero arbitrio; altruismo e fitness. L’etica nasce dal basso del corpo e delle sue esperienze e non dall’alto di una rivelazione. Certo, aggiunge Wilson, «la fiducia nel libero arbitrio è biologicamente proficua. In sua mancanza la mente, imprigionata nel fatalismo, rallenterebbe e finirebbe per deteriorarsi» (137).
L’ultima -ma decisiva- espressione della consilience è ciò che potremmo definire panteismo biologico. Wilson riconosce la profondità del bisogno del sacro nell’uomo e individua nelle realtà fisiche scoperte dalla scienza un fascino superiore a quello delle cosmologie religiose.
Qual è lo scopo finale di questa proposta scientifica? Contribuire, ancora una volta, a capire chi e cosa siamo e -da qui- comprendere una serie di gravi questioni per tentare di affrontarle meglio. Il problema principale è la progressiva scomparsa della biodiversità, causata soprattutto dalle enormi esigenze materiali della specie umana: «la crescita della popolazione può essere giustamente definita il mostro della Terra» (331) e contro di essa bisogna operare con consapevolezza, convinzione e decisione, pena la scomparsa della maggior parte degli ecosistemi, delle specie viventi e, infine, della stessa umanità.
Cervello e cultura sono dunque unificati da questo libro in una prospettiva biologica che è materialistica senza però essere riduzionistica.
 Che cos’è un rito? Come nasce? Quale funzione svolge? A queste domande cercano di rispondere da tempo discipline quali l’antropologia, l’etnologia, la sociologia della cultura, l’etologia. Un contributo importante può venire anche delle scienze della mente. Il ricco dossier di questo numero di M&C lo dimostra.
Che cos’è un rito? Come nasce? Quale funzione svolge? A queste domande cercano di rispondere da tempo discipline quali l’antropologia, l’etnologia, la sociologia della cultura, l’etologia. Un contributo importante può venire anche delle scienze della mente. Il ricco dossier di questo numero di M&C lo dimostra.
«Nella definizione dei rituali -specialmente di quelli che non riguardano la realtà quotidiana- spiccano di solito quattro caratteristiche fondamentali: ruolo del corpo, formalità, modalità e trasformazione» (A. Michaels, p. 54). A essere coinvolto in un rito è sempre l’intero corpomente in modi formalmente stabiliti e rigorosi, con modalità che differenziano lo stesso gesto se compiuto nel quotidiano o se invece inserito in una forma rituale, avendo come obiettivo una trasformazione di condizione interiore o di status comunitario.
I riti di iniziazione e di passaggio, ad esempio, sono tra i più importanti e prevedono tre fasi: di separazione dal luogo o dallo status precedente, liminale di transizione e di abolizione dell’ordine precedente, di integrazione nel nuovo luogo o nella nuova condizione. In generale, un rito fa parte di una ben precisa cultura e solo in quel contesto acquista il suo senso, si struttura in un linguaggio che spesso produce azioni -come quando un funzionario civile o religioso dichiara due persone marito e moglie-, ha una qualità estetica specifica e caratterizzante, segna una interruzione e un rallentamento del consueto flusso temporale attraverso il tempo della festa, del passaggio o del lutto.
 La plasticità del cervello è enorme, esso possiede «una capacità apparentemente infinita di cambiare, adattandosi millisecondo per millisecondo» (C.H. Kinsley e E.A. Meyer, p. 102). Fra le tante prove di tale potenza ci sono le illusioni ottiche, già illustrate nei due numeri precedenti di Mente & cervello e che qui arrivano allo spettacolare fuoco d’artificio illustrato dai titoli di tre articoli di Susana Martinez-Conde e Stephen L. Macknik: Falso movimento, Scolpire l’illusione, Cibo per la mente. Il triangolo impossibile di Penrose, le prospettive cangianti di Escher, le ombre di Shigeo Fukuda, il cubo tribarra di Guido Moretti provano come il “semplice fatto” della visione sia una realtà di inimmaginabile complessità nella quale convergono fattori cerebrali, processi evolutivi, condizionamenti culturali, attese, desideri, abitudini. Una vera e affascinante sintesi dell’identità psicosomatica della persona umana, già saputa da artisti come Giuseppe Arcimboldo -che con frutta, verdura, ortaggi, libri costruisce figure umane- e dalla lunga schiera dei suoi continuatori.
La plasticità del cervello è enorme, esso possiede «una capacità apparentemente infinita di cambiare, adattandosi millisecondo per millisecondo» (C.H. Kinsley e E.A. Meyer, p. 102). Fra le tante prove di tale potenza ci sono le illusioni ottiche, già illustrate nei due numeri precedenti di Mente & cervello e che qui arrivano allo spettacolare fuoco d’artificio illustrato dai titoli di tre articoli di Susana Martinez-Conde e Stephen L. Macknik: Falso movimento, Scolpire l’illusione, Cibo per la mente. Il triangolo impossibile di Penrose, le prospettive cangianti di Escher, le ombre di Shigeo Fukuda, il cubo tribarra di Guido Moretti provano come il “semplice fatto” della visione sia una realtà di inimmaginabile complessità nella quale convergono fattori cerebrali, processi evolutivi, condizionamenti culturali, attese, desideri, abitudini. Una vera e affascinante sintesi dell’identità psicosomatica della persona umana, già saputa da artisti come Giuseppe Arcimboldo -che con frutta, verdura, ortaggi, libri costruisce figure umane- e dalla lunga schiera dei suoi continuatori.
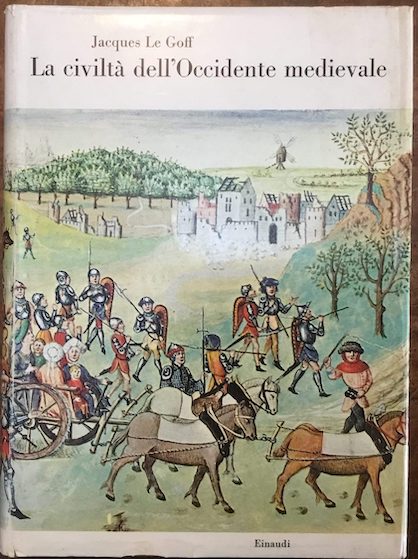
La civiltà dell’Occidente medievale
di Jacques Le Goff
(La civilisation de l’Occident médiéval, Arthaud, Paris 1964)
Trad. di Adriana Menitoni
Einaudi, Torino 1999
Pagine XX-533
Les Annales hanno trasformato la storiografia in una indagine globale sulle strutture materiali e intellettuali delle diverse epoche e società. Del Medioevo occidentale Le Goff descrive non soltanto il pullulare degli eventi ma anche e soprattutto la profondità dei parametri culturali e di mentalità. La distinzione di base è tra un Lungo medioevo, che durerebbe dal III secolo alla metà del XIX, nel quale «l’essenziale è costituito dal lungo equilibrio del modo di produzione feudale, dominato dalla ideologia cristiana» e un Corto medioevo che va dall’anno Mille alla Peste nera (p. XIV). Il testo incentra la propria analisi su quest’ultimo periodo, «il cuore del Medioevo», infanzia della nostra età e «vero inizio dell’Occidente medievale» (pp. XIII-XIV). In questi secoli la profonda unione tra il reale e l’immaginario fa scaturire idee, strutture, narrazioni, miti, obiettivi.
Due degli elementi centrali sono l’analogia e il simbolismo. La prima è una ontologia e gnoseologia dell’eco: «esiste veramente solo quello che ricorda qualcosa o qualcuno, quello che è già esistito» (188). Il secondo fa del pensare una costante ierofania, un continuo apparire di significati nascosti nelle strutture materiali. Per quanto riguarda la continuità tra il mondo antico e quello medievale, Le Goff osserva che «il pensiero antico nel Medioevo è sopravvissuto solo atomizzato, deformato, umiliato dal pensiero cristiano» (131); un autentico vandalismo condusse alla distruzione dei monumenti e delle testimonianze antiche, attuata «sia per ignoranza, sia per ostilità al paganesimo» (508).
Come esempio della ricchezza analitica di questo libro valga la discussione sul tema del feudalesimo, da non opporre -come spesso invece accade- alle strutture urbane, in quanto «feudalesimo e movimento urbano sono due aspetti di una stessa evoluzione, che organizza contemporaneamente lo spazio e la società» (105). Un altro esempio è costituito dall’evento politico e militare delle Crociate: in esse si riassumono per molti versi la violenza, il razzismo religioso, l’intrico di problemi sociali che agitarono l’Occidente medievale. Il loro portato fu secondo Le Goff completamente negativo, esse esasperarono i contrasti tra l’elemento latino e Bisanzio, la cristianità e l’islam, l’universalità e la dimensione locale, impoverirono l’economia, moltiplicarono la violenza. Prende così forma un «Medioevo delle profondità» (7), che è tempo del dolore, della miseria, della furia. Una società primitiva, tradizionalista, seminomade, povera e malata. Già le invasioni barbariche diedero il tono ai successivi dieci secoli: «le armi, la carestia, l’epidemia, le belve, questi saranno gli infausti protagonisti» (28). Pensiero e sensibilità furono impregnati di «un fondamentale pessimismo», quello di un mondo limitato e morente: «Mundus senescit» (183). L’Occidente medievale è l’universo della fame, delle miserie fisiche, dell’ostracismo verso gli stranieri, i lebbrosi, i poveri, i malati; dell’odio verso «colui che non si unisce alla maggioranza» (301); dei supplizi inauditi, della furia degli uomini tra di loro, dell’insicurezza materiale e morale. L’uscita dalla crisi prodotta dalla Grande Peste del 1348 «dà origine alla società del Rinascimento e dei tempi moderni, più aperta e, in genere, più felice dell’opprimente società feudale» (125).
In ogni caso, questo testo si pone al di là della denigrazione e dell’apologia, documentando in modo chiaro e assai ricco ogni sua affermazione, tesi, interpretazione. Il riconoscimento degli elementi di crescita individuale e collettiva è scevro da qualsiasi nostalgia; allo stesso modo, l’analisi dei numerosi aspetti di sofferenza non nasce da alcun pregiudizio e anzi parte dall’affermazione che «il fatto essenziale è comunque l’innegabile potenza creatrice del Medioevo» (XV). Le Goff offre un quadro complesso e plausibile del Medioevo, contro ogni Legenda aurea e insieme al di là di ogni ingenuo progressismo.


