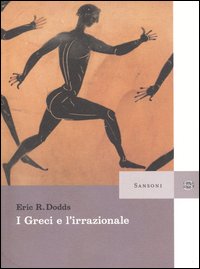Il paganesimo è vivo, nascosto ma vivo. Esso pulsa nei documenti antichi, negli inni delle civiltà più diverse, nella dimensione esoterica della dottrina cattolica e in quella popolare dei suoi culti: la Grande Madre, il Dio divorato -Dioniso- che risorge ogni volta dalla propria morte, il pantheon dei santi…Il paganesimo vive nei movimenti e negli individui che hanno ancora rispetto per la Natura e in essa percepiscono la perennità del Sacro. Il paganesimo vive in ogni forma di panteismo del passato e del presente, delle religioni come delle filosofie. Pagana è l’ebrezza di Nietzsche nei suoi euforici giorni torinesi. Pagana è la tensione neoplatonica «verso la vita e verso la luce» (Poimandres, v. 85). Pagana è l’identità fra il Tutto e il Nulla. Pagana è l’accoglienza di tutte le religioni, di tutti gli Dèi, di tutte le fedi, quel sentimento irenico che fa dire a Proclo : «Voi che reggete il timone della saggezza santa / dèi che accendete il fuoco del grande Ritorno (…) Che infine possa vedere io / l’uomo che sono e il dio / immortale in me» (Inno a tutti gli Dèi).
Pagana è la felicità senza ombre di Pan. È la vita nella sua pienezza tragica, nel suo essere qui, ora, senza senso alcuno al di là di se stessa, un essere impersonale e finalmente libero dall’asservimento agli scopi. Pan tiene ancora unita l’identità molteplice del politeismo mentre l’imporsi dei tre grandi monoteismi ha impoverito il mondo della sua strepitosa e costitutiva varietà, ha fatto vincere la coscienza egoica di un soggetto monocorde. Pan è l’unità psicosomatica che siamo. È nel trionfo del corpo che –nonostante il grido riferito da Plutarco che pose fine al mondo antico- Pan è vivo e sempre lo rimarrà. Sempre, finché un corpo umano e animale pulserà del desiderio di vita e del suo terrore.
Pagana è la consapevolezza della necessità che domina su ogni cosa, compresi gli Dèi, espressa in forma perfetta nelle Moire che intrecciano «con gesti di diamante le infinite / trame degli eventi a cui non si sfugge / Aisa, Kloto e Lachesis, / figlie della Notte» (Simonide, Alle dee del destino, vv. 2-3). Pagana è soprattutto la Luce, il sentimento solare di una vita insensata, eterna e sacra. La filosofia nasce in Grecia da questo sostrato luminoso e ctonio, nasce come unione inseparabile di teologia, antropologia, cosmologia, nasce come comprensione del posto che spetta all’umano nel mondo. Molto diversi dal Dio biblico e coranico, gli Dèi pagani non provano alcuna gelosia verso altre divinità, non pretendono una conversione totale ed esclusiva poiché gli umani non potrebbero mai allontanarsi, anche se lo volessero, dalla sacralità naturale e profonda da cui sorgono e che gli Dèi rappresentano in forme antropomorfiche. I pensatori greci arcaici (i “presocratici”) costituiscono le superstiti ramificazioni della foresta del mito, della sacralità animistica, del panteismo originario di ogni cultura umana.
Il Divino è perfezione immutabile e felice, espressa nella politeistica unità dei dodici Dèi del pantheon ellenico. «Gli dèi che fanno il mondo sono Zeus, Poseidone e Efesto; lo animano Demetra, Era e Artemis; Apollo, Afrodite e Hermes lo accordano; mentre Hestia, Atena e Ares stanno a guardia» (Salustio, Sugli dèi e il mondo, 6, 3, 1-6). Sono essenze di un mondo imperituro e ingenerato. Il divino di nulla ha bisogno e da niente può essere scalfito. Culti, sacrifici e preghiere hanno quindi senso solo dal punto di vista umano ed è agli uomini che servono. Tale fiducia offre agli esseri umani non la hybris di paradisi oltremondani ma la felicità della comprensione del qui e dell’ora nell’unità dell’eterno. È il presente, non il futuro, il tempo del paganesimo.
Ananke non proviene dall’esterno, non è la costrizione di un ordine ricevuto da altri umani. Ananke è la necessità che nasce da noi stessi, dal carattere, dalla natura, dall’insieme sottile e potente dei pensieri del corpo. Di tale natura è segno supremo l’ambiguità di Atena, la quale porta sul petto la Gorgone, orrenda immagine della Necessità. Il paganesimo accetta il terribile delle nostre nature, senza attribuirne le dinamiche interiori e collettive alla sola malattia. Il paganesimo sottrae l’umano alla patologizzazione delle morali monoteistiche per cogliere il tratto di gentilezza e di misericordia –e non solo di ferocia e di indifferenza- che intesse la vita del mito.
Il pullulare di movimenti religiosi settari, la grande diffusione dell’astrologia e delle varie forme di esoterismo in una società disincantata, economicistica e ipertecnicizzata, confermano ancora una volta che senza una spiegazione altra rispetto al semplicemente visibile gli esseri umani non riescono proprio a vivere. In effetti, ogni dichiarazione di morte del Divino mostra di essere un po’ troppo prematura. Il Sacro è una categoria che va ben al di là del religioso. Esso comprende la Natura e il suo ordine, la Società e la sua potenza, gli Umani e il loro senso. Nei politeismi pagani non ha senso contrapporre naturale e soprannaturale poiché la molteplicità degli Dèi si coniuga alla unità monistica del cosmo, nella quale convergono identità e differenza, singolarità e pluralità, maschio e femmina, vita e morte, senso e significato, somatico e psichico.
Il paganesimo costituisce, nella varietà delle sue espressioni storiche che vanno dall’Oriente e dal Mediterraneo antichi sino ai politeismi polinesiani e africani, una forma nella quale l’umano esplica la propria tensione verso l’intero, prima di ogni dualismo e oltre ogni speranza. La sua logica non chiede rinuncia o ascesi, non perviene agli estremi di un impossibile amore universale –pronto naturalmente a capovolgersi in ipocrisia e in guerra- ma fa delle relazioni umane il luogo naturale di un conflitto non mortale, preparato sempre alla mediazione della prestazione e del possesso. Il paganesimo è meno di una religione perché non possiede dogmatiche, caste sacerdotali e aspirazioni alla trascendenza. Ed è più di una religione poiché costituisce un integrale stile di esistenza radicato nella corporeità gloriosa delle statue e degli idoli, nella ricchezza delle relazioni e dei conflitti, nella benedizione del tempo. Di questo tempo e non dell’eterno. Il paganesimo offre la serenità dell’inevitabile e relativizza le pretese di assoluto. La grandezza del paganesimo sta nel sapere e non nello sperare. Anche per questo una rappresentazione adeguata del divino pagano sono i kouroi, il loro enigmatico sorriso.
Non si tratta di reinventare improbabili culti neo-pagani o di indugiare in un paganesimo estetico e letterario; si tratta di comprendere le ragioni per le quali ancora oggi l’Europa non può non dirsi pagana e da questa comprensione far discendere delle coordinate esistenziali differenti, davvero nuove perché radicate in una identità ancora viva. Allo storicismo, alla temporalità lineare e irreversibile che postula un significato intrinseco della storia -intrinseco poiché radicato nella volontà dell’unico Dio- va opposta la consapevolezza (anche cosmologica) che non si dà alcun inizio assoluto del tempo e ogni passato è ancora da venire. Il divino non abita nel totalmente Altro, al di là e al di fuori della natura, delle cose, del mondo. Dio si dispiega qui e ora.
La contraddizione sta in ogni società, individuo, esperienza; la differenza significa ricchezza, confronto, arricchimento reciproco; la vita stessa è molteplicità di forme, obiettivi, strutture. Sensibile alla dissonanza, il paganesimo è l’opposto dell’evangelico «tutti siano uno» (Gv., 17, 11-23). Il precetto dell’unità giustifica ogni inquisizione ed è una delle radici dei moderni totalitarismi, i quali hanno tentato di rendere una l’umanità a partire da un principio fortissimo, esclusivo, salvifico, che fosse la razza, la classe o il libero commercio.
Abitare il Tempo in forma pienamente sacrale significa farlo nei modi di un vivere familiare, iniziale, straordinario eppur misurato. Di questo soggiornare, la filosofia è la forma suprema. Non c’è stata caduta ma il limite fa da sempre parte dell’essere, non esiste colpa se non quella di esistere. Non ci sono peccati al di fuori dell’ignoranza «di chi eravamo, di che cosa siamo diventati, di dove eravamo, di dove siamo stati gettati, del luogo verso cui tendiamo, di che cosa possa liberarci, di che cosa sia davvero stato la nascita, di come possiamo riscattarla e finalmente rinascere» (Excerpta ex Theodoto, 78). La conoscenza di tutto questo è la Filosofia. Non una fede o un procedimento soltanto logico ma un sapere intuitivo della condizione umana e cosmica; non una teologia ma un’esperienza completa, sofferta e gloriosa dello stare al mondo; non un ripetere formule altrui ma il ripercorrere da sé il cammino di ogni ente dalla Pienezza al Limite.
L’umanità è intrisa di Luce dionisiaca e di titanica cecità. L’umanità è una goccia del Sacro annegata nel mare dell’ignoranza. Lo scopo vero dell’esistenza, quello per il quale merita esserci, consiste nel conoscere questa nostra natura, nel riconoscerla, nella immensa serenità che tale sapere offre. La comprensione intellettuale non è mai -se è davvero comprensione- separata dai gesti e dal corpo. Il Corpo è sacro. I corpi degli Dèi che gli umani hanno bisogno di sentire accanto a sé, impressi nel marmo e nel bronzo. Le chiese cristiane sono davvero povere e malinconiche. Esse sostituiscono al tripudio della carne il gusto del soffrire, alla gloria di Zeus quella di un condannato a morte, sostituiscono ad Afrodite -la divinità che solleva la propria veste in un gesto di divertita conquista- la paura del corpo. Ma il bisogno della Bellezza Sacra permane, aere perennius, e con esso quella degli Dèi. Morto il Dio monoteistico (ebraico, cristiano, islamico), vive il Divino molteplice, panteistico, enoteistico.
Nelle pieghe del mondo. È lì che gli Dèi si sono nascosti ma è nello spazio sacro, nel loro tempo eterno, che abitano ancora. «Ταῦτα δὲ ἐγένετο μὲν οὐδέποτε, ἔστι δὲ ἀεί·» (Salustio, 4, 8, 26), queste cose mai avvennero e sempre sono.