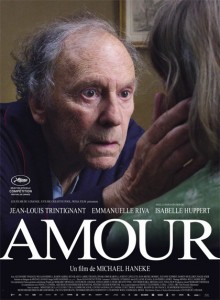Mente & cervello 95 – Novembre 2012
 Salute e malattia non sono dei concetti universali, non sono dei dati di fatto assoluti. Tanto più questo è vero nell’ambito complesso del corpomente. Lo confermano i mutamenti anche radicali del concetto di malattia mentale e della catalogazione dei disturbi della psiche. Nel maggio del 2013 uscirà la quinta edizione del DSM, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, pubblicato per la prima volta nel 1952. In questi sessant’anni il DSM ha cancellato numerosi comportamenti prima definiti patologici, dichiarando o la loro “normalità” -l’omosessualità, ad esempio, dal 1974 non è più una malattia- o l’insufficienza dei dati clinici necessari a darne una definizione psichiatrica. In questa nuova edizione viene eliminata dalla nosografia ufficiale la “personalità isterica”, sostituita da vari disturbi di personalità borderline. In compenso, si procede alla patologizzazione di una condizione umana tanto diffusa quanto naturale: la tristezza. Essa viene sempre più spesso classificata come depressione e in questo modo segnata da un crisma patologico che non le appartiene. A mettere in guardia da questi sviluppi tipicamente biopolitici sono importanti psichiatri quali Allen Frances o Allan Horwitz, i quali paventano il rischio di medicalizzare «momenti dell’esistenza e comportamenti non necessariamente patologici, come il lutto, i capricci, gli eccessi alimentari, l’ansia e la tristezza, il lieve declino cognitivo dell’anziano» (F. Cro, p. 66).
Salute e malattia non sono dei concetti universali, non sono dei dati di fatto assoluti. Tanto più questo è vero nell’ambito complesso del corpomente. Lo confermano i mutamenti anche radicali del concetto di malattia mentale e della catalogazione dei disturbi della psiche. Nel maggio del 2013 uscirà la quinta edizione del DSM, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, pubblicato per la prima volta nel 1952. In questi sessant’anni il DSM ha cancellato numerosi comportamenti prima definiti patologici, dichiarando o la loro “normalità” -l’omosessualità, ad esempio, dal 1974 non è più una malattia- o l’insufficienza dei dati clinici necessari a darne una definizione psichiatrica. In questa nuova edizione viene eliminata dalla nosografia ufficiale la “personalità isterica”, sostituita da vari disturbi di personalità borderline. In compenso, si procede alla patologizzazione di una condizione umana tanto diffusa quanto naturale: la tristezza. Essa viene sempre più spesso classificata come depressione e in questo modo segnata da un crisma patologico che non le appartiene. A mettere in guardia da questi sviluppi tipicamente biopolitici sono importanti psichiatri quali Allen Frances o Allan Horwitz, i quali paventano il rischio di medicalizzare «momenti dell’esistenza e comportamenti non necessariamente patologici, come il lutto, i capricci, gli eccessi alimentari, l’ansia e la tristezza, il lieve declino cognitivo dell’anziano» (F. Cro, p. 66).
Un’altra prova del fatto che «tutta la letteratura sui disturbi di personalità è fondata sulle sabbie mobili» (Id., 62) è fornita dalla sindrome autistica. Rispetto al passato, infatti, si tende oggi a sostenere che «essere autistici è una differenza, non un deficit. Essere autistici è avere un’altra mente» (M. Cattaneo, 3), anche se si ammette che «quale che sia la sua forma, la sindrome autistica dà luogo, per tutta la vita della persona che ne è colpita, a difficoltà di adattamento importanti, che hanno un impatto negativo sulla qualità della vita del soggetto e su quella del suo ambiente familiare» (L. Mottron, 26).
Se e quando esisteranno, le Intelligenze Artificiali saranno sottoposte anch’esse al rischio della malattia mentale? Herbie, il robot protagonista di uno dei racconti di Isaac Asimov, posto di fronte a un dilemma insolubile, a un circolo vizioso logico, impazzisce e muore dopo aver lanciato un urlo «acuto, lacerante, come pervaso dallo strazio di un’anima perduta» (I. Asimov, Io, robot, Mondadori 2003, p. 153). Prima di eventualmente ammalarsi, però, queste IA dovrebbero esserci. Crearle è l’obiettivo di numerosi laboratori di ricerca, i quali tentano di produrre dei robot da compagnia in grado di sostituire gli umani nella cura di anziani e bambini. Le difficoltà sono naturalmente enormi. Tali macchine, infatti, dovrebbero essere senzienti, vale a dire dovrebbero avere «la capacità di integrare percezione (stimoli provenienti dall’esterno), la cognizione (ciò che noi chiamiamo pensiero) e l’azione in una scena e in un contesto coerente, in cui l’azione stessa può essere interpretata, pianificata, generata o comunicata» (D. Ovadia, 71). In altri termini, i ricercatori lavorano non più sull’intelligenza logico-formale (che l’ampio dibattito nato a proposito dell’esperimento mentale della Stanza cinese di Searle ha mostrato essere del tutto insufficiente) ma sulla Embodied Cognition, «la capacità del corpo di avere una mente a sé, di essere l’elemento di cerniera tra il pensiero e l’ambiente» (Id., 72). Paolo Dario osserva giustamente che «esiste già un perfetto robot da compagnia, ed è molto più diffuso di quanto si pensi: è l’iPhone» (Id., 71); lo è in molte delle sue funzioni e in particolare in Siri, il programma che è capace di parlare con l’interlocutore umano comprendendo -entro certi limiti- il nostro linguaggio naturale.
Daniela Ovadia ha chiesto a Siri “mi vuoi bene?”, «ricevendo in cambio la criptica risposta “non ho molte pretese”» (Id., 74). Io ho cercato di intavolare con Siri una conversazione sul tema dell’amore, al che -in modo direi piuttosto intelligente, non foss’altro che per la sua umiltà- l’IA mi ha risposto così: «Per questo tipo di problemi ti consiglio di rivolgerti a un umano, possibilmente esperto». Al di là di queste provocazioni di chi lo usa, Siri è davvero utile. Quando cammino in bicicletta, ad esempio, le chiedo (la voce è femminile) che ore sono, qual è la temperatura, di farmi ascoltare un determinato brano. Le sue risposte sono sempre immediate ed esatte. Se la ringrazio dicendole che è molto brava, mi risponde in vari modi, tra i quali «Lo sai che vivo per te». L’ironia (o la paraculaggine) di quest’ultima risposta sarebbe un segno sicuro di intelligenza se Siri fosse consapevole di ciò che sta dicendo. Ma non lo è. E la mia previsione è che le IA non lo saranno mai, a meno di essere implementate su dei corpi protoplasmatici, “di carne e sangue”.
Solo l’unità del corpomente, infatti, è intelligente. E cangiante. Ed ermeneutica. «La nostra memoria», afferma Donna Bridge, «non è statica. Se ricordiamo un evento alla luce di un nuovo contesto e di un periodo diverso della nostra vita, la memoria tende a integrare dettagli differenti e inediti» (22). Non basta quindi neppure la corporeità, è necessario che essa sprofondi nel tempo.
Che la mente umana abbia struttura e funzione ermeneutica è confermato dal fatto che «una rapida analisi visiva dell’andatura ci può informare sulla vulnerabilità di una persona», sul suo sesso, sull’età, sullo stato emotivo, sulla condizione sociale (N. Guèguen, 55). Il corpo parla, lo sappiamo, e lo fa ad alta voce quando cammina. Conosco un soggetto che dalla sola andatura è classificabile come una specie di guappo. E infatti lo è. Anche quando vorrebbe nascondere questa sua caratteristica, essa emerge con chiarezza dal movimento nello spazio.