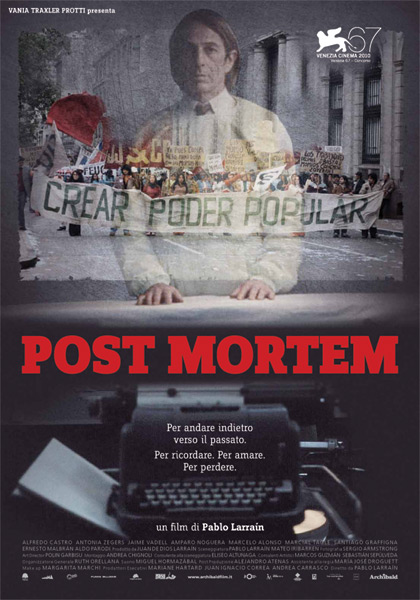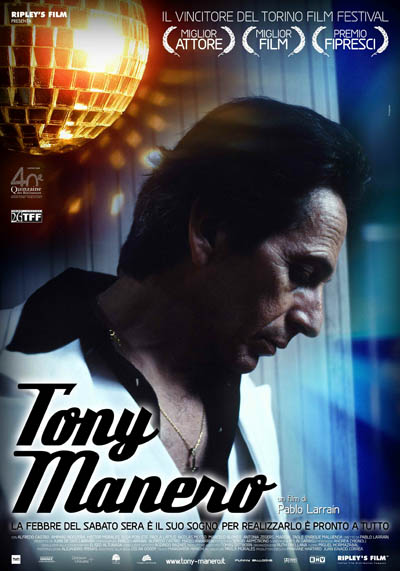Alejandro Jodorowsky
La danza della realtà
(La danza de la realidad, 2001)
Trad. di Michela Finassi Parolo
Feltrinelli, 2009
Pagine 343
Una vita dolorosa trasformata in forza per sé e per gli altri. Una pratica del corpo umano che ne mostra per intero la fragilità e la potenza. Un ricordare che comprende. Anche tutto questo è l’autobiografia nella quale Jodorowsky spiega la genesi di alcune delle azioni per le quali è noto -la psicomagia, lo psicosciamanesimo– e anche spesso travisato. Qui invece tutto è molto chiaro e -non sorprenda- razionale.
Uno dei capitoli più intensi è il primo, dedicato all‘infanzia a Tocopilla, località marina nel nord del Cile. Un’infanzia colma di luce e di sofferenza per il non amore dei genitori, in particolare del padre Jaime. Da qui, infatti, tutto si genera negli umani, in questi «mammiferi a sangue caldo» i quali «nel fondo della loro animalità nutrono il bisogno di venire protetti, alimentati e riparati dal freddo dai corpi del padre e della madre. Se questo contatto manca, il piccolo è condannato a morire. L’angoscia più grande di un essere umano è quella di non essere amato dalla madre, o dal padre o da entrambi; se questo avviene, l’anima è segnata da una ferita che continua a infettarsi. Il cervello che non ha trovato il proprio centro autentico, luminoso, che lo manterrebbe in uno stato di perenne estasi, vive nell’angoscia. […] Tra due mali, il cervello sceglie sempre il minore, e poiché il male peggiore è non essere amati, l’individuo non riconosce questo disamore: piuttosto che sopportare il dolore atroce di averlo sulla coscienza preferisce deprimersi, inventarsi una malattia, rovinarsi, fallire» (pp. 294-295).
Il bisogno d’essere amati viene qui colto nella sua vera scaturigine, che non è psicologica né tantomeno sentimentale ma è esattamente biologica.
Per le complesse vicissitudini della famiglia e a causa del carattere del padre, Alejandro afferma che «lo sperma che mi generò venne lanciato come uno sputo» (50) e questo formò sin da subito il nucleo di dolore che costella questa vita pur così intensa e colma di energia. Dolore generato da molti abbandoni, a cominciare dal trasferimento dalla natia Tocopilla a Santiago, dove comunque l’Autore si dedicò a quel «modo di vivere bellissimo e demenziale» (81) che era possibile nel Cile degli anni Quaranta e Cinquanta, al riparo dalla guerra che devastava il mondo e dove era possibile di tutto, come in un enclave di libera follia. Fu questa follia, unita al coraggio e a una inconsueta forza di volontà, a spingere Jodorowsky a lasciare anche questo rifugio naturale per trasferirsi a Parigi, senza alcuna certezza professionale ed economica. Accettare la solitudine come un’occasione, l’abbandono come un inizio, significò entrare ancora più a fondo nel dolore umano per comprenderlo e per immaginare alcune vie d’uscita. Questo accadde, infatti, attraverso l’incontro con i numerosi artisti e filosofi che popolavano la capitale francese. Jodorowsky è stato mimo, poeta, attore, regista e -dal lungo soggiorno in Messico- taumaturgo e sciamano. Ma che cosa significano parole come queste, termini così impegnativi e anche bizzarri? Insieme alla miriade di eventi narrati, il senso del libro sta nella risposta a tale domanda.
Lo sfondo, sin dall’inizio, è dato da una visione olistica del mondo, dove ogni parte è legata al tutto, in una corrispondenza radicale anche quando non appare. Concezione, come si vede, genuinamente greca e rinascimentale: «Essere, spazio e tempo sono la stessa cosa» (313). All’interno di tale unità spaziotemporale, il corpomente davvero τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα (“è in qualche modo tutto”, Aristotele, De anima, III, 431b, 20) ed è sulla sua potenza e universalità che si fonda la possibilità di guarire attraverso delle tecniche che si ispirano certamente alla magia tradizionale messicana ma che da Jodorowsky vengono reinterpretate in una chiave assai più “occidentale” essendo egli del tutto consapevole del fatto che «non si può cambiare pelle e liberarsi della propria cultura razionale giocando a fare il ‘primitivo’» (242).
Che cos’è dunque la malattia? È «una sorta di sogno organico» (301) e soprattutto è «una mancanza di consapevolezza impregnata di paura» (321). Una paura, un limite, una ferita che si generano assai prima della nascita di un determinato individuo –un dato che anche altre ipotesi cliniche tendono a confermare– e hanno pertanto a che fare con la storia familiare, con un’anamnesi che intride certo il corpo dei soggetti -«il corpo intero è una memoria» (305)- ma che affonda nella vicenda di coloro dai quali si germina: «le sofferenze famigliari, come gli anelli di una catena, si ripetono di generazione in generazione» (36); «le frecce, scoccate molte generazioni prima, giungono fino a noi obbligandoci a mettere in atto pulsioni autodistruttive» (282). Non trovare il proprio posto nel mondo e nel tempo è la fonte di tutte le sofferenze; sentirsi rifiutati da coloro cui dobbiamo l’esserci, la madre anzitutto, è certamente tragedia. Nulla è infatti più potente, per la specie di mammiferi che siamo, della donna dentro la quale i nostri corpi si formano, plasmano, diventano.
«Quando la madre per un motivo molto forte […] consciamente o no vuole eliminare il feto, questo desiderio di eliminazione, di morte, s’innesta nel ricordo intrauterino della creatura che sta per nascere e poi, durante la sua vita terrena, impartisce gli ordini. Senza rendersene conto, l’individuo si sente un intruso, è come se non avesse il diritto di vivere» (294).
Pur nella varietà dei suoi gradi e delle manifestazioni, si tratta di una sofferenza che nessuno può estirpare dall’esterno, «non si può guarire nessuno; si può soltanto insegnare a guarirsi da soli» (114). La guarigione, quando avviene, accade tramite la volontà di colui che sta subendo il male. Psicomagia e psicosciamanesimo sono anche dei potenti placebo, effetto che anche la medicina contemporanea giudica sempre più capace di guarire davvero le persone: «Lo psicosciamano deve guidare il paziente con accortezza, per farlo credere in ciò in cui lui crede. Se il terapeuta non crede, non c’è guarigione possibile» (322). Malattia e salute, disastro e guarigione non sono ma accadono. Avvengono, come ogni cosa, nel tempo: «Il potere non risiede né nel passato né nel futuro, che sono le sedi della malattia: la salute si trova qui, adesso. Possiamo abbandonare immediatamente le cattive abitudini se la smettiamo di identificarci con il passato. Il potere dell’ “adesso” cresce insieme all’attenzione sensoriale» (322).
Dunque da una parte il cosiddetto “imbroglio sacro”, un metodo che attraverso alcuni trucchi attuati con destrezza dà al paziente l’impressione che lo sciamano sia in grado di sostituire un organo, un arto, la parte malata del corpo, con organi nuovi e sani; dall’altra parte, ma non in contraddizione con la prima, l’emergere di una consapevolezza sempre più lucida delle radici profonde del proprio male, della scaturigine psicosomatica della malattia.
Come si vede, qui Jodorowsky attua una vera e propria opera di disincanto e di razionalizzazione, anche perché a questo punto le tecniche e i riferimenti possono diventare i più diversi nei differenti contesti culturali, antropologici e spaziotemporali; l’importante è che il malato sappia e senta di costituire il convergere di forze totalmente fisico-biologiche stratificate nei corpi e nel tempo, e che sia ancora possibile trasformarle in parte costruttiva di sé e non in un insuperabile tormento. Il libro è pieno di esempi che mostrano che cosa questo empiricamente significhi. In ogni caso, «la psicomagia si basa sostanzialmente sul fatto che l’inconscio accetta il simbolo e la metafora, dando loro la stessa importanza che darebbe a un fatto reale. I maghi e gli sciamani delle culture più antiche lo sapevano bene» (280).
Questi metodi terapeutici hanno l’obiettivo che la medicina si è posta sin dall’inizio, con Ippocrate e Galeno, di ricostituire l’equilibrio infranto degli elementi, l’armonia tra il tutto e le sue parti. Non si tratta «di trovare un filtro magico» che impedisca «di morire bensì, soprattutto, di imparare a morire nella felicità» (149).
Le parole conclusive del testo sono costituite dall’ultimo verso di una poesia dedicata alla conoscenza. Dicono questo: «Non so chi sono, ma so che non sono colui che non sa» (323). È solo un cenno ma è assai significativo.