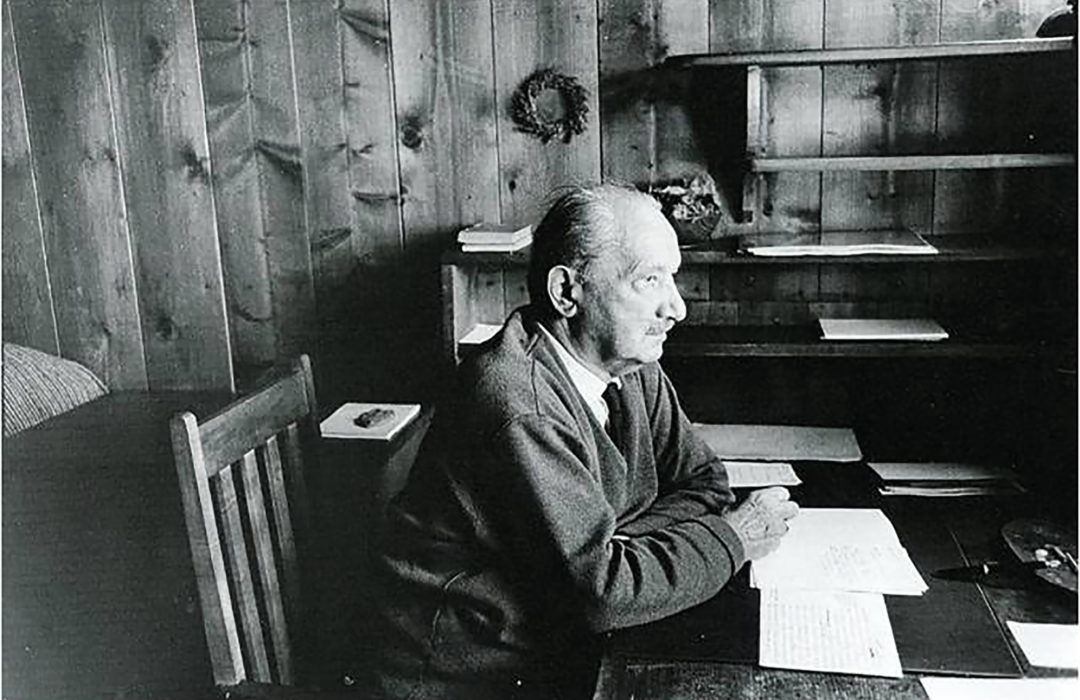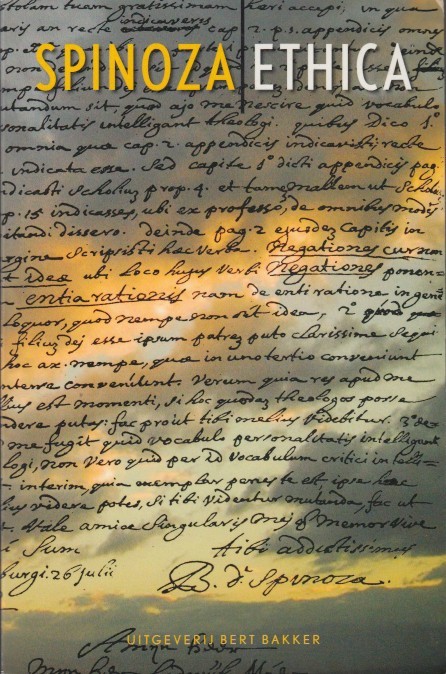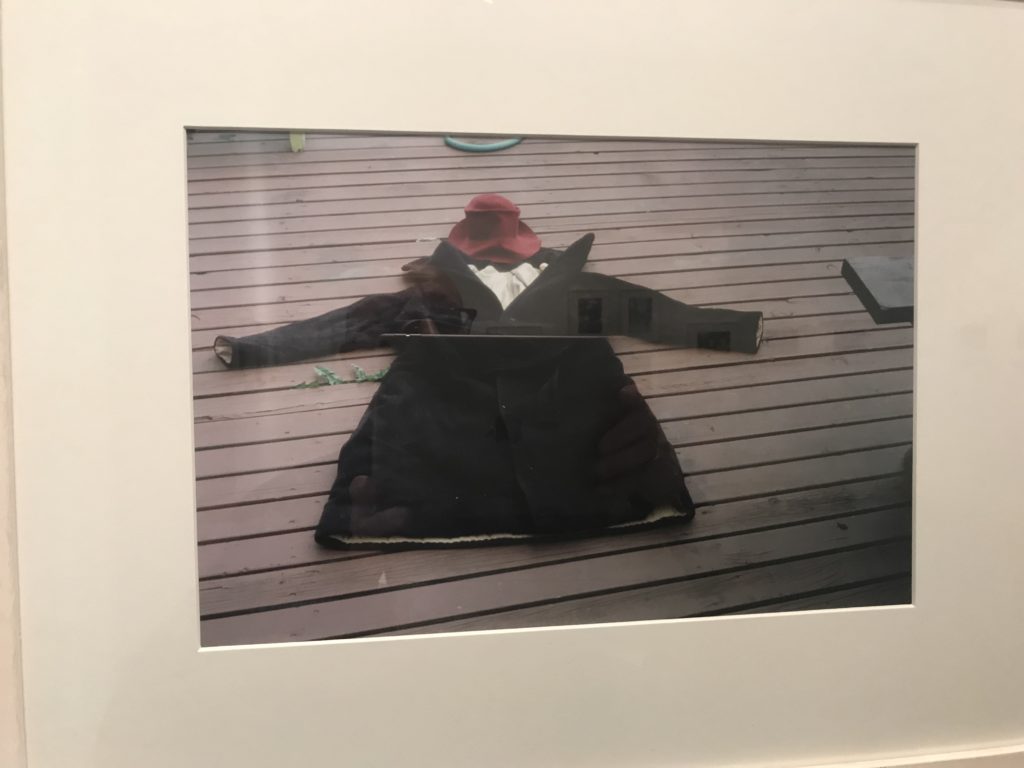Transfert
di Massimiliano Russo
Italia, 2017
Con: Alberto Mica (Stefano Belfiore), Massimiliano Russo (Stefano), Paola Roccuzzo, Clio Scirè Saccà, Rossella Cardaci, Rosario Pizzuto
Trailer del film
Dentro i meandri della psicoterapia, sullo sfondo del cielo e del mare di Catania, nella notte e nella metropolitana, tra le carte e le parole, sui letti e davanti agli specchi che moltiplicano le figure, le scompongono, le agglutinano, le separano, le dissolvono e ne ratificano il dolore.
Quando Stefano Belfiore riceve e ascolta i suoi pazienti c’è sempre uno specchio dietro di lui, che dei pazienti riflette la presenza. Ma che cosa significa presenza? In quanti modi si può essere presenti alla mente? La descrizione degli altri umani è anche la descrizione di ciò che noi stessi siamo, della differenza che vorremmo marcare, dell’identità che a loro ci accomuna.
Una sceneggiatura matura, nella quale non ci sono affermazioni superflue e battute fuori posto. Una tensione che va seguita dall’inizio alla fine con molta cura, per non smarrire un filo che si intrica, si dipana, si scioglie e ci sorprende. Una recitazione scandita e mediterranea, esagerata e sottile, sorridente e fredda. L’intrico può sembrare estremo ma -come sappiamo da Pirandello e da altri gorghi- la vita vissuta è a volte più improbabile della vita immaginata.
C’è chi vuole diventare psicoterapeuta e chi, invece, vuole diventare paziente.