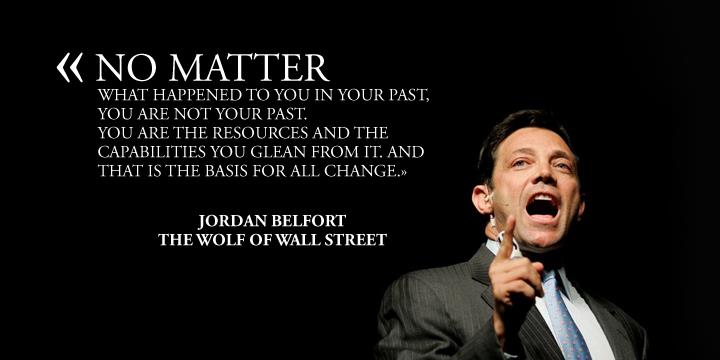Mente & cervello 97 – Gennaio 2013
 Gran parte della sofferenza interiore che proviamo è costituita da ciò che nel gergo psicologico si chiama ruminazione, condizione nella quale «la mente è assorbita da pensieri ripetitivi e focalizzati su precise preoccupazioni» (C. André, p. 44). Uno dei significati delle pratiche meditative consiste nel liberarsi da tale condizione. Per il buddhismo, ad esempio, «la meditazione ha per obiettivo l’eliminazione della sofferenza mentale, come pensieri ossessivi o emozioni negative» in modo da raggiungere l’equanimità, «ossia la facoltà di conservare uno stato emotivo stabile» (A. Lutz, 34-35). Se, come recita un proverbio cinese, non possiamo impedire agli uccelli di volare sopra le nostre teste, possiamo però evitare che facciano il nido tra i nostri capelli. Proprio perché siamo una profonda unità psicosomatica
Gran parte della sofferenza interiore che proviamo è costituita da ciò che nel gergo psicologico si chiama ruminazione, condizione nella quale «la mente è assorbita da pensieri ripetitivi e focalizzati su precise preoccupazioni» (C. André, p. 44). Uno dei significati delle pratiche meditative consiste nel liberarsi da tale condizione. Per il buddhismo, ad esempio, «la meditazione ha per obiettivo l’eliminazione della sofferenza mentale, come pensieri ossessivi o emozioni negative» in modo da raggiungere l’equanimità, «ossia la facoltà di conservare uno stato emotivo stabile» (A. Lutz, 34-35). Se, come recita un proverbio cinese, non possiamo impedire agli uccelli di volare sopra le nostre teste, possiamo però evitare che facciano il nido tra i nostri capelli. Proprio perché siamo una profonda unità psicosomatica
la riduzione dello stress attraverso la meditazione è di grande interesse per i ricercatori, perché può essere studiata anche a livello biologico dettagliato, in particolare nell’ambito della psiconeuroimmunologia, che studia le connessioni strette e reciproche tra lo stato psicologico e l’attività del sistema nervoso e di quello immunitario, definita «medicina psicosomatica» (C. André, 45).
Non a caso Francisco Varela -più volte citato in questo numero di Mente & cervello– ha coniugato in modo argomentato ed efficace il buddhismo e le neuroscienze. Il buddhismo, infatti, «non invoca l’esistenza di un essere supremo o di una trascendenza. Si propone piuttosto di rimediare alla sofferenza umana attraverso una conoscenza migliore dell’Io e praticando regole semplici e universali» (F. Rosenfeld, 28), le quali sembra abbiano un effetto positivo anche sui telomeri, probabilmente perché queste strutture vengono danneggiate dallo stress, che la meditazione contribuisce invece a tenere sotto controllo. In ogni caso, come la filosofia, «in realtà la meditazione non deve servire a niente» (Id., 31) se non a vivere con misura e a pensare con radicalità.
Esattamente il contrario di ciò che succede nel trafelato, ossessivo e idiota stile di vita di molti contemporanei, tra i quali spiccano i brokers, gli umani che investono e speculano nelle Borse di tutto il mondo. Uno studio neuropsicologico dei loro comportamenti mostra sino a che punto siano dettati da irrazionalità, tanto da confermare l’ipotesi «che gli alti e bassi della borsa sono correlati alla logica della nostra mente più che ai dati economici» (M. Reiter, 81). Hanna e Antonio Damasio hanno scoperto che pazienti con danni permanenti nella corteccia orbitofrontale -e quindi assai meno soggetti alle emozioni- sono capaci di prendere decisioni finanziarie più vantaggiose rispetto agli individui sani. Le crisi che investono le borse sono quindi anche crisi di panico e non soltanto tecnico-economiche. E il panico, si sa, è contagioso. Un celebre esperimento di Salomon Asch dimostrò quanto sia forte il  condizionamento del gruppo -anche temporaneo- del quale si fa parte. Se vi chiedono a quale delle tre linee di destra corrisponda la lunghezza di quella di sinistra nella figura qui accanto, nessuno dubiterà che si tratti della n. 2. E tuttavia se alcuni nostri compagni di esperimento -segretamente d’accordo con lo sperimentatore- dichiarano più volte e senza esitazioni che la risposta corretta è la 1 o la 3, molti di noi alla fine concorderanno con questa risposta, per quanto contrasti in modo clamoroso con l’evidenza: «È grave che un singolo operatore prenda decisioni sbagliate […]. Ma in più, seguendo l’istinto del branco, gli investitori miopi, che vendono in preda al panico, si contagiano a vicenda. Un esperimento classico dello psicologo sociale Salomon Asch aveva indicato già nel 1951 che è difficile resistere a una forte pressione dei pari» (Id., 85).
condizionamento del gruppo -anche temporaneo- del quale si fa parte. Se vi chiedono a quale delle tre linee di destra corrisponda la lunghezza di quella di sinistra nella figura qui accanto, nessuno dubiterà che si tratti della n. 2. E tuttavia se alcuni nostri compagni di esperimento -segretamente d’accordo con lo sperimentatore- dichiarano più volte e senza esitazioni che la risposta corretta è la 1 o la 3, molti di noi alla fine concorderanno con questa risposta, per quanto contrasti in modo clamoroso con l’evidenza: «È grave che un singolo operatore prenda decisioni sbagliate […]. Ma in più, seguendo l’istinto del branco, gli investitori miopi, che vendono in preda al panico, si contagiano a vicenda. Un esperimento classico dello psicologo sociale Salomon Asch aveva indicato già nel 1951 che è difficile resistere a una forte pressione dei pari» (Id., 85).
Pressione che costituisce parte del senso di fallimento che molte persone provano per non aver avuto dei figli, tanto da affidarsi in modo totale alle diverse tecniche di fecondazione artificiale e a cadere «in una sindrome ossessivo-compulsiva che induce chi ne è affetto a organizzare tutta la propria vita intorno al tentativo di procreare» (D. Ovadia, 74). Uno dei più gravi nodi psicologici ed esistenziali legato a questa condizione è la vera e propria «perdita di senso della vita. L’idea di invecchiare senza un figlio rende il trascorrere del tempo acutamente doloroso. Solo chi riesce a riconoscere l’importanza del proprio contributo sociale indipendentemente dalla presenza di un bambino può superare questo che sembra essere lo scoglio più duro» (Id., 76). Si tratta dell’ennesima dimostrazione che l’evento del procreare ha ben poco a che fare con l’amore verso l’altro, il nascituro, ed è radicato piuttosto in una forma biologica di amore di sé, di proiezione psichica del proprio narcisismo in un figlio, di esistenziale paura di dover morire per sempre senza lasciare i propri geni in giro per il mondo.
Come avevo già accennato su questo sito, tra le espressioni del conformismo la società dello spettacolo ne amplifica alcune in modo radicale e patologico. Varie serie televisive non soltanto durano anni e decenni ma entrano nella vita di milioni di persone come parte reale e decisiva della loro identità. «Legioni di adolescenti, professionisti, casalinghe, impiegati, persone di ogni età e senza caratteristiche particolari» incontrano «parte dei loro amici -della loro famiglia allargata, si potrebbe dire- all’interno della tv o del computer», tanto che «la fine della propria serie tv preferita può scatenare sintomi depressivi e un senso di angoscia e smarrimento simile a quella generata dalla fine di un amore» (P.E. Cicerone, 88 e 93). L’articolo che ne parla indulge un po’ troppo in un paragone tra serie televisive come le soap opera o fiction quali Lost, Sex and the City, Dr. House e la grande letteratura epica e romanzesca. Un’analogia insensata poiché per la nostra specie l’attenzione visuale, lo scorrere passivo delle immagini che attraversano il nostro orizzonte, è pura natura; il leggere è attività costruttiva della mente, è cultura diventata natura. Anche per questo la lettura costituisce un livello evolutivo assai superiore rispetto alla dipendenza televisiva, la cui essenza è quindi pre-umana e subumana.