Homo fugit velut umbra
(Passacaglia della Vita)
di Anonimo (1657)
Voce Marco Beasley – Ensemble L’Arpeggiata (2002)
Versione in html
Versione video
In siciliano si impreca contro la «morte buttana». È vero, la morte sembra una puttana che si dà a tutti, uomini e donne, indistintamente. E tuttavia questo detto rivela non la natura del morire ma la miseria della condizione umana, il suo terrore, l’arroganza di pretendere un destino diverso da quello degli altri viventi. La Passacaglia della Vita (di anonimo, pur se spesso attribuita erroneamente a Stefano Landi) esprime invece la necessità del morire, il Sein zum Tode che ci rende ciò che siamo. È il limite temporale, infatti, che dà senso all’esserci.
Homo fugit velut umbra è un canto magnifico e danzante, eseguito da Marco Beasley con l’ensemble L’Arpeggiata diretto da Christina Pluhar, una delle più creative musiciste contemporanee. Forse anche Leonard Cohen (Who by Fire) si è ispirato a questo barocco trionfo della morte.
Oh come t’inganni se pensi che gli anni
Non han da finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
È un sogno la vita che par sì gradita
Che breve gioire, bisogna morire
Non val medicina, non giova la china
Non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Non voglion sperate in arie bravate
Che taglia da dire bisogna morire
Lustrina che giova parola non trova
Che plachi l’ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Non si trova modo di scioglier ‘sto nodo
Non vale fuggire, bisogna morire
Non muta statuto, non vale l’astuto
‘Sto colpo schernire bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Oh morte crudele, a tutti è infedele
Ognuno svergogna, morire bisogna
È pura pazzia o gran frenesia
A dirsi menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna.
Si more cantando, si more sonando
La cetra zampogna, morire bisogna
Si more danzando, bevendo, mangiando
Con quella carogna morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna.
I giovani putti e gli uomini tutti
Son da incenerire, bisogna morire
I sani, gl’infermi, i bravi, gl’inermi
Tutti han da finire, bisogna morire.
E quando nemmeno ti penti nel seno
Ti vien da finire, bisogna morire.
Se tu non ti pensi hai persi li sensi
Sei morto e puoi dire: bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
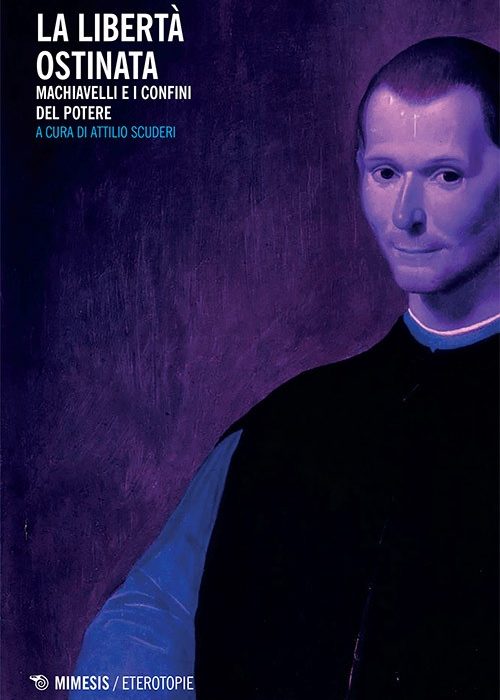





 anche quando non sono attraversati dall’amore. Gorgogliano i rancori, il reciproco disprezzo. Tramontano le convenzioni, le buone maniere, l’educazione antica che evita di sbranarci a ogni istante. I libri erano la salvezza dall’incessante lotta che ci affligge, da questa nostra natura di mammiferi di grossa taglia pronti alla passione della copula per riprodurre se stessi nelle cellule e pronti alla passione della guerra per sfoltire da queste cellule il pianeta.
anche quando non sono attraversati dall’amore. Gorgogliano i rancori, il reciproco disprezzo. Tramontano le convenzioni, le buone maniere, l’educazione antica che evita di sbranarci a ogni istante. I libri erano la salvezza dall’incessante lotta che ci affligge, da questa nostra natura di mammiferi di grossa taglia pronti alla passione della copula per riprodurre se stessi nelle cellule e pronti alla passione della guerra per sfoltire da queste cellule il pianeta.


