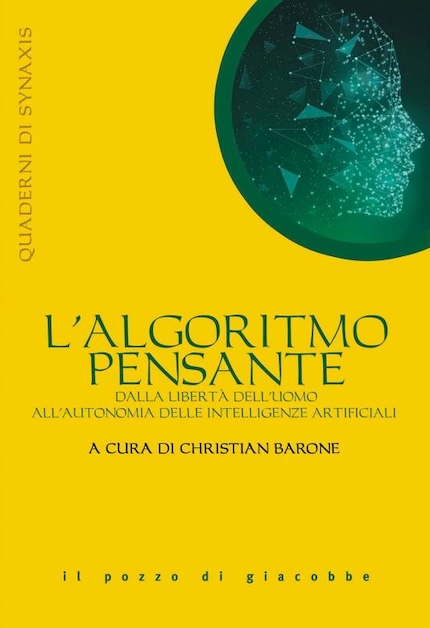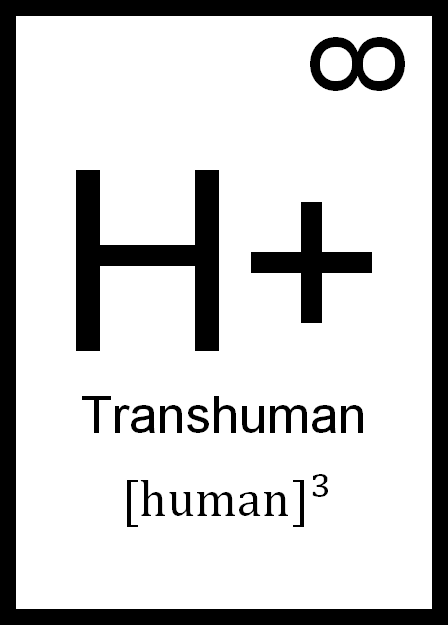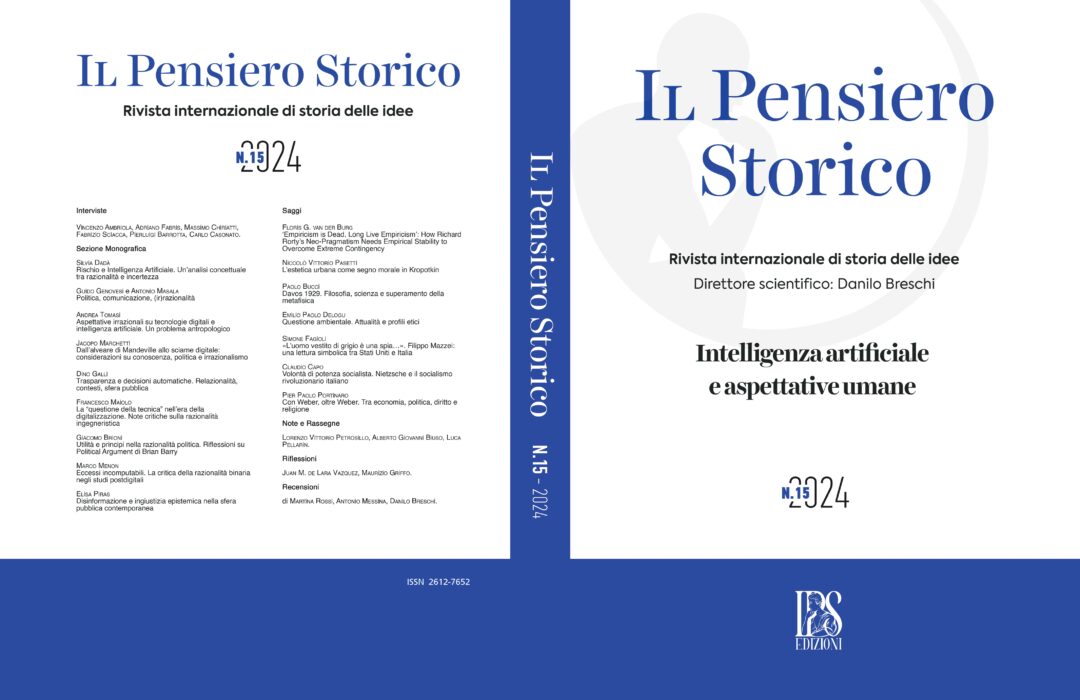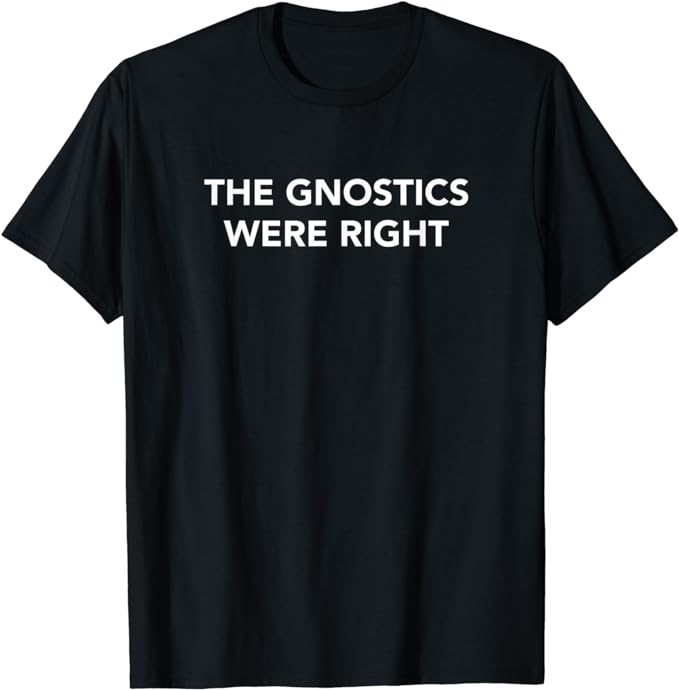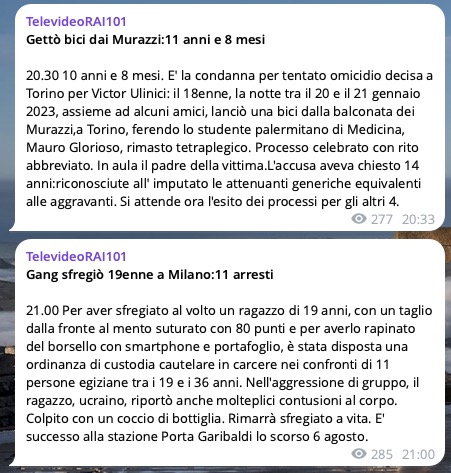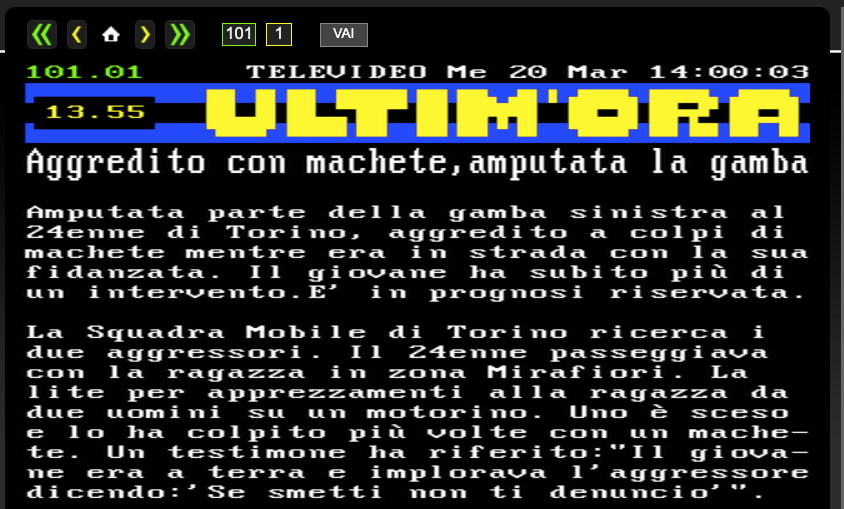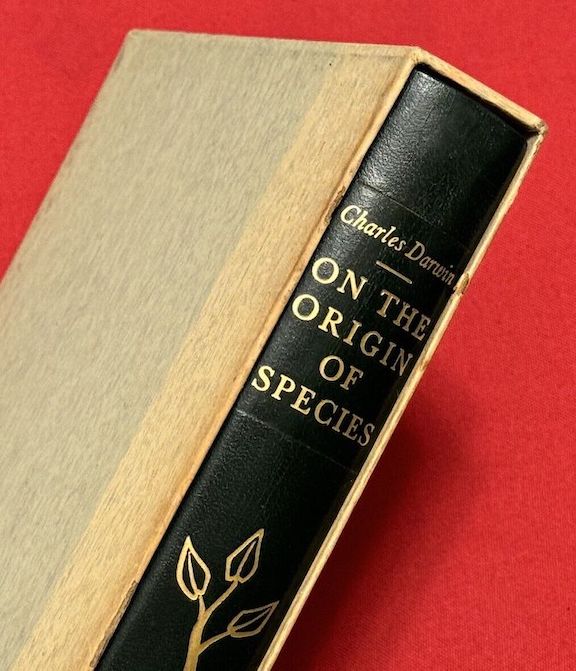Georg W.F. Hegel
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
(Enzyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817-1830)
Traduzione, prefazione e note di Benedetto Croce
Prefazioni di Hegel tradotte da Angelica Nuzzo
Introduzione di Claudio Cesa
Mondadori, 2008
Pagine CVII-651
[Data l’ampiezza un poco inconsueta del testo che segue, ne metto a disposizione una versione in pdf]
Al di là dell’astrazione illuministica e intellettualistica che vorrebbe imporre alla realtà i pensamenti e i desideri degli umani.
Al di là del moralismo «che tiene i sogni delle sue astrazioni per alcunché di verace, ed è tanto gonfio del suo dover essere, che anche nel campo politico va predicando assai volentieri; quasi che il mondo aspettasse quei dettami per apprendere come deve essere ma non è» (§ 6, pp. 10-11).
Al di là del sentimentalismo che «si adopra a indagare le particolarità, passioni e debolezze degli altri uomini, le cosiddette pieghe del cuore umano» (§ 377, p. 371) e che mostra tutta la sua micidiale forza di incomprensione, equivoco e miseria nel discorso pubblico – i Social Network ad esempio – che fa costantemente appello alle esperienze di vita, ai casi concreti, al sapere che cosa si prova (al ‘vieni in un ospedale se vuoi capire il covid’), psicologismo sentimentalistico che merita parole assai chiare come queste:
Quando un uomo, discutendo di una cosa, non si appella alla natura e al concetto della cosa, o almeno a ragioni, all’universalità dell’intelletto, ma al suo sentimento, non c’è altro da fare che lasciarlo stare; perché egli per tal modo si rifiuta di accettare la comunanza della ragione, e si richiude nella sua oggettività isolata, nella sua particolarità (§ 447, p. 439).
Al di là della presunzione che si lega alla parola filosofia, che molti pensano di poter praticare soltanto perché sono dotati di un encefalo e vivono le loro esperienze; che vuol dire presunzione di fare filosofia senza averla mai studiata:
A questa scienza tocca spesso lo spregio che anche coloro che non si sono affaticati in essa, s’immaginano e dicono di comprendere naturalmente di che cosa tratti, e d’esser capaci, col solo fondamento di un’ordinaria coltura e in particolare dei sentimenti religiosi, di filosofare e giudicar di filosofia. Si ammette che le altre scienze occorra averle studiate per conoscerle, e che solo in forza di siffatta conoscenza si sia facoltati ad avere un giudizio in proposito. Si ammette che, per fare una scarpa, bisogna avere appreso ed esercitato il mestiere del calzolaio, quantunque ciascuno abbia la misura della scarpa nel proprio piede, e abbia le mani e con esse la naturale abilità per la predetta faccenda. Solo per filosofare non sarebbero richiesti né studio, né apprendimento, né fatica (§ 5, p. 8).
A queste piccole e grandi miserie, ai tanti equivoci, ai pregiudizi e all’incomprensione, alla superficialità e alla banalità, Hegel oppone la filosofia intesa come «la considerazione pensante degli oggetti» (§ 2, p. 4); la filosofia come storia del proprio inverarsi e divenire, la filosofia come storia della filosofia ma anche e soprattutto la filosofia come sistema poiché «un contenuto ha la sua giustificazione solo nel momento del tutto, e fuori di questo è un presupposto infondato o una certezza meramente soggettiva; molti scritti filosofici si restringono in tal modo ad esprimere soltanto pareri e opinioni» (§ 14, pp. 22-23).
Con questo approccio sistematico e oggettivo, Hegel coglie alcuni elementi fondamentali e fondanti dell’umano e del tempo. Dell’umano come vita animale coglie il «sentimento d’insicurezza, di angoscia, d’infelicità» (§ 368, p. 362), l’essere l’individuo un epifenomeno della specie che ne fa uno strumento della propria sopravvivenza, riproduzione, moltiplicazione, la sua destinazione mortale: «Il genere si mantiene solo mediante la rovina degli individui; i quali nel processo dell’accoppiamento adempiono alla loro destinazione e, in quanto non ne hanno un’altra più elevata, vanno così incontro alla morte» (§ 370, p. 363), morire che è la vera attività dell’individuo, il significato della parte, il destino del singolo, le cui passioni effimere non vanno giudicate, condannate, respinte ma ancora una volta comprese, poiché «la passione non è né buona né cattiva: questa forma esprime soltanto che un soggetto ha posto in un unico contenuto tutto l’interesse vivente del suo spirito, dell’impegno, del carattere, del godimento. Niente di grande è stato compiuto, né può esser compiuto, senza passione. È soltanto una moralità morta, e troppo spesso ipocrita, quella che inveisce contro la forma della passione in quanto tale» (§ 474, p. 468).
La comprensione della natura parziale dei singoli, degli enti, degli eventi, permette a Hegel di dar conto del tempo come sinonimo della stessa realtà e come sinonimo del nulla nel quale la realtà costantemente si riversa. Non è nel tempo che tutto nasce, muore, accade ma «il tempo stesso è questo divenire, nascere e morire; è l’astrarre che insieme è; è Kronos, produttore di tutto e divoratore dei suoi prodotti. – Il reale è diverso dal tempo, ma gli è altresì essenzialmente identico» (§ 258, p. 234) in quanto la struttura finita e diveniente delle cose rende ogni elemento finito – e ogni cosa è finita – del tutto «passeggiero e temporale», come si vede dal fatto che il finito si comporta di fronte alla negatività come «alla potenza che lo domina [zu seiner Macht]» (Ibidem). Il tempo è l’incontro tra la realtà e il nulla, dove l’una non sarebbe possibile senza l’altra. Un convergere che chiamiamo divenire:
Le dimensioni del tempo, il presente, il futuro e il passato, sono il divenire come tale dell’esteriorità, e la risoluzione di quel divenire nelle differenze dell’essere, da un lato, che è trapasso in nulla, e del nulla, dall’altro, ch’è trapasso in essere. Lo sparire immediato di queste differenze nella individualità è il presente, come ora [questo istante, als Jetzt], il quale ora, essendo, come l’individualità, insieme esclusivo e affatto continuo negli altri momenti, non è altro che questo trapasso del suo essere in niente e del niente nel suo essere (§ 259, 235).
Il presente è l’istante che non è pronto a dileguare nel nulla ma che consiste proprio in tale dileguare. L’insieme dei dileguanti nello spaziotempo è l’assoluto e da ciò segue «la seconda definizione dell’assoluto: che esso è il niente» (§ 87, p. 102), il quale è quindi l’altro nome dell’essere. La verità dell’essere e del niente nella loro unità è appunto il divenire, che «è la vera espressione del risultato di essere e niente come l’unità di essi: e non è soltanto l’unità dell’essere e del niente, ma è l’irrequietezza in sé» (§ 88, p. 107).
Questi contenuti ed esiti teoretici costituiscono il nucleo sempre fecondo della metafisica hegeliana, che però li coniuga a qualcosa che nella sua essenza è l’opposto di una comprensione oggettiva della finitudine della parte nella perfezione dell’intero. Tale opposto consiste nell’essere quella hegeliana anche una filosofia radicalmente religiosa, cristiana e dunque antropocentrica.
In una delle Prefazioni, quella alla seconda edizione del 1827, Hegel scrive con chiarezza che «la religione può sì sussistere senza la filosofia, ma la filosofia non può sussistere senza la religione, ché anzi la include in sé» (p. XCIII), una tesi che attraversa tutta l’Enzyclopädie sino alla fine, sino alla identificazione di eticità, religione e Stato (§ 552). Questa religione è una ben precisa religione, è il cristianesimo nella sua forma luterana. Una fede che si presenta come razionale, che crede nella teleologia della storia, nella storia come Provvidenza, «in fondo» alla quale sta «uno scopo finale in sé e per sé, (§ 549, p. 520) e che in questo fine accomuna «il principio della coscienza religiosa e della coscienza etica» in «una e medesima cosa nella coscienza protestante» (§ 552, p. 536).
Data la natura radicalmente antropocentrica del cristianesimo, una filosofia apologetica di tale religione non può che cadere in una forma di antropocentrismo assoluto, come quello che innerva questa pagina:
Allorché gli individui e i popoli hanno accolto una volta nella loro mente il concetto astratto della libertà per sé stante, nient’altro ha una forza così indomabile; appunto perché la libertà è l’essenza propria dello spirito, e cioè la realtà stessa. Intere parti del mondo, l’Africa e l’Oriente, non hanno mai avuto questa idea, e non l’hanno ancora: i Greci e i Romani, Platone e Aristotele, ed anche gli stoici non l’hanno avuta: essi sapevano, per contrario, soltanto che l’uomo è realmente libero mercé la nascita (come cittadino ateniese, spartano ecc.) o mercé la forza del carattere e la coltura, mercé la filosofia (lo schiavo, anche come schiavo e in catene, è libero). Quest’idea è venuta nel mondo per opera del cristianesimo; pel quale l’individuo come tale ha valore infinito, ed essendo oggetto e scopo dell’amore di Dio, è destinato ad avere relazione assoluta con Dio come spirito, e far che questo spirito dimori in lui, cioè l’uomo è in sé destinato alla somma libertà (§ 482 , pp. 473-474).
La sintesi e il culmine di un antropocentrismo che disprezza profondamente la materia, il cosmo, gli astri, la luce, è un’annotazione di filosofia della natura che si legge a conclusione del paragrafo 248: «E, anche quando l’accidentalità spirituale, l’arbitrio, giunge fino al male, perfino il male è qualcosa d’infinitamente più alto che non i moti regolari degli astri e l’innocenza delle piante; perché colui, che così erra, è pur sempre spirito» (p. 223).
Il paragrafo 392 ribadisce la patetica sensazione/convinzione di superiorità dell’umano sul cosmo, individuando nello spirito una separazione e differenza dalla materia cosmica, separazione che negli altri animali non si dà e che anche per questo li renderebbe inferiori: «La storia del genere umano non è in dipendenza dalle rivoluzioni nel sistema solare; né le vicende degli individui dalle posizioni dei pianeti. […] Con la libertà dello spirito che comprende sé stessa in modo più profondo, spariscono anche codeste poche e meschine disposizioni, che si fondano sul convivere dell’uomo con la natura. L’animale, invece, come la pianta, vi rimane sottoposto» (p. 384).
Una filosofia così radicalmente umanistica rappresenta un momento assai chiaro dello smarrimento dell’umano rispetto all’intero, della dimenticanza dell’ontologia, della incomprensione dell’essere, pensato come il più generico e vuoto dei concetti, «l’elemento immediato semplice e indeterminato» (§ 85, p. 101). Anche a proposito della prova ontologica dell’esistenza di Dio, Hegel ribadisce che «pel pensiero, nel riguardo del contenuto, non si può dar nulla di più povero che l’essere» (§ 51, p. 66).
E invece sta proprio nella centralità dell’essere rispetto agli enti, dell’intero rispetto alle sue parti, della materia cosmica rispetto alla materia cerebrale che elabora idee sul mondo, sta nella struttura del mondo la ragione che rende possibile la redenzione filosofica, il fatto che la filosofia sia «appunto quella dottrina, che libera l’uomo da un’infinita moltitudine di scopi e mire finite, e lo fa verso di esse indifferente, in modo che per lui è il medesimo che quelle cose sieno o non sieno» (§ 88, p. 104).
L’Enzyclopädie si chiude con una citazione aristotelica, dal libro λ della Metafisica (1072b). Se davvero il divino è ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀΐδιος, vita perfetta ed eterna, è perché esso è diverso dall’umano e dai suoi limiti, che sono certamente anche limiti psicologici e somatici ma prima di tutto e fondamentalmente sono limiti ontologici.