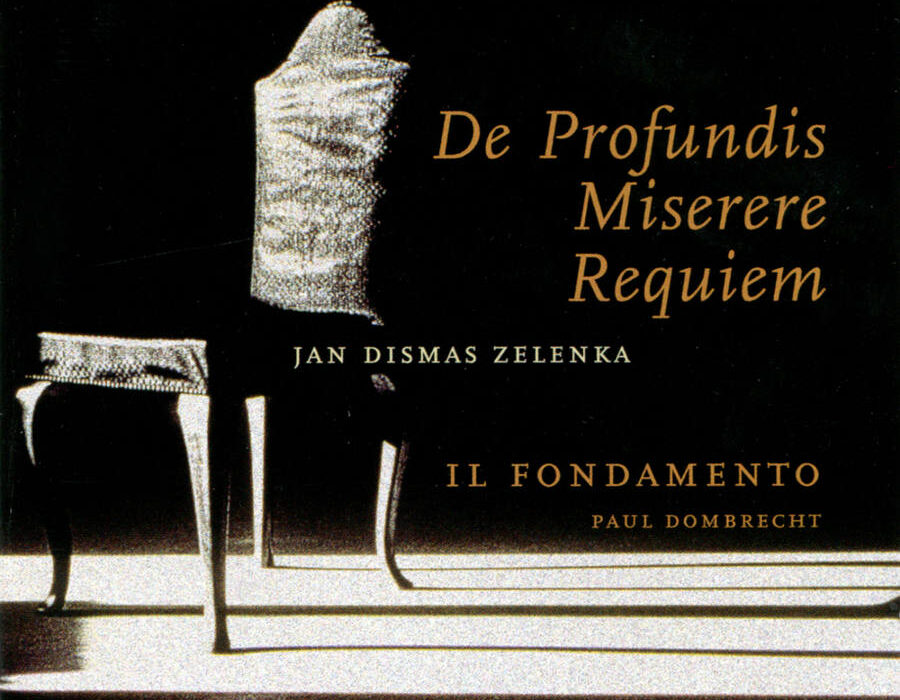La comune
(Kollektivet)
di Thomas Vinterberg
Danimarca, 2016
Con: Ulrich Thomsen (Erik), Trine Dyrholm (Anna), Lars Ranthe (Ole), Martha Sofie Wallstrøm Hansen (Freja), Helene Reingaard Neumann (Emma)
Trailer del film
Perché le tante Comuni sorte nella seconda metà del Novecento sono, dopo tempi più o meno rapidi, fallite?
Se ne sono occupati saggi sociologici, libri autobiografici, documentari storici. Una risposta narrativa la dà un film di Thomas Vintenberg ambientato a Copenaghen nel 1975.
Un architetto e una giornalista ereditano una grande e magnifica casa. Erik vorrebbe venderla, Anna invece vorrebbe chiamare amici e anche estranei e costruirvi una comune. Vince lei e l’esperienza comincia. Consuete relazioni, amicizie e conflitti sino a quando Erik si innamora di una sua studentessa, lo dice alla moglie e la ragazza viene accolta «in prova» nella comune. Anna, che pure aveva proposto questa soluzione, crolla sentendo e vedendo giorno e notte la presenza di Emma nella vita di Erik. E non poteva che essere così.
I sentimenti umani sono infatti e ovviamente più forti di qualunque idea politica, esigenza etica, afflato psicologico. I sentimenti umani si fondano su alcune strutture universali, pur se variamente declinate nel tempo e nello spazio, tra le quali il gaudio inquieto, il possesso, la prestazione, la ferocia, la colpa (me ne sono occupato in varie sedi, di recente in Animalia, pp. 108-113).
La struttura del possesso è centrale. Può e deve essere attutita, può essere mimetizzata, può declinarsi in forme simboliche e non soltanto tangibili ma rimane inemendabile. Le tante forme del possesso – amori, amicizie, gerarchie, luoghi, case, oggetti – sono gli autentici scopi delle azioni animali, anche le più generose.
In Animalia ho appunto scritto che «meriti, qualità, abilità e talenti, uniti al fondamentale ingrediente che è la forza di imporli, creano giorno dopo giorno le gerarchie professionali, sentimentali, politiche. In ciascuno di questi ambiti l’obiettivo è sempre il possesso. Gli amici si hanno poiché chiamiamo così chi è sùbito pronto a venire incontro a qualche nostra esigenza, fosse soltanto quella di non stare soli. La soddisfazione dello stare insieme, utilizzandosi a vicenda, raggiunge il suo culmine nell’amore. La complessità di questo sentimento non può nascondere la sua scaturigine fondamentale: detenere il monopolio nell’uso di un essere umano. È certo possibile, come fa Descartes, distinguere fra amore di benevolenza e amore di concupiscenza ma la loro fonte comune è il desiderio, senza il quale nessun affetto, nessuna passione può nascere. Tutte e quattro le forme di amore descritte da Stendhal – l’amore come fisicità, passione, capriccio, vanità – affondano nell’illusione che permette alla ‘cosa immaginata’ di diventare ‘la cosa esistente’ e ciò perché nei sentimenti umani esiste solo ciò che si teme o che si desidera. La natura solipsistica dell’amore è la più evidente conferma del suo essere puro possesso di sé tramite il fantasma dell’altro e possesso dell’altro attraverso i fantasmi dell’io» (p. 109).
Tutto questo emerge con chiarezza dalla coinvolgente narrazione che Vintenberg fa del volto di Anna, delle sue espressioni, dei capelli, dell’incedere che da sicuro si fa incerto, della presa d’atto che il mondo non funziona come lei immaginava funzionasse.
L’inganno antropologico e moralistico, che sta a fondamento di molte idee e pratiche non soltanto degli anni Settanta del Novecento ma anche degli anni Venti del XXI secolo, si sbriciola nei due ambienti in cui questo film accade: il primo sono le aule e lo studio universitario di Erik; il secondo è costituito dai continui pranzi, cene e riunioni della comune nella quale ha trasformato la sua bella dimora altoborghese.
Il risultato è una efficace metafora della superficialità con la quale idee egualitarie vengono incistate dentro la società liberale. L’effetto non può che essere la menzogna, il politicamente corretto.