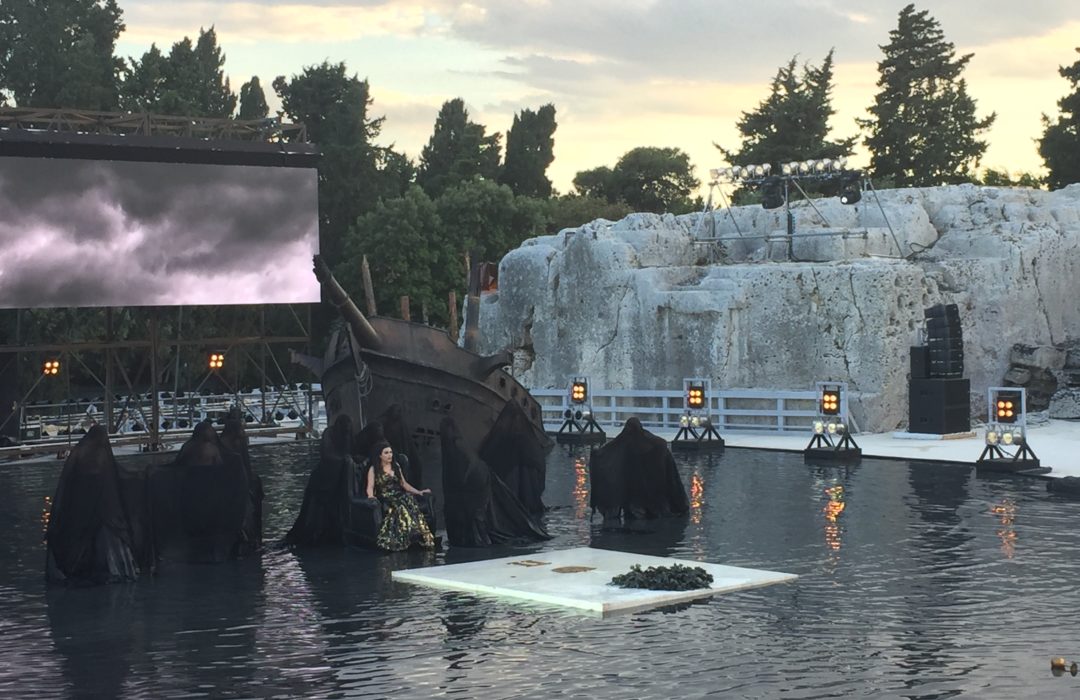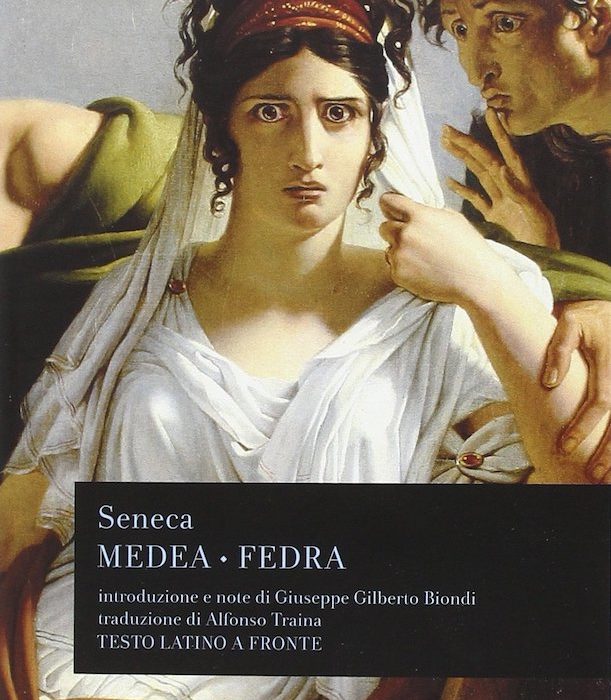Teatro Greco – Siracusa
Troiane
(Τρώαδες)
di Euripide
Traduzione di Alessandro Grilli
Con: Maddalena Crippa (Ecuba), Marial Bajma Riva (Cassandra), Elena Arvigo (Andromaca), Viola Graziosi (Elena), Paolo Rossi (Taltibio), Graziano Piazza (Menelao), Francesca Ciocchetti (Atena), Massimo Cimaglia (Poseidone), Riccardo Scalia (Astianatte), Clara Galante (Corifea), Elena Polic Greco (capocoro), Fiammetta Poidomani (chitarrista)
Regia di Muriel Mayette-Holtz
Sino al 23 giugno 2019
Atena e Poseidone osservano i vinti e i vincitori. E stabiliscono di portare a compimento la fine di Troia ma di dare anche amaro ritorno agli Achei. Nessun amore per gli umani in questi dèi. E basta esistere e vedere il mondo per comprendere che nessun amore proviene dal divino. Ecuba lo sa, ora che la città, la casa, i figli, persino il nipote Astianatte vanno morendo e sono alla rovina. Ecuba sa e dice che «di quelli che sono fortunati non stimate felice nessuno mai, prima che muoia» (le traduzioni, tranne una, sono di Filippo Maria Pontani). La fortuna, il caso, gli dèi danzano infatti sulle vite individuali e sulla storia miserrima della specie che si crede grande e per la quale meglio sarebbe stato invece non venire al mondo. «Io dico», afferma Andromaca, «che non nascere equivale a morire. Ma d’una vita triste è meglio morte. Sofferenza non c’è per chi non sente il male».
Il male della storia e il male dell’individuo. Quello della storia perché «folle è il mortale che distrugge le città. Getta nello squallore templi e tombe, sacro asilo d’estinti; ma poi finisce per perire lui», afferma Poseidone; il male dell’individuo immerso in passioni antiche, nuove, pervadenti. Nell’uno e nell’altro caso i Greci appaiono in questa tragedia feroci e disumani, sino ad accettare il consiglio dell’implacabile Odisseo di togliere la vita ad Astianatte affinché il figlio di Ettore non abbia, crescendo, a vendicarsi. Il bambino viene gettato giù dalle mura della città in fiamme.
Prorompe dentro la distruzione Cassandra. Lucida e invasata, lucida perché invasata, sa che ad Agamennone che se l’è presa come concubina lei porterà ogni sciagura, vede «la lotta matricida che le mie nozze desteranno, e lo sterminio della famiglia d’Atreo», esulta sapendo che «vittoriosa giù fra i morti arriverò: / che la casa dei carnefici, degli Atridi, spianterò». Il momento nel quale irrompe Cassandra sulla scena, con la sua torcia con il suo canto, il momento nel quale appare questa potenza struggente, luminosa e dionisiaca, è il più alto della messa in scena, l’unico nel quale appaiano in essa i Greci. Per il resto, infatti, è uno spettacolo sobrio sino alla piattezza; con un Paolo Rossi del tutto fuori ruolo, che interpreta il personaggio chiave di Taltibio come se recitasse in un cabaret milanese; e soprattutto con i cori di Euripide cancellati e sostituiti da canzonette leggere e sentimentali, accompagnate da una chitarra. Si può e si deve interpretare un testo greco come si ritiene più consono ma non lo si può sostituire -o, peggio, ‘sintetizzare’– con testi melensi.
Nietzsche aveva ancora una volta ragione, anche se forse non per le ragioni che credeva: davanti al male della storia, davanti al male che è il respiro, Euripide enuncia il disincanto che alla tragedia greca pone fine. Il poeta fa pronunciare infatti a Ecuba una preghiera che trascolora i nomi degli dèi, persino quello di Zeus, nella forza senza fine e senza senso della materia agra: «ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, / ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, / Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν, / προσηυξάμην σε: πάντα γὰρ δι᾽ ἀψόφου / βαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτ᾽ ἄγεις», ‘Tu che sostieni il mondo e che nel mondo hai dimora, chiunque tu sia, Zeus, inconcepibile enigma, che tu sia necessità della natura o pensiero degli uomini, io ti prego: tutte le cose mortali le governi secondo giustizia, procedendo in silenzio lungo il tuo percorso’ (vv. 884-888; trad. di Alessandro Grilli).
In questa magnifica preghiera panteistica una donna e una regina al culmine della disperazione riconosce con dolorosa intelligenza che tutto è giusto ciò che agli umani accade, anche che «la gran città / non più città s’è spenta e non c’è più».
L’innocente causa di tutto questo, Elena, appare davanti a Menelao e si fa avvocata formidabile di se stessa, somigliando le sue parole a quelle argomentate e profonde con le quali Gorgia tesse l’elogio di questa creatura bellissima e fatale. Persino le donne troiane che la odiano ammettono che l’argomentare di Elena è convincente. Come nella tragedia a lei specificatamente dedicata, Euripide coniuga l’indicibile bellezza a una intelligenza raffinata e superiore. Elena sostiene infatti che preferendo lei – e non i doni che offrivano Era e Atena – Alessandro Paride risparmiò ai Greci la sconfitta contro i Troiani. Scegliendo lei nell’impeto di un totale desiderio, Paride fu asservito da Afrodite mentre di Afrodite decretava la vittoria. E quindi, afferma Elena rivolgendosi a Menelao, «la dea devi punire, devi farti superiore a Zeus, che regna sì sugli altri dèi, ma di quella è uno schiavo».
Se schiavo è Zeus di Afrodite, quanto più gli umani lo saranno. Lo sa bene anche Ecuba, sa che il nome di questa invincibile dea è simbolo e sintesi della fragilità di tutti: «Ogni follia per l’uomo s’identifica con Afrodite». Fino a dire parole che sembrano nostre, di noi disincantati ma sempre persi umani del futuro: «οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ», ‘colui che amò una volta ama per sempre’ (v. 1051)