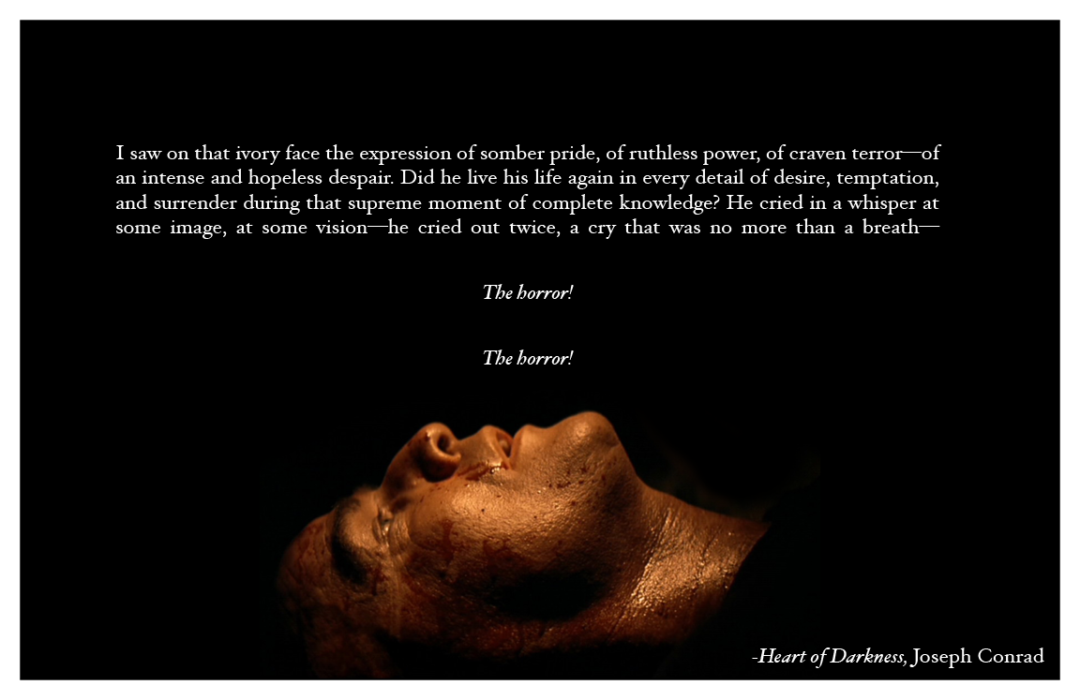Abdel Kechiche
Venere nera
(Venus noire)
Con: Yahima Torrès (Saartjie), Andre Jacobs (Caezar), Olivier Gourmet (Réaux)
Francia-Italia-Belgio, 2011
Trailer del film
 Nel 1810 a Londra una donna del Sudafrica viene esposta come fenomeno da baraccone. Il suo guardiano domatore la mostra al pubblico in una gabbia da cui la tira fuori come fosse una selvaggia, suscitando un’esitazione eccitante. È la Venere ottentotta. Pochi anni dopo, a Parigi, la donna viene presentata in feste aristocratiche più o meno licenziose. L’eco dello spettacolo arriva ai naturalisti dell’Università che pagano i suoi padroni per studiarne il corpo e misurarne ogni dettaglio, soprattutto le grandi natiche e la particolarissima estensione delle piccole labbra della vulva. Quando la donna rifiuta di mostrarsi completamente nuda agli scienziati viene picchiata dai suoi sfruttatori. La degradazione subita la conduce a un bordello e poi per le strade, sino a che sifilide e tubercolosi non la uccidono. Questa la vicenda di Saartjie Baartman. Il corpo venne venduto dopo la morte agli stessi naturalisti che non erano riusciti a studiarla in vita come pretendevano. Un calco dell’intera persona a grandezza naturale, gli organi genitali e il cervello conservati nella formalina costituirono oggetto di lezione di anatomia razziale da parte di insigni studiosi, tra i quali Georges Cuvier. Costoro affermarono con sicurezza che la conformazione del cranio, del volto e del sedere di questa “femmina” la avvicinava assai più all’orangotango che all’Homo sapiens sapiens. Soltanto nel 2002 i resti e lo scheletro di Saartjie vennero restituiti al Sudafrica e trovarono finalmente sepoltura.
Nel 1810 a Londra una donna del Sudafrica viene esposta come fenomeno da baraccone. Il suo guardiano domatore la mostra al pubblico in una gabbia da cui la tira fuori come fosse una selvaggia, suscitando un’esitazione eccitante. È la Venere ottentotta. Pochi anni dopo, a Parigi, la donna viene presentata in feste aristocratiche più o meno licenziose. L’eco dello spettacolo arriva ai naturalisti dell’Università che pagano i suoi padroni per studiarne il corpo e misurarne ogni dettaglio, soprattutto le grandi natiche e la particolarissima estensione delle piccole labbra della vulva. Quando la donna rifiuta di mostrarsi completamente nuda agli scienziati viene picchiata dai suoi sfruttatori. La degradazione subita la conduce a un bordello e poi per le strade, sino a che sifilide e tubercolosi non la uccidono. Questa la vicenda di Saartjie Baartman. Il corpo venne venduto dopo la morte agli stessi naturalisti che non erano riusciti a studiarla in vita come pretendevano. Un calco dell’intera persona a grandezza naturale, gli organi genitali e il cervello conservati nella formalina costituirono oggetto di lezione di anatomia razziale da parte di insigni studiosi, tra i quali Georges Cuvier. Costoro affermarono con sicurezza che la conformazione del cranio, del volto e del sedere di questa “femmina” la avvicinava assai più all’orangotango che all’Homo sapiens sapiens. Soltanto nel 2002 i resti e lo scheletro di Saartjie vennero restituiti al Sudafrica e trovarono finalmente sepoltura.
Il film si chiude proprio sulle immagini reali dell’arrivo delle spoglie di Saartjie Baartman in Africa. Si apre, invece, su una lezione tenuta da Cuvier, nella quale lo scienziato espone le proprie opinioni razziste come un dato del tutto evidente, empiricamente e razionalmente evidente. Merito non piccolo di questo film è dunque contribuire a smascherare ancora una volta la presunta neutralità delle scienze dure, le quali in realtà -come tra gli altri Foucault e Kuhn hanno dimostrato- costituiscono uno dei più formidabili strumenti al servizio del potere degli Stati e dei pregiudizi diffusi nelle società. Ma non è questo a dare senso e valore al film. Neppure lo è la critica al razzismo che intride la storia europea come quella di tutti gli altri continenti e civiltà. La magia di Venus noire sta nell’essere una descrizione dello sguardo umano. Non succede infatti nulla in questo film. Tutto quello che accade è dentro e intorno al corpo di Saartjie, nei suoi occhi. Il suo sguardo rimane sempre colmo di una profonda dignità, qualunque cosa accada, anche quando viene toccata, derisa, violata non soltanto dalle mani degli altri ma anche e soprattutto dai loro sguardi famelici, sprezzanti, curiosi, lascivi, violenti, umilianti, volgari, arroganti, avidi, gelidi. Lo sguardo di Saartjie e quello di tutti gli altri appaiono in un tessuto di primi e primissimi piani scolpiti da una cinepresa in moto perpetuo, che mostra come lo sguardo umano sia uno sguardo di ferocia.