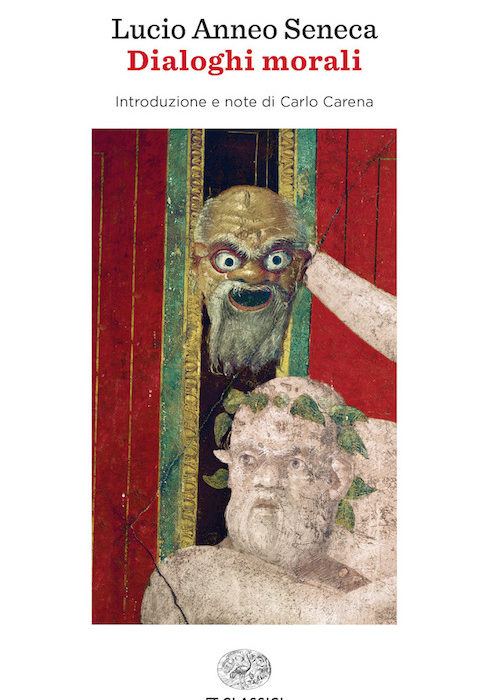Monaco di Baviera è un’ubriacatura. Di birra, di Grecia, di biciclette, di musicisti, di buonumore, di spazio, di chiese. Nata come snodo mercantile, soprattutto per il commercio del sale, le maggiori strade della Altenstadt conservano il carattere e la vivacità di un luogo di scambi. Nell’Ottocento i sovrani bavaresi, specialmente Ludwig I, ne vollero fare una sorta di Atene teutonica. E ci riuscirono. Lo testimonia la magnifica Königsplatz che raccoglie gli uni accanto agli altri i Propilei al centro e di lato la Glyptothek, (purtroppo in questo periodo e ancora per un bel po’ di tempo chiusa per restauri) e la Staatliche Antikensammlung, vale a dire uno dei più straordinari musei archeologici che abbia visitato. Di queste antichità monacensi parlerò prossimamente più in dettaglio. Cerco intanto di descrivere la ricchezza degli altri musei posti a poca distanza da questi.
Nella Alte Pinakhotek (Pinacoteca d’arte antica) c’è la maggiore concentrazione di capolavori che abbia mai visti raccolti in un sol luogo. Vi è rappresentata tutta la storia della pittura europea da Giotto al Settecento, con i maggiori esponenti di ogni nazione, tradizione, tendenza. Inutile fare dei nomi, ci sono tutti. Solo qualche opera, a mo’ di esempio.
Una versione meno nota dell’Annunciata di Antonello da Messina; una Vanitas di Salvator Rosa (1650); un autoritratto di Rembrandt del 1629; Wallfahrer bei einer Stadt (Pellegrini) di Sebastian Vrancx e Das Schlaraffenland (Terra di latte e miele) di Pieter Bruegel; i Giudizi universali di Rubens che nella spietata caduta dei dannati verso il baratro mostrano la forza di un cristianesimo senza misericordia; la Lesende Frau (Donna che legge, 1665) di Peter Janssens Elinga, nel quale la donna fa splendere un riflesso di luce nella stanza, il raggio della sapienza; una Stilleben mit Porzellankanne (Natura morta con porcellane, 1653; qui a destra) di Willem Kalf dentro cui la porcellana si confonde con la frutta, l’organico e l’inorganico si fondono nella semplice bellezza della materia; un piccolo, splendido dipinto di Jan Porcellis (Sürmische See, lago di Sürmisch, 1629) incornicia se stesso in una dissoluzione che sente Turner; una Spoliazione del Greco nella quale la geometria vibrante e dissolta del Cristo diventa
(1650); un autoritratto di Rembrandt del 1629; Wallfahrer bei einer Stadt (Pellegrini) di Sebastian Vrancx e Das Schlaraffenland (Terra di latte e miele) di Pieter Bruegel; i Giudizi universali di Rubens che nella spietata caduta dei dannati verso il baratro mostrano la forza di un cristianesimo senza misericordia; la Lesende Frau (Donna che legge, 1665) di Peter Janssens Elinga, nel quale la donna fa splendere un riflesso di luce nella stanza, il raggio della sapienza; una Stilleben mit Porzellankanne (Natura morta con porcellane, 1653; qui a destra) di Willem Kalf dentro cui la porcellana si confonde con la frutta, l’organico e l’inorganico si fondono nella semplice bellezza della materia; un piccolo, splendido dipinto di Jan Porcellis (Sürmische See, lago di Sürmisch, 1629) incornicia se stesso in una dissoluzione che sente Turner; una Spoliazione del Greco nella quale la geometria vibrante e dissolta del Cristo diventa  una macchia rossa dentro il grigio dell’umano; un magnifico Landschaft mit römischer Tempelruine (Paesaggio con rovine di tempio romano, 1773; qui a sinistra) di Hubert Robert; Ein Seehafen bei aufgehender Sonne (Porto al levar del Sole, 1674) di Claude Lorrain, il tramonto della storia, il tempo che imbrunisce, un’opera cosmica; nella Morte di Seneca di Rubens (1612), splende la luce della mente che sino all’ultimo detta al mondo il senso di cui esso è privo poiché di senso bisogno non ha; il Carlo V di Tiziano (1548) non è un guerriero, neppure un mercante o un prete ma un uomo che molto sa del mondo e della sua inevitabile rovina; così come l’Autoritratto di Dürer (1500) è il Cristo-artista che guarda l’esserci con lucida indifferenza, e nel suo sguardo lo condanna.
una macchia rossa dentro il grigio dell’umano; un magnifico Landschaft mit römischer Tempelruine (Paesaggio con rovine di tempio romano, 1773; qui a sinistra) di Hubert Robert; Ein Seehafen bei aufgehender Sonne (Porto al levar del Sole, 1674) di Claude Lorrain, il tramonto della storia, il tempo che imbrunisce, un’opera cosmica; nella Morte di Seneca di Rubens (1612), splende la luce della mente che sino all’ultimo detta al mondo il senso di cui esso è privo poiché di senso bisogno non ha; il Carlo V di Tiziano (1548) non è un guerriero, neppure un mercante o un prete ma un uomo che molto sa del mondo e della sua inevitabile rovina; così come l’Autoritratto di Dürer (1500) è il Cristo-artista che guarda l’esserci con lucida indifferenza, e nel suo sguardo lo condanna.
La Pinakothek der Moderne (nell’immagine in alto parte della facciata e il giardino visti dal Museo Brandhorst) costituisce un’altra antologia, stavolta dell’arte del Novecento. Anche in questo caso solo qualche nome dei moltissimi che vi sono presenti: le opere di Paul Klee nelle quali la geometria diventa flusso e pienezza; i ritmi di Lucio Fontana; la carne dissolta della Crucifixion di Bacon; L’ange du foyer di Max Ernst disegna in due creature incomprensibili la disarticolazione stessa del mondo, degno accompagnamento della Große Sterbeszene (Grande scena di morte) di Max Beckmann, nella quale la disperazione assoluta del morire emerge da colori insieme definiti e opachi, vibranti e trapassi; l’Acme Thunderer di John Chamberlain (qui a destra) è acciaio ricreato, ricomposto, ripensato, come fa la filosofia con il dolore, dandogli un ordine che si muove nel Rhein II di Andreas Gursky, fatto del flusso di tre colori.
Thunderer di John Chamberlain (qui a destra) è acciaio ricreato, ricomposto, ripensato, come fa la filosofia con il dolore, dandogli un ordine che si muove nel Rhein II di Andreas Gursky, fatto del flusso di tre colori.
E poi molto design, automobili, moto, Bauhaus.
Il Museo Brandhorst è il presente di un’arte a rischio di veloce deperimento. Vi si trovano infatti il solito, seriale, ripetitivo, del tutto integrato Andy Warhol. Con lui Basquiat e il kitsch di Koons; va meglio con Keith Haring, mentre Wolfgang Tillmans è di una banale apparenza trasgressiva; Jacquelin Humphries è espressionismo al neon; David Lachapelle è qui il fotografo non dell’alta moda ma della volgarità statunitense; interessante nel suo simbolismo un’opera di Damien Hirst che raccoglie in una vetrina più di 23.000 pillole, segno esplicito della medicalizzazione del corpo sociale. Il pezzo forte di questo museo è la raccolta delle opere di Cy Twombly, in particolare il ciclo della battaglia di Lepanto (2001: qui sotto) con il mare, i navigli, la guerra, il sangue, in dodici grandi tele  ritmate come la storia.
ritmate come la storia.
La Residenz dei Wittelsbach è una sorta di Potsdam o Versailles ma posta dentro la città. Centinaia di stanze piene di arazzi, affrescate, intarsiate, solenni. Scrivanie, tavoli, secrétaires, orologi, letti imponenti e fastosi. Dipinti dedicati alle città italiane e siciliane, ai siti archeologici dell’Isola. Stanze ricolme di porcellane cinesi e giapponesi. Migliaia di oggetti che vedono il loro trionfo prezioso e antico nella Schatzkammer, il tesoro di corte di una ricchezza assoluta, nel quale il fasto dei potenti si incarna in simboli fatti d’oro e di gemme. Un San Giorgio a cavallo del 1638-1641 (qui a destra) è tempestato di diamanti come nessun altro oggetto da me sinora visto. Ai miei amici cristiani, in particolare a coloro che ritengono il cristianesimo una speranza per i poveri della Terra, dico che il cristianesimo è stato ed è questo. E per tale ragione esiste ancora; fosse stato ‘povero’, sarebbe scomparso da secoli.
a cavallo del 1638-1641 (qui a destra) è tempestato di diamanti come nessun altro oggetto da me sinora visto. Ai miei amici cristiani, in particolare a coloro che ritengono il cristianesimo una speranza per i poveri della Terra, dico che il cristianesimo è stato ed è questo. E per tale ragione esiste ancora; fosse stato ‘povero’, sarebbe scomparso da secoli.
E invece esso esiste ancora nelle centinaia di chiese cattoliche che spuntano ovunque a München, segno orgoglioso e fatto di pietra dell’identità della Baviera rispetto al resto della Germania luterana. Anche perché cattolica, questa è una città evidentemente gaudente e gaudiosa nella quale musicisti di strada suonano ovunque, le risate sono squillanti e la disciplina stradale carente. Si sentono spesso clacson protestare se qualche altro automobilista rallenta e si vede gente che per questo si manda al diavolo in forme colorite, come se fossimo in una Catania qualunque. Da un momento all’altro, infatti, mi aspettavo di essere apostrofato con un siculo-tedesco «‘mparen».
Come tutte le belle città d’Europa, anche München è attraversata da un imponente fiume, l’Isar, dal colore verde turchese e dalla portata che varia nei diversi punti che attraversa. Oltre l’Isar, venendo dalla città antica, si apre il quartiere Haidhausen, che un tempo -quando München aveva ancora le mura– era un centro urbano a sé, poi quartiere operaio e popolare, oggi luogo abbastanza gentrificato ma dove si può osservare la vita quotidiana degli abitanti di Monaco. E lo si può fare anche dal Gasteig, un grande e dinamico centro culturale nel quale è possibile consultare libri, ascoltare concerti,  sedersi al bar, vedere film. Insomma leben, vivere.
sedersi al bar, vedere film. Insomma leben, vivere.









 (1650); un autoritratto di Rembrandt del 1629; Wallfahrer bei einer Stadt (Pellegrini) di Sebastian Vrancx e Das Schlaraffenland (Terra di latte e miele) di Pieter Bruegel; i Giudizi universali di Rubens che nella spietata caduta dei dannati verso il baratro mostrano la forza di un cristianesimo senza misericordia; la Lesende Frau (Donna che legge, 1665) di Peter Janssens Elinga, nel quale la donna fa splendere un riflesso di luce nella stanza, il raggio della sapienza; una Stilleben mit Porzellankanne (Natura morta con porcellane, 1653; qui a destra) di Willem Kalf dentro cui la porcellana si confonde con la frutta, l’organico e l’inorganico si fondono nella semplice bellezza della materia; un piccolo, splendido dipinto di Jan Porcellis (Sürmische See, lago di Sürmisch, 1629) incornicia se stesso in una dissoluzione che sente Turner; una Spoliazione del Greco nella quale la geometria vibrante e dissolta del Cristo diventa
(1650); un autoritratto di Rembrandt del 1629; Wallfahrer bei einer Stadt (Pellegrini) di Sebastian Vrancx e Das Schlaraffenland (Terra di latte e miele) di Pieter Bruegel; i Giudizi universali di Rubens che nella spietata caduta dei dannati verso il baratro mostrano la forza di un cristianesimo senza misericordia; la Lesende Frau (Donna che legge, 1665) di Peter Janssens Elinga, nel quale la donna fa splendere un riflesso di luce nella stanza, il raggio della sapienza; una Stilleben mit Porzellankanne (Natura morta con porcellane, 1653; qui a destra) di Willem Kalf dentro cui la porcellana si confonde con la frutta, l’organico e l’inorganico si fondono nella semplice bellezza della materia; un piccolo, splendido dipinto di Jan Porcellis (Sürmische See, lago di Sürmisch, 1629) incornicia se stesso in una dissoluzione che sente Turner; una Spoliazione del Greco nella quale la geometria vibrante e dissolta del Cristo diventa  una macchia rossa dentro il grigio dell’umano; un magnifico Landschaft mit römischer Tempelruine (Paesaggio con rovine di tempio romano, 1773; qui a sinistra) di Hubert Robert; Ein Seehafen bei aufgehender Sonne (Porto al levar del Sole, 1674) di Claude Lorrain, il tramonto della storia, il tempo che imbrunisce, un’opera cosmica; nella Morte di Seneca di Rubens (1612), splende la luce della mente che sino all’ultimo detta al mondo il senso di cui esso è privo poiché di senso bisogno non ha; il Carlo V di Tiziano (1548) non è un guerriero, neppure un mercante o un prete ma un uomo che molto sa del mondo e della sua inevitabile rovina; così come l’Autoritratto di Dürer (1500) è il Cristo-artista che guarda l’esserci con lucida indifferenza, e nel suo sguardo lo condanna.
una macchia rossa dentro il grigio dell’umano; un magnifico Landschaft mit römischer Tempelruine (Paesaggio con rovine di tempio romano, 1773; qui a sinistra) di Hubert Robert; Ein Seehafen bei aufgehender Sonne (Porto al levar del Sole, 1674) di Claude Lorrain, il tramonto della storia, il tempo che imbrunisce, un’opera cosmica; nella Morte di Seneca di Rubens (1612), splende la luce della mente che sino all’ultimo detta al mondo il senso di cui esso è privo poiché di senso bisogno non ha; il Carlo V di Tiziano (1548) non è un guerriero, neppure un mercante o un prete ma un uomo che molto sa del mondo e della sua inevitabile rovina; così come l’Autoritratto di Dürer (1500) è il Cristo-artista che guarda l’esserci con lucida indifferenza, e nel suo sguardo lo condanna. Thunderer di John Chamberlain (qui a destra) è acciaio ricreato, ricomposto, ripensato, come fa la filosofia con il dolore, dandogli un ordine che si muove nel Rhein II di Andreas Gursky, fatto del flusso di tre colori.
Thunderer di John Chamberlain (qui a destra) è acciaio ricreato, ricomposto, ripensato, come fa la filosofia con il dolore, dandogli un ordine che si muove nel Rhein II di Andreas Gursky, fatto del flusso di tre colori. ritmate come la storia.
ritmate come la storia. a cavallo del 1638-1641 (qui a destra) è tempestato di diamanti come nessun altro oggetto da me sinora visto. Ai miei amici cristiani, in particolare a coloro che ritengono il cristianesimo una speranza per i poveri della Terra, dico che il cristianesimo è stato ed è questo. E per tale ragione esiste ancora; fosse stato ‘povero’, sarebbe scomparso da secoli.
a cavallo del 1638-1641 (qui a destra) è tempestato di diamanti come nessun altro oggetto da me sinora visto. Ai miei amici cristiani, in particolare a coloro che ritengono il cristianesimo una speranza per i poveri della Terra, dico che il cristianesimo è stato ed è questo. E per tale ragione esiste ancora; fosse stato ‘povero’, sarebbe scomparso da secoli.
 sedersi al bar, vedere film. Insomma leben, vivere.
sedersi al bar, vedere film. Insomma leben, vivere.