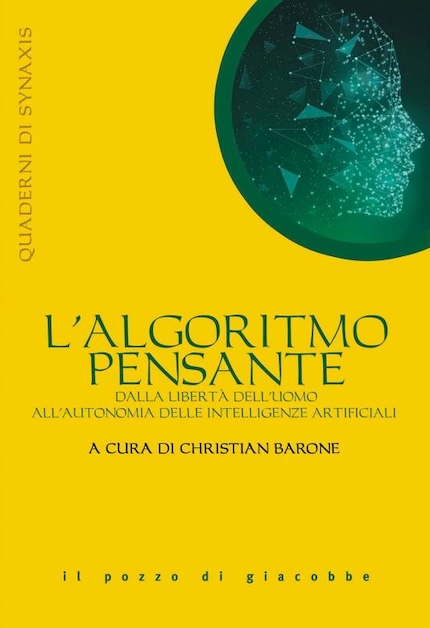
Aa. Vv.
L’algoritmo pensante
Dalla libertà dell’uomo all’autonomia delle intelligenze artificiali
a cura di Christian Barone
Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2020
«Quaderni di Synaxis»
Pagine 136
La fusione tra neuroscienze e ingegneria informatica è l’orizzonte nel quale si inscrive oggi una parte sostanziale della questione antropologica. Un’espressione centrale di tale fusione è lo statuto stesso degli algoritmi – perché sono questi che contano, il software, assai più del supporto macchinico – i quali vanno sempre più comportandosi come agenti non soltanto autonomi ma anche e soprattutto in veloce evoluzione, come se fossero dei veri e propri organismi multicellulari. È il caso di software come ChatGPT e DeepSeek o di altri programmi che, ad esempio, ‘giocano’ in borsa (e ai quali viene dunque affidato il destino di ingenti patrimoni) o di programmi che conducono operazioni militari. Tali algoritmi prendono decisioni in pochi secondi (anche meno) e in modo del tutto autonomo da interventi umani, determinando a volte delle gravi perturbazioni nei mercati finanziari e certamente la morte in guerra di molti esseri umani.
L’’intelligenza’ di questi software, soprattutto se coniugati a degli hardware, è in realtà ancora infima, «il robot più performante attualmente esistente al mondo, non può essere benché minimamente paragonato alle capacità percettive e motorie di un’ape» (Paolo Arena, p. 49) ma è certamente in costante progresso. Ai tradizionali robot tele-operati, e quindi del tutto dipendenti dalla presenza umana, si affiancano infatti dei robot assai più autonomi nelle scelte e nelle operazioni – compresi quelli installati in un numero sempre maggiore di automobili – e soprattutto i robot cognitivi, che agiscono sia a livello logico-formale, ambito nel quale sono ovviamente fortissimi, sia in quelli operativi.
Anche la forma di intelligenza che chiamiamo pura razionalità è in realtà per sua natura l’intelligenza dell’ambiente e consiste nel:
-percepire il contesto con dei sensi/sensori
-decidere quale sia il comportamento più adeguato alla situazione rilevata
-eseguire movimenti e azioni volti a raggiungere gli scopi che dalle diverse e specifiche situazioni emergono.
E pertanto non è esatto dire che «la storia della civilizzazione umana è stata segnata dalla progressiva esternalizzazione delle funzioni cognitive» (Christian Barone, 11) poiché tali funzioni sono state da sempre ‘esternalizzate’. Più esattamente: la razionalità formale ha bisogno di organismi capaci di incidere sull’ambiente e l’ambiente condiziona, plasma, modifica la razionalità formale. L’intelligenza consiste pertanto nella capacità del corpomente di abitare lo spazio, il tempo, gli istanti, le condizioni, i rischi, le possibilità.
Il fondamentale e grave limite delle prospettive che si fanno chiamare transumaniste sta nell’ignorare tutto questo o nel non tenerne conto, sta nel riproporre uno spiritualismo antico e radicale pur se in forme immerse nelle tendenze tecnologiche e antropologiche proprie del XXI secolo.
Il transumanesimo nega la corporeità sino a disprezzarla, ritenendo che l’intelligenza possa davvero consistere in una «pura informazione» che ‘liberi’ l’umano «dal fardello della carne» (Antonio Allegra, 112). Il transumanesimo nega questo corpomente che siamo, sino a ritenere che esso sia «un incidente di noi stessi, qualcosa che ci definisce non più degli abiti che scegliamo di indossare» (Id., 113). Il dualismo di tali prospettive è evidente e radicale, è la più recente espressione di «un immaginario assolutamente potente, antico e modernissimo insieme: quello che riduce l’individuo all’informazione […] Il risultato è una spiritualizzazione totale dell’identità umana. Il dualismo proposto riprende quello attivo in alcuni momenti chiave della tradizione culturale occidentale. Il punto è estremamente rilevante: il transumanesimo a questo proposito non fa altro che assumere un lascito ben preciso -ma lo riattualizza» (Id., 112).
Da tali altezze spirituali il transumanesimo torna però poi alla miseria e alla paura della vita, la vita e basta, la nuda vita: «La vita, dal punto di vista transumanista, è a ben vedere l’unica cosa che merita, o a cui si deve, davvero il segno più», una vita talmente innamorata di se stessa da non voler finire mai e dunque dal voler semplicemente divinizzarsi: «La divinizzazione non è sempre esplicita ma è con tutta evidenza il vero tema della proposta transumanista. […] Si tratta di trasformare l’uomo in Dio grazie al controllo sull’evoluzione della specie. […] Si tratta, almeno sotto questo profilo, di una narrazione teologica» (Id., 104-105). Anche per questo il transumanesimo è parte della costellazione culturale tecnognostica.
Tutto questo si crede al centro dell’essere, tanto che un umanista come Hans Jonas scrive che «la natura non poteva commettere sbaglio peggiore che creare l’uomo, creando l’uomo la natura ha distrutto se stessa» (Il principio responsabilità, Einaudi 1990, p. 177, qui a p. 34). Parole imprudenti e tracotanti; non la ‘natura’, infatti, sarebbe in pericolo ma quella infima espressione della materia che è la vita sul nostro pianeta. Per la ‘natura’, vale a dire per la materia universale, per la sua massa, la sua energia, la sua impensabile potenza, tutto quello che accade su questo pianeta è un battito di ciglia inavvertito, è il nulla.






3 commenti
Sarah
Che poi, a ben pensarci, il tentativo di rimanere in vita e di non finire non equivale all’affermazione del vivere stesso, bensì alla sua negazione dal momento che finitudine e fragilità definiscono la natura umana, che ci piaccia o no. Rifiutare o non accettare tali caratteri non significa forse rifiutare o non accettare la vita che pure si dice di desiderare, di volere e di continuare? Da questo punto di vista lo sfondo si presenta prossimo all’Antinatalismo molto più di quanto si pensa. È soltanto il modo di pensarsi e di ricollocarsi all’interno di questo sfondo comune che cambia.
agbiuso
L’ipotesi ermeneutica di una possibile convergenza tra Antinatalismo e Transumanesimo mi sembra plausibile.
Cogliere gli elementi specifici di ciascuna prospettiva, compresi quelli che rendono le due posizioni irriducibili l’una all’altra, e nello stesso tempo una possibile tendenza comune nell’indicare la miseria dell’umano e della vita, è un lavoro tutto da fare e che potrebbe aprire sentieri imprevedibili e fecondi.
Sarah
È un ipotesi che inizia a prendere forma anche grazie al dialogo proficuo e generoso con alcuni dei suoi allievi. A conferma che lo scambio può diventare uno spazio di ricchezza, di confronto e di crescita.
Un caro saluto!