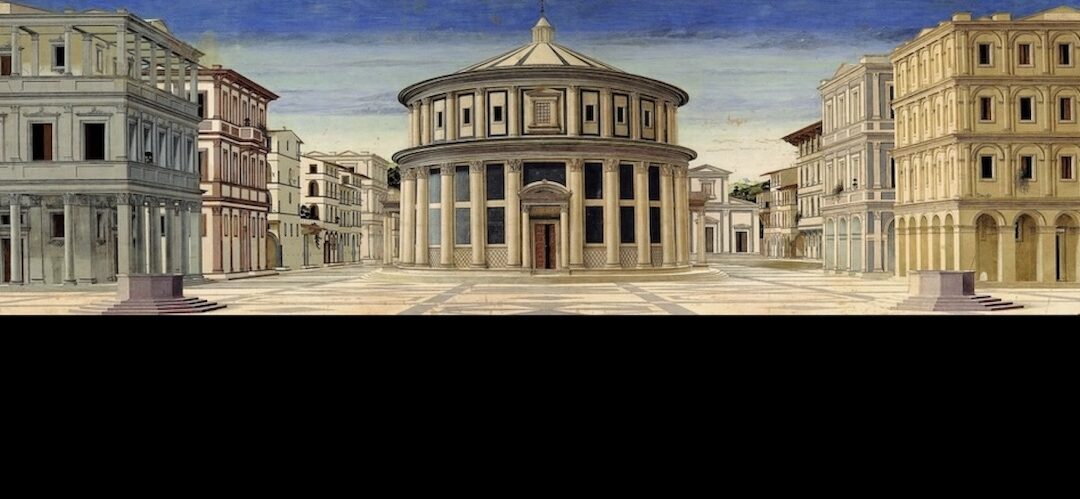
La scuola, i saperi
Aldous, 22 gennaio 2025
Pagine 1-2
Nel novembre del 2024 (esattamente il 16 e 17) si è svolto a Vicenza un convegno dal titolo Salvare i saperi per salvare la scuola. Ad aprirlo è stata Elisabetta Frezza. In un quarto d’ora Frezza è riuscita a sintetizzare con grande chiarezza (e coraggio) le radici dell’ignoranza che affligge sempre più le scuole e le università italiane e occidentali, a partire dalla colonizzazione da parte della mentalità e della pedagogia statunitense, la quale ha totalmente fallito in quel Paese ma – come diceva Elémire Zolla – gli italiani hanno un particolare talento a nutrirsi dei rifiuti altrui.
In realtà, anche a partire dalla mia esperienza di docente liceale e universitario, io credo che la scuola sia semplicemente morta. Ad apparire è un suo fantasma, destinato naturalmente presto a dissolversi nel virtuale, negli algoritmi, nel digitale. Muore perché trasformata da spazio di apprendimento in un luogo terapeutico; muore nel non chiedere alcun impegno agli studenti, titillando invece il loro narcisismo e le loro presunzioni; muore nel lasciare i ragazzi in una condizione infantile; muore nell’essere mossa da strutture e logiche aziendali e non educative; muore nella sostituzione dei professori e degli insegnanti, delle persone vive, con dei software magari dotati di interfaccia robotica. I docenti che sostengono con masochistico entusiasmo o con passiva rassegnazione queste modalità non si rendono conto di tagliare il ramo sul quale siedono. Se la lezione viva viene sostituita da un insieme di tecnologie digitali, perché non sostituire l’intero corpomente del docente con un software/robot, come accade già in altri ambiti della vita sociale? Credo che questo sia uno degli obiettivi ultimi dell’ideologia didatticista impartita in modo ossessivo e autoritario anche ai docenti che si preparano ai concorsi. Una didattica che farà a meno di loro.
La scuola è morta e l’università è moribonda e tuttavia l’integrale disincanto, necessario per vivere e per pensare tenendo conto del principio di realtà, non deve mai essere separato dalla tenacia e dalla lucidità con le quali agire nel mondo. La formula di Burckhardt e dei Greci sul pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà deve guidare ogni pensiero e ogni respiro di chi insegna.






2 commenti
Michele Del Vecchio
Carissimo Alberto, ho letto il tuo intervento sulla scuola e ho recuperato il video della presentazione del convegno di Vicenza fatta da Elisabetta Frezza. Ho ascoltato con attenzione la sua denuncia della sistematica e folle distruzione della scuola italiana e condivido quasi tutto della sua colta, coraggiosa, argomentata e disperata denuncia della inarrestabile e devastante implosione del nostro sistema scolastico. Potrei persino aggiungere qualche ulteriore disastro al lungo, e assolutamente vero, atto di accusa formulato da Elisabetta Frezza. Mi permetto qualche breve considerazione;la prima è, in realtà, una domanda: di chi è la responsabilità politica,educativa, culturale di questo colossale disastro ? La risposta non è, purtroppo, semplice e rischia di coinvolgere responsabilità molto ampie. Tuttavia senza una ricostruzione storica dei processi decisionali e di meccanismi distruttivi allestiti contro la tradscolastica scolastica precedente c’è il rischio di una vaghezza dannosa su una questione centrale. Seconda considerazione; la responsabilità di Dewey. Non sono d’accordo nel ridurre il filosofo americano ad un irresponsabile sostenitore di una scuola affidata alla egemonia di studenti svogliati che hanno soggiogato i loro maestri. Non è un profilo credibile dell’attivismo che, a mio parere, qualche merito lo ha avuto; terza considerazione: nel coraggioso e appassionato sermone di Elisabetta Frezza non c’è una sola parola sulle responsabilità dei docenti delle nostre disastrate scuole. Mi chiedo come sia stato possibile il collasso della nostra scuola senza un minimo accenno alla corresponsabilità di coloro che stavano in cattedra e, soprattutto, delle loro agguerritissime lobby sindacali. Voglio essere capito senza generare equivoci. Lo ripeto: condivido quasi totalmente il colto e appassionato discorso di Elisabetta. Ho soltanto voluto precisare che un paio di cose dette, o non dette, non mi trovano in piena sintonia.
agbiuso
Caro Michele, ti ringrazio molto per l’attenzione critica che hai voluto dedicare al mio sintetico articolo e soprattutto all’intervento di Frezza.
Per quanto riguarda Dewey, lo conosco poco per esprimere una valutazione argomentata. In generale, tuttavia, le pedagogie ‘progressiste’ del Novecento (la sua e quella di Montessori, ad esempio, così come il behaviorismo) per quanto diverse affondano tutte nell’antropologia di Rousseau, nello ‘spontaneismo’ (finto) di Emilio, nella centralità dell’allievo-studente. Io credo invece che al centro del fatto educativo non ci sia l’allievo, così come non c’è il maestro.
Il cuore del rapporto educativo è la relazione che si instaura tra le persone, non le persone. Credo che Frezza abbia voluto porre in rilievo tale elemento.
Sulla responsabilità dei docenti e delle loro organizzazioni sindacali – volte a premiare l’incompetenza e a umiliare la dimensione scientifica e culturale dell’insegnamento- sono del tutto d’accordo con te. E l’ho anche accennato: «I docenti che sostengono con masochistico entusiasmo o con passiva rassegnazione queste modalità non si rendono conto di tagliare il ramo sul quale siedono».
Strutture come la scuola e l’università non possono essere distrutte senza l’attiva partecipazione di chi ne fa parte. Un solo esempio, che è vita quotidiana: da una decina d’anni circa un po’ in tutti gli Atenei, compreso Catania, i professori hanno accettato la sistematica parcellizzazione degli esami con le cosiddette ‘prove in itinere’. Sembra che non abbiano riflettuto sul fatto che in questo modo l’unità epistemologica dei contenuti disciplinari venga dissolta, con l’impossibilità da parte degli studenti di capire e apprendere davvero ciò che studiano. In altri interventi – ad esempio qui: Lauree – ho formulato altri esempi di tradimento da parte dei docenti.
I fatti sociali sono sempre complessi e pluricausali ma ho apprezzato il modo in cui in 15 minuti Frezza ha descritto l’essenziale.